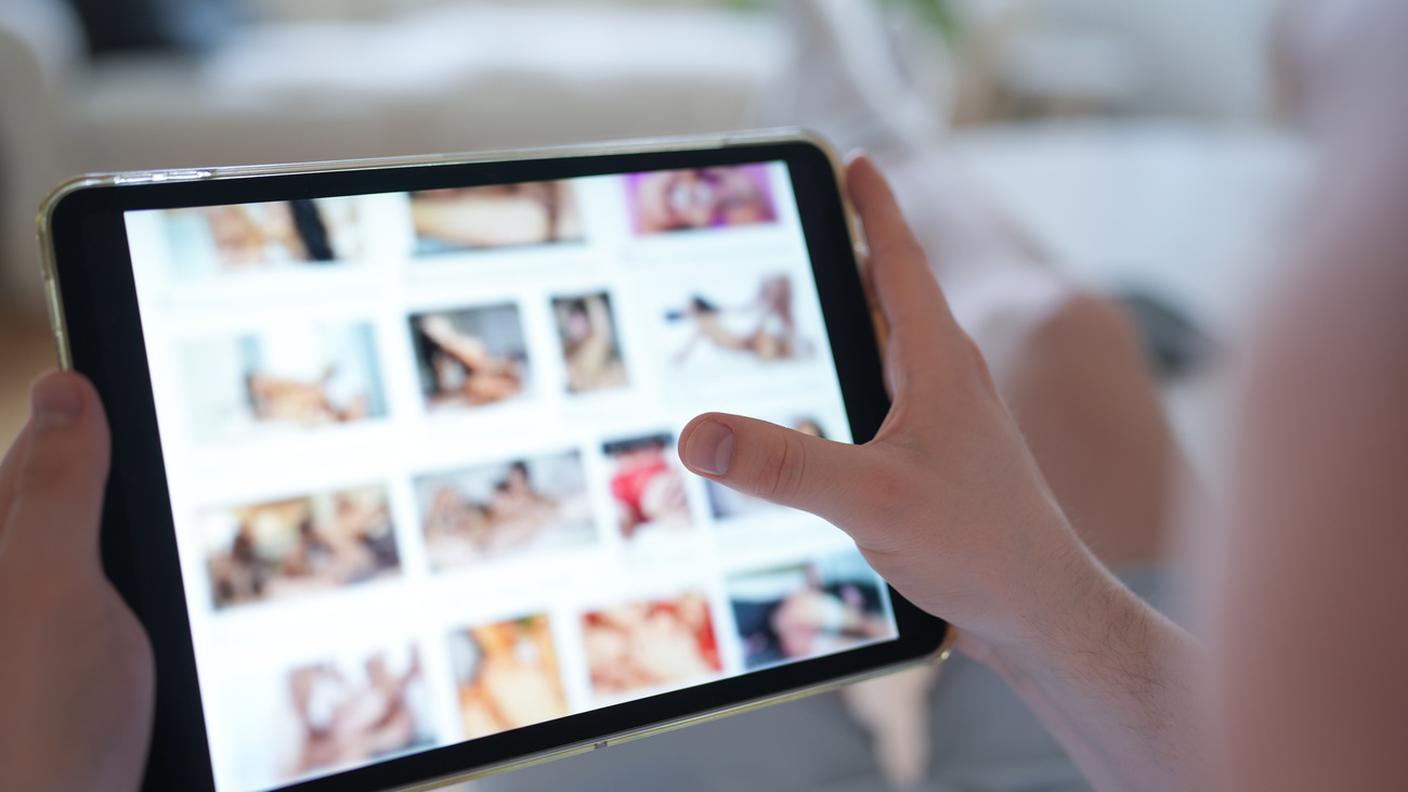“La vorrei visitare, la ammiro”. Era l’estate del 2014. Papa Francesco aveva appena concluso il suo primo viaggio apostolico in Asia, in Corea del Sud. Quando il suo aereo sorvola il territorio cinese, Bergoglio esprime per la prima volta in modo esplicito il suo desiderio: ripercorrere i passi del gesuita Matteo Ricci e diventare il primo pontefice della storia a visitare la Cina. Un sogno rimasto inespresso, per Francesco, che come mai nessun altro prima di lui ha lavorato per avvicinare la Santa Sede e Pechino. I rapporti ufficiali tra il Vaticano e il Partito comunista si sono interrotti nel 1951, quando Pechino ruppe le relazioni diplomatiche con la Santa Sede, dopo la decisione di quest’ultima di mantenere legami ufficiali con la Repubblica di Cina (Taiwan). Da allora, la Chiesa cattolica in Cina si è divisa tra una parte “ufficiale”, controllata dallo Stato, e una “sotterranea”, fedele a Roma ma non riconosciuta dal regime.
Con Papa Francesco, si è aperta una fase nuova. Nel 2018, dopo anni di trattative riservate, è stato firmato un accordo provvisorio tra il Vaticano e la Cina sulla nomina dei vescovi. Un passaggio storico, che ha suscitato reazioni contrastanti. Per alcuni, è stato un passo avanti nel riconoscimento della libertà religiosa e nella tutela dei fedeli cinesi. Per altri, una concessione troppo generosa a un governo che continua a limitare i diritti dei credenti. L’accordo è stato rinnovato già per tre volte: nel 2020 e nel 2022 su una base biennale, nell’autunno del 2024 su base quadriennale. Un apparente salto di qualità che si basa sulla fiducia costruita nel tempo tra i funzionari cinesi e quelli vaticani, in primis il segretario di Stato Pietro Parolin, fautore del disgelo.
Bergoglio ha viaggiato spessissimo in Asia: Giappone, Mongolia, Sri Lanka, ma anche tantissimi Paesi del Sud-Est asiatico. Per primo, il Papa “venuto dalla fine del mondo” ha trattato l’Asia non come la periferia del mondo cattolico ma uno dei suoi centri propulsori, in ossequio alla sua visione di mondo multipolare e pacifico, capace di rispettare anche religioni, stili di vita e modelli di sviluppo diversi dal proprio. Un approccio affine ai metodi diplomatici della Cina, che ha osservato con estremo interesse le mosse del Pontefice.
La via del silenzio
Per rafforzare il dialogo con Pechino, Bergoglio ha scelto anche la via del silenzio. In molti hanno notato le mancate critiche esplicite al governo cinese sulla repressione delle proteste di Hong Kong o sulla questione della minoranza uigura dello Xinjiang. Diversi attivisti non hanno apprezzato, così come a Taiwan hanno guardato spesso con sgomento gli abboccamenti tra la Santa Sede e Pechino. L’approccio di Francesco ha suscitato qualche divisione anche all’interno della Chiesa. Figure come il cardinale Joseph Zen, vescovo emerito di Hong Kong, hanno criticato duramente l’accordo con Pechino, definendolo “un tradimento” dei cattolici fedeli a Roma. Ma il Papa ha scelto un’altra strada: non lo scontro aperto, ma un cammino lento, fatto di piccoli gesti e continui tentativi di apertura. Bergoglio era convinto che la Cina fosse il destinatario principale della sua logica diplomatica del “seminare”, votata alla “costruzione paziente di fiducia” per il perseguimento di obiettivi a lungo termine.
Obiettivi che ora potrebbe perseguire il suo successore. O almeno così spera Pechino, che mantiene una posizione di cauta apertura. Sì al rafforzamento del dialogo, attenzione a svolte definitive come l’apertura di rapporti diplomatici ufficiali o al via libera (mai arrivato a Bergoglio) per la visita di una delle poche autorità al mondo che (essendo spirituale) potrebbe non essere semplice porre chiaramente al di sotto di quella del Partito.

TG Speciale: Morte di Papa Francesco
Telegiornale 21.04.2025, 16:16
Dieci anni con Francesco: l'intervista al Papa
Informazione 12.03.2023, 20:40