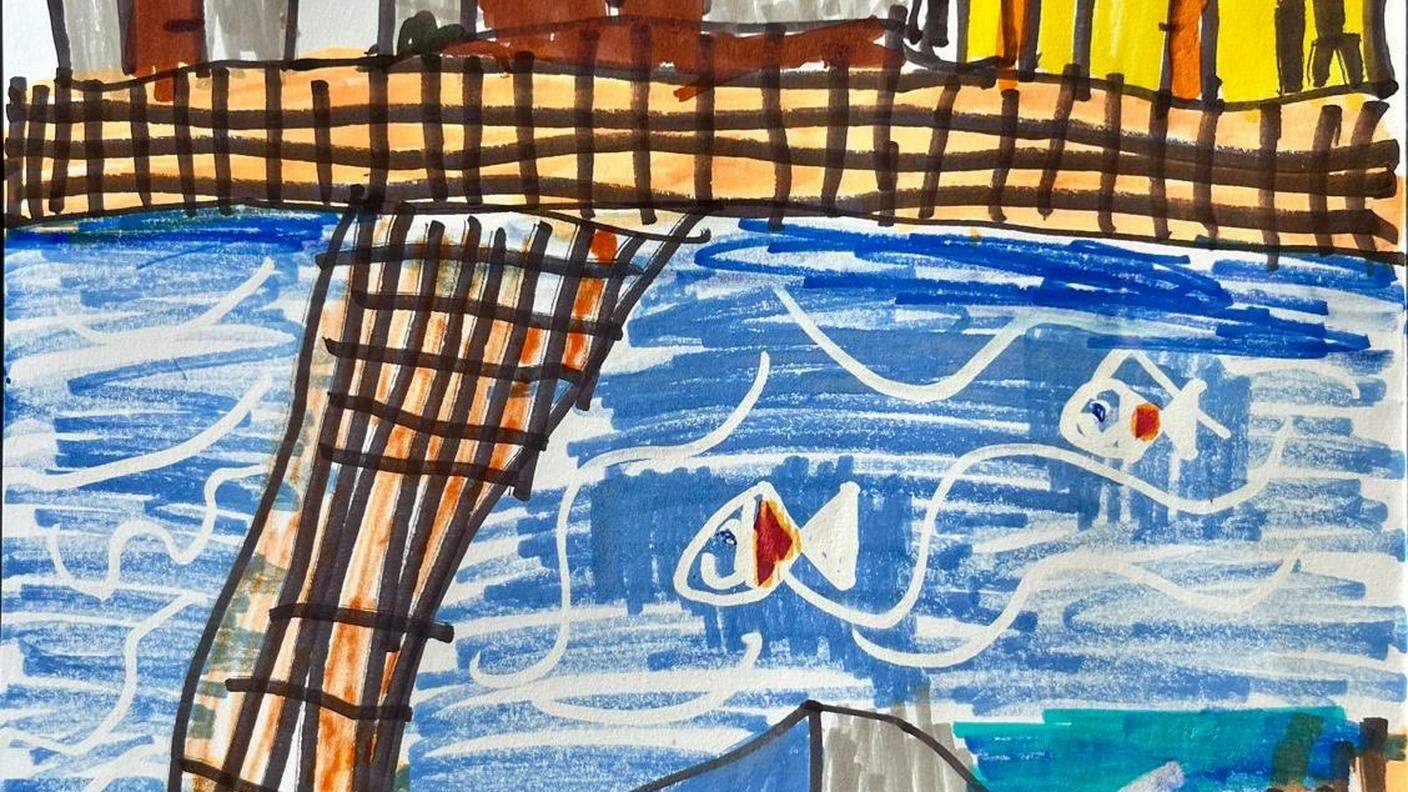Quando Roma non aveva ancora esteso il suo dominio sul Mediterraneo, erano i Cartaginesi i padroni del Grande Mare, o meglio: della sua parte occidentale. Nel V e IV secolo avanti Cristo, con le loro navi da trasporto e da guerra, controllavano gran parte delle rotte dal Nord Africa alla Penisola Iberica, dal Nord Africa alla Sicilia, dalla Sardegna alle coste Tirreniche e alla Magna Grecia. Non trasportavano solo le proprie merci, ma tutte quelle dei popoli che riuscivano a raggiungere.
I loro commerci erano così fiorenti, che potevano pagare eserciti mercenari per fare la guerra al posto loro. Spesso, solo i comandanti erano Cartaginesi. Annibale, ad esempio: nel 218 a.C. valicò le Alpi con i suoi elefanti per attaccare Roma alle spalle. Ma a quel punto la potenza cartaginese era già in declino. Roma – per contrastare la città rivale – aveva costruito una propria flotta che arrivò ad essere più potente e temibile di quella punica. E portò la guerra in Africa, dove i Cartaginesi, fino a quel momento, avevano prosperato in una relativa pace. Roma non poteva più convivere con Cartagine: voleva annientarla. E la distrusse, nel 146 a.C., per poi rifondarla come città romana. Oggi di Cartagine ci restano grandiose rovine, ormai quasi inglobate dai sobborghi di Tunisi. La sua storia ci dice che i Cartaginesi non erano affatto “barbari”, ma avevano una cultura ricca e originale. Il Mondo Classico, insomma, non fu solo frutto della cultura Greco-Romana, ma fu il risultato di molteplici rapporti e scambi fra popoli e culture differenti. Ne parliamo con il Professor Giovanni Brizzi, Ordinario di Storia Romana all'Università di Bologna.
Michela Sechi