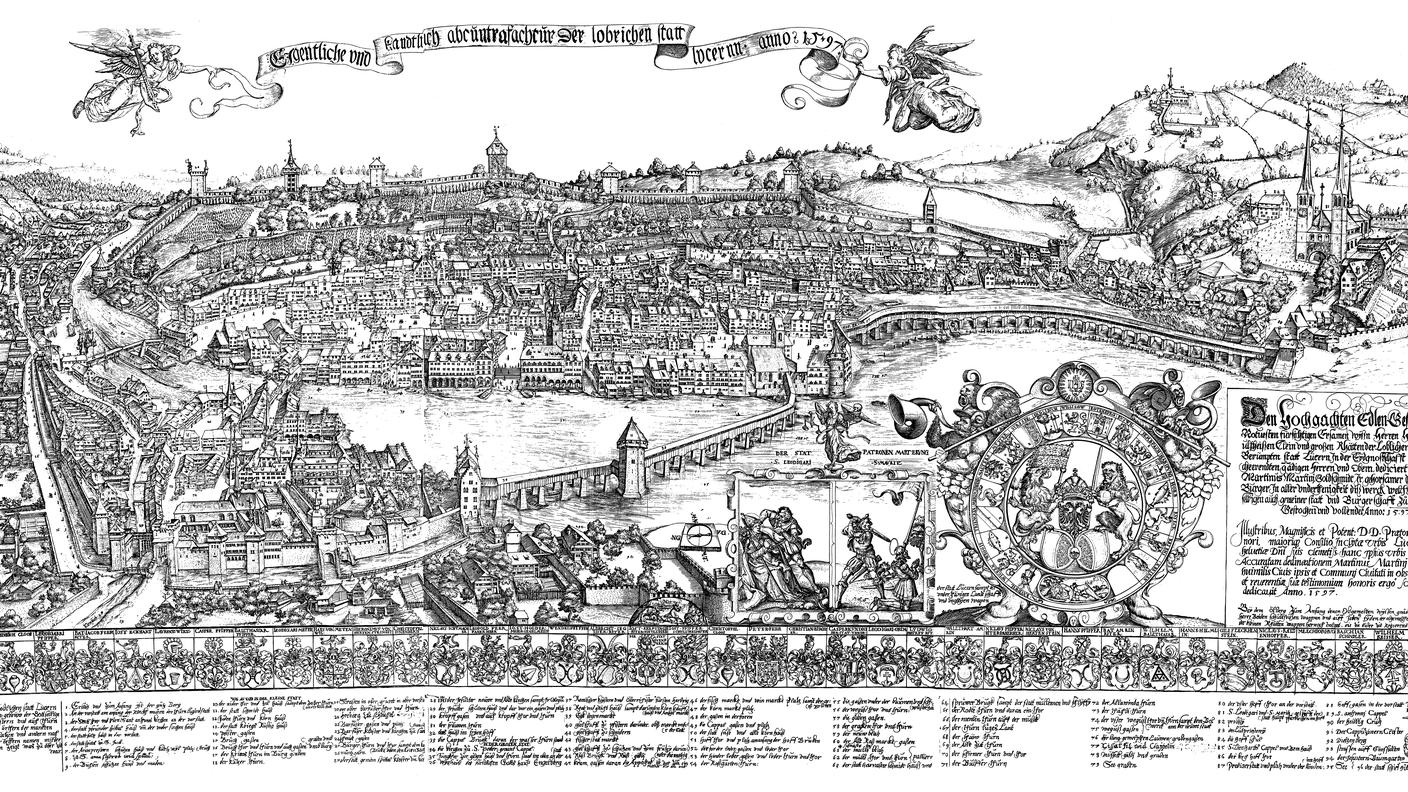La percezione dello scollamento tra realtà e rappresentazione – l’impossibile ricerca del “fiore azzurro”, secondo le celebri parole di Novalis, oppure l’“indecenza dei segni”, come la definì Hugo von Hofmannsthal, uno grandi interpreti della straordinaria stagione culturale che accompagnò il crollo della Monarchia asburgica – ha trovato una delle massime espressioni nella psicanalisi di Freud, che poteva fiorire solo nella Vienna di quegli anni, giustamente definita da Karl Kraus «stazione meteorologica della fine del mondo». I letterati viennesi, nei primi decenni del secolo scorso, erano tutti direttamente o indirettamente freudiani, perché le teorie psicanalitiche facevano quasi parte della composizione chimica dell’atmosfera. Le si respirava ovunque, venivano assorbite e poi rimodellate nelle opere narrative e teatrali, ma anche nei testi saggistici e nelle biografie storiche, come nel caso di Stefan Zweig.
https://rsi.cue.rsi.ch/cultura/letteratura/Morire--1208497.html
Il più freudiano dei freudiani, per certi versi addirittura più freudiano di Freud, perché più gelido, impietoso, quasi disumano, capace di restituire le intuizioni della psicanalisi in altissime figurazioni artistiche, rendendole terribilmente concrete, è stato con ogni evidenza Arthur Schnitzler. Non stupisce quindi che nel 1922, in occasione del suo sessantesimo compleanno, l’altrimenti riservatissimo Freud gli abbia scritto una lettera di sincere felicitazioni, riconoscendo nel grande scrittore una specie di fratello, o perfino un doppio, un sosia: «Il suo determinismo, il suo scetticismo, il suo essere dominato dalle verità dell’inconscio, dalla natura istintuale dell’uomo, il suo demolire le certezze culturali convenzionali, l’aderire del suo pensiero alla polarità di amore e morte, tutto questo mi ha colpito con un’insolita e inquietante familiarità. Credo che nell’intimo del suo essere lei sia un ricercatore della psicologia del profondo, così sinceramente obiettivo e impavido come nessuno prima di lei. Ho avuto l’impressione che lei, attraverso l’intuizione, sapesse tutto ciò che io ho scoperto con un faticoso lavoro sugli uomini».
Freud si riferiva in particolare a Il dottor Gräsler, medico termale, uscito cinque anni prima, che insieme al sulfureo Doppio sogno rimane indiscutibilmente il suo racconto più psicanalitico, ma le parole e il giudizio del padre della psicanalisi sono molto utili anche per inquadrare il breve racconto Geronimo il cieco e suo fratello, scritto in pochi giorni nell’ottobre del 1900. Paragonato alle grandi opere della maturità, lo si potrebbe considerare un episodio minore o comunque interlocutorio all’interno della vasta produzione di Schnitzler, e invece si tratta di un fondamentale punto di snodo, perché è il primo testo narrativo nel quale compaiono temi, suggestioni e riferimenti di chiara matrice psicanalitica.
C’è poi un altro aspetto interessante e perfino sorprendente, almeno fino a un certo punto. Geronimo il cieco e suo fratello costituisce un’eccezione all’interno della narrativa di Schnitzler, dal momento che la vicenda, anziché a Vienna, è ambientata nelle zone dell’Alta Valtellina, principalmente lungo la strada che porta allo Stelvio e nella zona di confine col Canton Grigioni, il cui paesaggio viene descritto in maniera indiretta ma con forti tratti evocativi. E’ sorprendente l’ambientazione, ma non la scelta, perché Schnitzler conosceva piuttosto bene le zone di confine tra i Grigioni, la Valtellina e il Tirolo, che all’epoca costituivano i luoghi di villeggiatura prediletti della borghesia viennese. Il già ricordato Zweig, ad esempio, ha ambientato nei Grigioni alcuni racconti e molti capitoli del romanzo Estasi di libertà.
Nel racconto di Schnitzler ci sono quindi parecchie descrizioni dettagliate del paesaggio e degli ambienti, col «vento umido e freddo» che soffia «sul terreno infangato» lungo le strade e la presenza di alcune locande poco ospitali, che non «non invitano a una sosta prolungata perché prive di una vista panoramica, tra le alture spoglie». Ma ci sono anche descrizioni che mettono in risalto particolari di segno differente, come le nebbie del fondovalle che si assottigliano e vengono squarciate e infine dissolte dai raggi del sole, il mattino che si trasforma in «un bagno di luce» e le pendici dei monti che assumono un aspetto leggiadro e invitante, mentre da lontano risuona «il rumore dei primi carri».
E’ questa la cornice – prevalentemente idilliaca – al cui interno Schnitzler costruisce in poche pagine un racconto pressoché perfetto, che in termini psicanalitici porta alla luce quello che Freud aveva definito l’elemento “perturbante” (unheimlich), costituito dalla sensazione di angoscia e paura al cospetto dell’estraneità di ciò che appare noto e familiare. Lungo la strada che porta allo Stelvio, due fratelli vivono mendicando: Geronimo, il più giovane, è stato accecato durante un gioco d’infanzia dal maggiore, Carlo, che da allora gli ha dedicato la vita in un impossibile tentativo di riparazione. Geronimo suona la chitarra e canta, mentre Carlo raccoglie nel cappello le monete che i viaggiatori vi lasciano cadere. Il “perturbante” è rappresentato dalla comparsa di un giovane signore, che una sera dice al cieco: «Non lasciarti ingannare. Ho dato al tuo compagno una moneta da venti franchi».
La moneta, in realtà, è da un franco, ma la menzogna insinua il dubbio e il sospetto tra i due fratelli. Carlo capisce che Geronimo inconsciamente diffida da sempre di lui, e in nome dell’amore fraterno ruba una moneta da venti franchi e gliela regala come forma di risarcimento, sottraendolo all’incantesimo della cecità simbolica: «Ora aveva di nuovo un fratello… No, ora aveva per la prima volta un fratello», dicono le righe conclusive. Tuttavia, come sempre in Schnitzler, non si tratta del classico lieto fine: i due fratelli, che sono diventati veramente due ladri, vengono scoperti e arrestati.
La simbologia è evidente: il giovane signore, lo sconosciuto, il “perturbante” obbliga a fare i conti con il male e la fragilità. Il dubbio e il sospetto scatenano le pulsioni più basse, aprendo l’orizzonte sulla solitudine, l’incomunicabilità, il rimosso, i miasmi e le bassezze dell’anima. Geronimo il cieco e suo fratello è ben più di un semplice esercizio di stile: il viaggio di Schnitzler negli abissi della psiche e nel cuore di tenebra dell’esistenza è partito dalle zone di confine tra Grigioni, Valtellina, Stelvio e Tirolo. La Valtellina e le zone contigue hanno fatto da sfondo anche a uno spericolato esperimento storico-filosofico, se così lo si può definire. Molto spesso, infatti, quelle che Stendhal aveva definito la petite histoire e la grande Histoire – la concreta esistenza di ogni essere umano e le più importanti e decisive occorrenze della grande Storia – sono fatte di domande estremamente complicate. La più ovvia, ma anche la più difficile, è la domanda: «Cosa sarebbe successo se…?». Come rispondere? Ma soprattutto: è possibile rispondere? C’è chi ha tentato di farlo, scegliendo uno scenario genialmente differito in una sorta di passato distopico.
Uno dei più originali, coraggiosi e innovativi scrittori italiani del secondo Novecento, Guido Morselli, che come spesso accade ai grandissimi (e Morselli – lo si è capito troppo tardi – è stato un grandissimo) venne scoperto soltanto dopo la morte, ha infatti tentato di riscrivere addirittura la grande Histoire in un romanzo che si intitola Contro-passato prossimo – Un’ipotesi retrospettiva ed è parzialmente ambientato in Valtellina. Ma non è soltanto una questione di ambientazione: la Valtellina, più che un semplice scenario, è in realtà l’autentico punto di snodo, dove passa la grande Storia e le vicende prendono (avrebbero potuto prendere?) una piega diversa da quella che hanno effettivamente preso. Le pagine valtellinesi del romanzo hanno quindi una funzione dirimente. «Cosa sarebbe successo se…?»: anche Morselli parte da questa domanda, declinandola in una serie di interrogativi davvero sostanziali. E se la Prima guerra mondiale fosse stata vinta dalle potenze degli Imperi Centrali? Ci sarebbe poi stato il nazismo? Ci sarebbe stata la Seconda guerra mondiale con la conseguente fine della vecchia Europa?
https://rsi.cue.rsi.ch/cultura/letteratura/Morselli-muore-due-volte--1805824.html
Oppure il povero e martoriato vecchio continente, dopo secoli di sanguinose battaglie, sotto la guida tedesca e la “Comunità Europea Democratica” del ministro Walther Rathenau (in realtà, una forma di improbabile dispotismo illuminato, senza contare che lo stesso Rathenau venne assassinato nel 1922, a Berlino, da un gruppo di terroristi di estrema destra), avrebbe conosciuto un lungo periodo di pace e floridità? Per giungere a una simile conclusione, Morselli ipotizza un’ingegnosa operazione militare, la cosiddetta Edelweiss Expedition, in virtù della quale gli austriaci, scavando un tunnel tra il Tirolo e la Valtellina, conquistano nel giro di poche ore l’Italia settentrionale, prendendo alle spalle le truppe italiane dislocate sul fronte orientale, e nello stesso tempo si dirigono verso ovest, in direzione della Francia e dell’Inghilterra, anche in questo caso prendendo alle spalle gli eserciti che si attendono un eventuale attacco da est. È davvero difficile pensare a un utilizzo più fantasioso di quella che Max Frisch ha definito “drammaturgia della casualità”.
Non c’è mai stata una Edelweiss Expedition come l’ha descritta Morselli, la Prima guerra mondiale si è conclusa con la rovinosa sconfitta della Germania e la fine della Monarchia asburgica. E’ inoltre lecito dubitare che un’Europa a guida tedesca avrebbe conosciuto un lungo periodo di pace e floridità. Ma l’interrogativo che Morselli ci ha lasciato con questo romanzo è in realtà un altro, ancora più abissale e inquietante. E’ lo stesso Morselli a porlo, pressappoco a metà del libro, in un fittizio dialogo tra l’autore e l’editore: nella vita è tutto ipotetico, anche il passato, anche la Storia intesa etimologicamente come “ricerca” dei fatti. Di conseguenza, «il paradosso sta dalla parte dell’accaduto: dall’altra parte se ne sta, sconfitta, quella che chiamiamo (quantunque con ottimismo) “logica delle cose”».
È un ottimismo inevitabile ma anche nocivo, sostiene Morselli, perché «troppo spesso ha impedito e impedisce di vedere come la Storia di fatto avviene». Ecco perché Contro-passato prossimo, con le sue pagine valtellinesi, merita oggi più che mai una lettura attenta e meditata: perché è molto più di una “ipotesi retrospettiva”, perché si avvicina a una verità talmente vera, nella sua vertiginosa evidenza, da essere tanto negletta quanto inconfessabile. Ma si può andare anche oltre: quella che in Morselli è più che altro una divertente e divertita forzatura, nel caso di Thomas Bernhard diventa una voluta quanto sorvegliatissima e urticante esagerazione.
La cosiddetta “arte dell’esagerazione” è infatti presente, come trave portante e filo conduttore, in tutta la sua produzione narrativa. Bernhard ha sviluppato un simile procedimento anche sul palcoscenico, portandolo anzi alle estreme conseguenze, perché il testo teatrale permette una maggiore commistione dei generi, stemperando la tragedia in commedia e caricando la commedia di significati che la trasformano in tragedia. Ci sono tuttavia, se così li si può definire, alcuni punti di osmosi o di massimo incontro/scontro tra narrativa e teatro e tra commedia e tragedia: un lungo racconto intitolato Camminare, scritto nel 1970 e pubblicato l’anno successivo, e più ancora un trittico narrativo pubblicato anch’esso nel 1971 col titolo Midland in Stilfs (“Midland a Stilfs”, dal titolo del primo racconto), che segna il momento di cesura – non a caso coincidente col suo esordio come drammaturgo – tra la produzione giovanile di Bernhard e le opere della maturità. Gli altri due racconti, che completano il trittico, si intitolano Il mantello di loden e Sull’Ortles – Notizie da Gomagoi.
https://rsi.cue.rsi.ch/cultura/letteratura/Thomas-Bernhard--1780956.html
A differenza di molti scrittori nati e vissuti nella zona dell’arco alpino, Bernhard ha sempre visto nella montagna il luogo per eccellenza della chiusura, della claustrofobia, di una vita priva di sbocchi e destinata a risolversi nella più cupa disperazione, perfino nel suicidio. A questa ferrea regola non si sottrae nemmeno l’immagine della montagna che si profila dai tre racconti contenuti in Midland a Stilfs, la cui cornice è rappresentata dalle valli del Tirolo e dalla regione dello Stelvio, nella zona di confine tra Trentino e Valtellina. È stato lo stesso Bernhard, del resto, a fornire una perfetta chiave di lettura di questo trittico della montagna: «Nel mio lavoro, quando qua e là si formano i primi segni di una storia, o quando in lontananza vedo spuntare da dietro una collina di prosa l’accenno a una storia, gli sparo addosso».
Non c’è quindi nessun idillio, non c’è redenzione, non ci sono salvezza e vie d’uscita, perché la montagna è la Madre o Matrigna che «regna sovrana come natura assoluta» e impone la propria legge di tenebra. In quel di Stilfs/Stelvio, luogo di brevissimi soggiorni del villeggiante inglese Midland, gli abitanti sono immersi in un «inferno di solitudine», in «un martirio di alta montagna» dove tutto «è perdita di tempo e quindi infelicità», e hanno la terribile certezza di vivere non già «nel luogo più ideale», ma anzi di scontare in un simile luogo una «immane punizione». Dice a un certo punto l’io narrante: «Per noi Stilfs non è un luogo ideale, bensì micidiale. La nostra esistenza è un’esistenza micidiale. Stilfs è la fine della vita».
Quanto ai Grigioni, Bernhard li utilizzerà come bersaglio circa un decennio dopo, nel romanzo Il soccombente, ma soprattutto in questo caso bisogna tenere presente che il principio poetico dell’esagerazione va sempre relativizzato, e di conseguenza vanno relativizzati anche i celebri o famigerati giudizi relativi alla città di Coira e i villaggi dei dintorni, in particolare Zizers (una «perversa creazione verbale»), dove il personaggio di Wertheimer si suicida impiccandosi a un albero. Lo stesso discorso vale per il giudizio, forse meno conosciuto, a proposito dell’arte culinaria nella Svizzera tedesca: «Il cibo che viene servito nella cosiddetta Svizzera tedesca è un attentato rivolto non solo al corpo, ma anche e soprattutto allo spirito».
La Valtellina, il Tirolo e non da ultimo i Grigioni de Il soccombente non sono l’oggetto di un odio particolare, ma piuttosto alcune delle tante metafore utilizzate da Bernhard per svelare la verità sul cuore di tenebra dell’animo umano: una verità che coinvolge le istituzioni, la politica, la vita sociale, le ombre del passato (soprattutto nell’odiatissima Austria) e infine i paesaggi e le città. C’è quindi una sorta di percorso a ritroso che parte dall’insulto, passa attraverso il paradosso, la forzatura e l’esagerazione per approdare alla metafora o allo spicco simbolico.
Anche in Bernhard, come in Geronimo il cieco e suo fratello di Schnitzler, tutto rimanda a qualcosa di estraneo, infido e perturbante, la realtà viene rimodellata come in Contro-passato prossimo di Morselli. Ma con una sostanziale differenza: le coordinate tradizionali vengono cancellate ma non riscritte, di modo che non esistono più né l’inconscio, né il gioco storico-filosofico sul possibile svolgimento della Storia. Zizers, Coira, lo Stelvio e le valli del Tirolo, non meno di Vienna, Salisburgo e altri luoghi dell’universo concentrazionario di Bernhard, sono altrettante metafore del grado zero dell’umano e dello stato brado dell’essere, prima di ogni ipocrisia civile e di ogni finzione “culturale”.
L’arte dell’esagerazione, come un continuo accordo in maggiore, li travolge insieme a tutto il resto e si innalza al rango di uno sproloquio definitivo che dice tutta l’insensatezza del vivere, l’irredimibile rogna della realtà e la tragicomica inutilità di ogni tentativo di comprendere il mondo. L’indecenza dei segni è irredimibile, lo scollamento tra realtà è rappresentazione è totale, il “perturbante” non è un aspetto della vita, ma la vita stessa: il cerchio aperto da Schnitzler si chiude con Thomas Bernhard. Come dice il primo dei suoi grandi personaggi, il pittore Strauch di Gelo, in un monologo che segna l’inizio di una lunga e consequenziale discesa nei normalissimi abissi dell’orrore: «Non avere pietà, ma limitarsi a lasciar lavorare la repulsione e lasciarle raggiungere il suo scopo, questo in molti casi è un vanto assoluto della ragione».