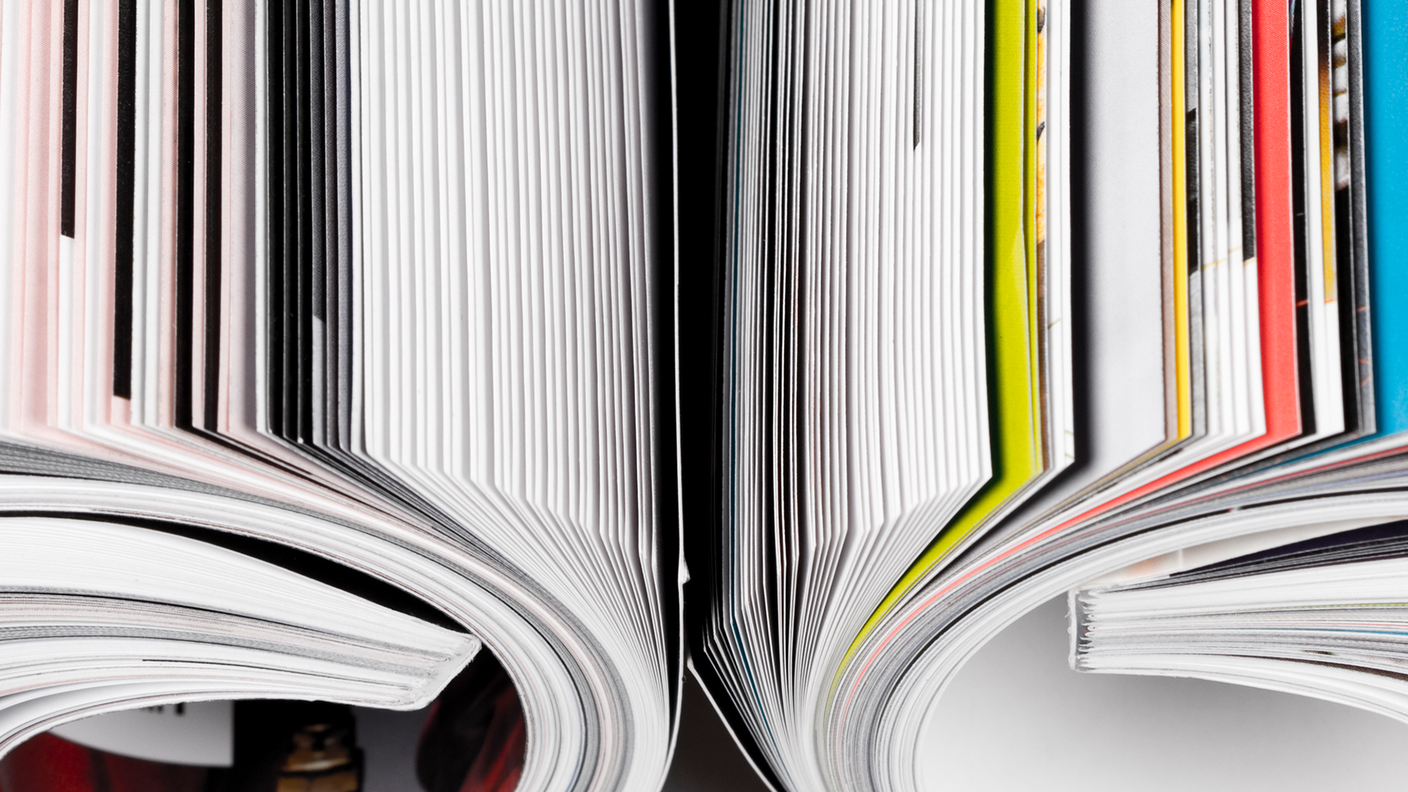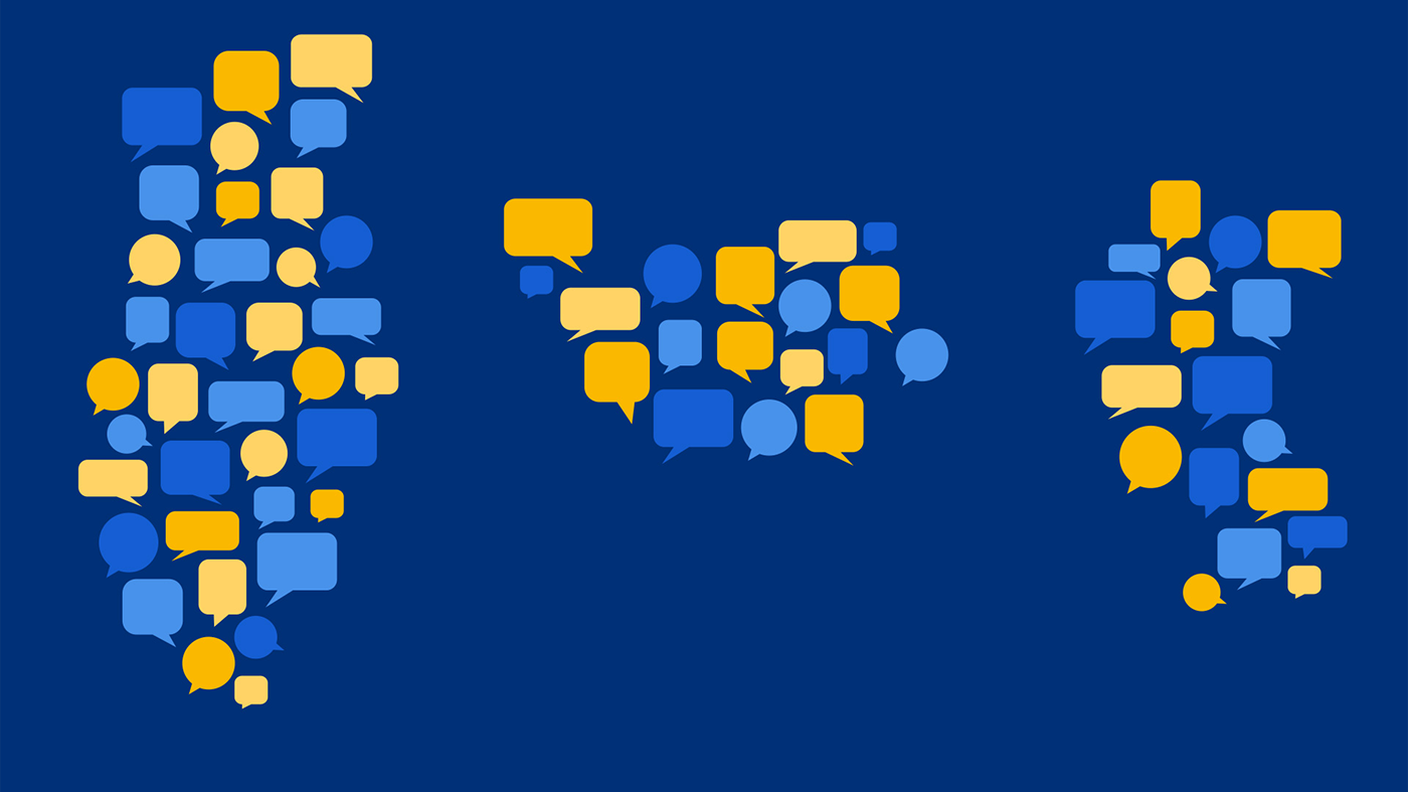L’impegno per una riflessione non superficiale sul tema dell’altro, dei suoi molteplici significati fra letteratura e antropologia, richiede di conoscere almeno quali autori di primaria importanza l’abbiano trattato nell’arco del Novecento. Dal fondamentale “Stranieri a noi stessi” di Julia Kristeva (Feltrinelli, 1990) a “Lo straniero ovvero l’identità culturale a confronto” di Maurizio Bettini (Laterza, 1992); da “Noi e gli altri” di Cvetan Todorov (Einaudi, 1993) a “L’altro che è in noi” di Francesco Orlando; senza dimenticare due capolavori della letteratura: “Lo sconosciuto” di Katherine Mansfield (1920, trad. italiana in Tutti i racconti, Adelphi 1994) e “Lo straniero” di Albert Camus (1942, trad. italiana Bompiani 1994). Scorrendo questi volumi e anche considerando solo l’accezione di straniero, insita nel termine l’altro, si scopre una ricca griglia di significati: forestiero, strano, estraneo, sconosciuto. E così via. Fra i molteplici ambiti disciplinari in cui questo concetto può essere affrontato, il Laser odierno, curato da Antonio Ria, privilegia l’ambito letterario ed etno-antropologico. Con due testimoni d’eccezione: Remo Ceserani e Marc Augé. Remo Ceserani, già docente di Letterature comparate all’Università di Bologna e conosciuto per il fortunato manuale di letteratura “Il materiale e l’immaginario” che ha scritto con Lidia De Federicis, è co-curatore del “Dizionario dei temi letterari”. Fra le tante sue pubblicazioni, al tema dell’alterità nella letteratura ha dedicato il libro “Lo straniero”, edito da Laterza nel 1998. In trasmissione ripercorre i momenti salienti della forte presenza dell’alterità nella letteratura, fin dall’antichità più remota. Ricordando Mosè per il popolo ebraico e Oreste per quello greco, Ceserani sottolinea il fatto che l’altro, lo straniero, è sempre stato uno tra i più inquietanti e significativi personaggi di opere letterarie. E cita alcuni esempi, più artisticamente riusciti: da Boccaccio a Hoffmann, da Baudelaire a Pirandello, tracciando una speciale antropologia letteraria sul tema dell’alterità. Ed è il famoso etnologo francese Marc Augé, figura di riferimento per un’antropologia della tarda modernità, ad approfondire in trasmissione il senso dell’altro, dell’alterità nell’etnologia. Un tema molto presente nella ricerca di Marc Augé. Basti pensare al volume “Il senso degli altri. Attualità dell’antropologia” (Bollati Boringhieri, 2000) e alla sua autobiografia, pubblicata di recente sempre con Bollati Boringhieri col titolo “Straniero a me stesso”. E non va dimenticato che a prender la parola in trasmissione è un etnologo che, per mestiere, coltiva con il proprio io un rapporto di “relativa estraneità”, ponendosi a metà strada tra se stesso e gli altri. Anche in riferimento all’idea del luogo, lui, l’inventore dei “nonluoghi”, si identifica “con lo sradicamento, col non essere mai al proprio posto”. Un’esperienza di “alterità”, di “straniamento”, di “continuo esercizio di migrazione”: da confrontare con la continua ricerca dell’identità” che, dialetticamente, la ricerca dell’alterità” comporta. Un’esperienza intellettuale e antropologica di non poca rilevanza, quindi. Dall’estraneità alla ricerca della propria identità; dall’identificazione dello “straniero”, all’essere “straniero a se stessi”, per poi capire ed “accogliere”, con più umanità ed intelligenza, l’altro, e quindi se stesso.
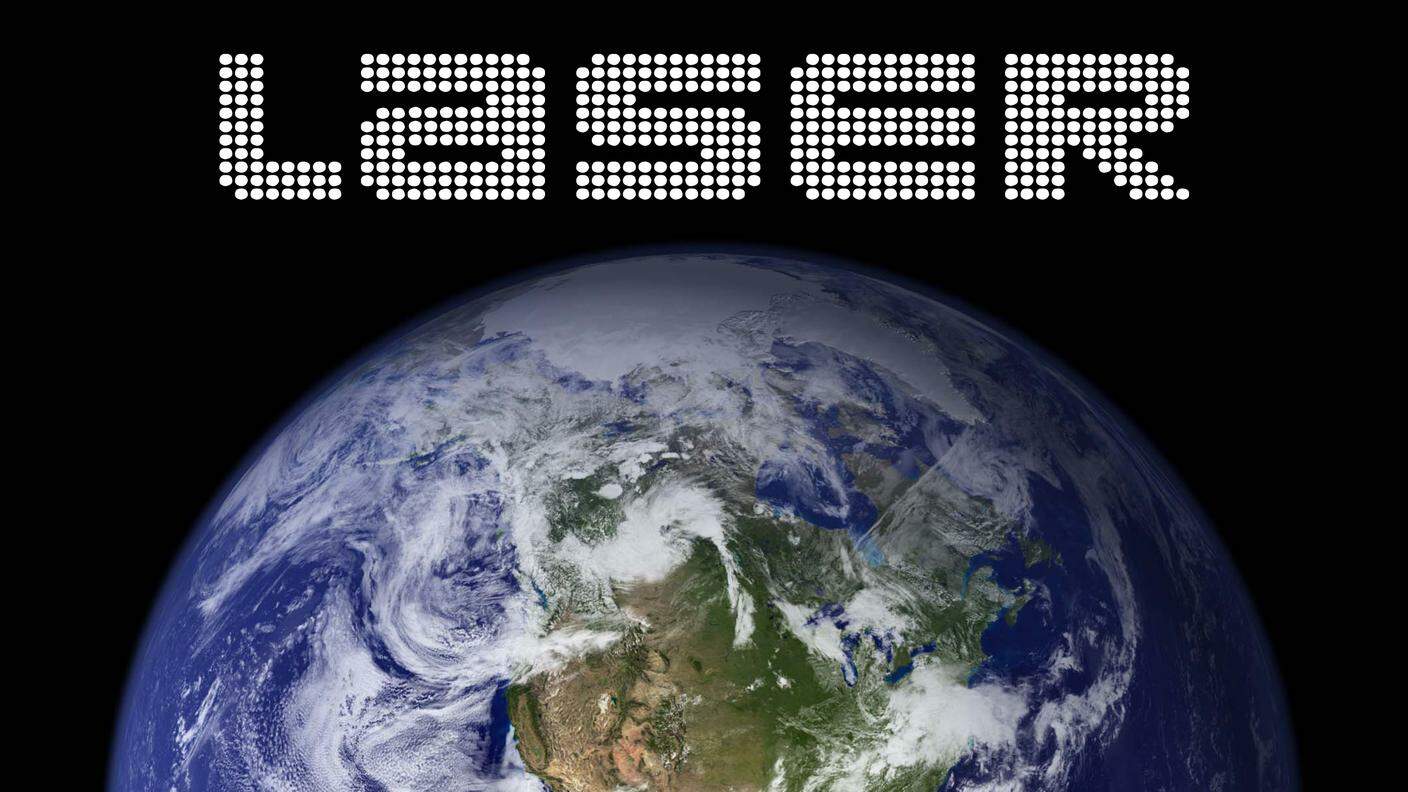
Alterità e identità fra letteratura e antropologia
Laser 06.12.2011, 01:00
Contenuto audio
Scopri la serie
https://www.rsi.ch/s/703609