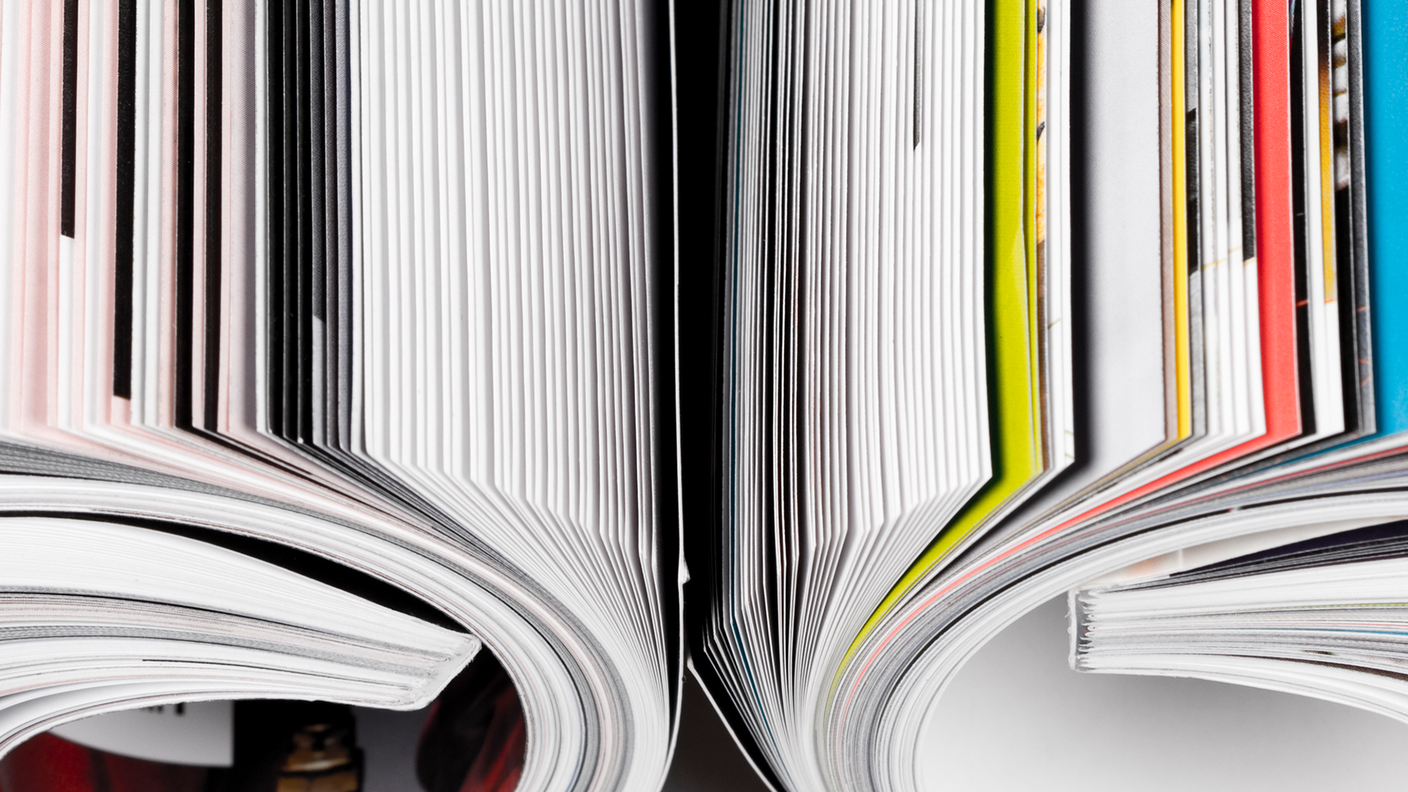Mentre al centro della riflessione filosofica e civile acquista sempre più rilevanza oggi la figura dell’altro, dell’alterità, il Laser odierno, curato da Antonio Ria, offre un approfondimento che va alle radici delle culture del Mediterraneo. Le antiche culture infatti (e non solo quelle del Mediterraneo) hanno intuito che si raggiunge la pienezza dell’essere “umani” quando si riesce ad aprirsi all’altro, al diverso, all’accoglienza dello straniero. Cosa apportano in questo contesto storico-antropologico la Bibbia ebraica e i Vangeli cristiani? Vi sono di fatto delle novità che poi si sono inscritte nel pensiero e nell’etica dell’ebraismo e del cristianesimo? Questi interrogativi vengono affrontati rispettivamente da Haim Baharier, profondo conoscitore di ermeneutica biblica ed esperto di studi ebraici, e da Alberto Melloni, storico del cristianesimo e intellettuale molto aperto e impegnato nel dialogo interreligioso e interculturale. Chi è l’altro per la Bibbia? Come viene identificato lo “straniero” nella Torah? Come si è evoluta nella tradizione teologica ebraica l’idea dell’altro, dell’alterità? E in che modo questa idea viene concretizzata nell’etica ebraica? E nella storia? E nella prassi contemporanea del popolo ebraico? Nelle risposte, puntuali e coraggiose, Haim Baharier, oltre ad evocare il senso dell’alterità nella Bibbia, apporta il contributo fondamentale circa l’esegesi dell’alterità anche del filosofo Emmanuel Lévinas, di cui è stato discepolo. Che tipo di alterità è quella biblica? Quella del bisogno, che invoca la solidarietà concreta e non il semplice riconoscimento astratto? Lévinas direbbe – risponde Baharier – «che invoca la condivisione di cose». Quindi, con la Bibbia e con Levinas – conclude Haim Baharier – «si può dire che l’”altro” biblico è l’”altro” che esige pane e giustizia». In questo modo lo “straniero” diventa davvero una figura paradigmatica soprattutto per i nostri tempi. Da parte sua Alberto Melloni, professore ordinario di Storia del cristianesimo all’Università di Modena-Reggio Emilia e titolare della Cattedra Unesco per il pluralismo religioso e la pace dell’Università di Bologna, ben mette in evidenza da un lato la continuità fra cristianesimo e pensiero biblico, e dall’altro le novità dei Vangeli e del Nuovo Testamento. Melloni non nasconde anche la distanza fra la straordinaria novità della predicazione di Gesù di Nazareth e le incongruenze (per non dire i tradimenti) delle chiese che a lui fanno riferimento. Difatti molto problematico – afferma Albero Melloni – è il passaggio fra visione biblica e teologica dell’altro nel Nuovo Testamento e il modo in cui questa visione si è incarnata, si è attualizzata nella storia del cristianesimo. E poi si può parlare di un’etica cristiana dell’alterità? La risposta l’aveva già data nel 1951 il teologo Jean Daniélou, nel suo saggio “Pour une théologie de l’hospitalité”, in cui scriveva: «Si può dire che la civiltà ha compiuto un passo decisivo, e forse il passo decisivo, il giorno in cui lo straniero da nemico (hostis) è divenuto ospite (hospes)», cioè il giorno in cui «gli individui sono diventati comunità umana». E quindi, conclude Melloni, guardando al futuro: interrogare l’altro e interrogarsi sull’altro va visto anche come risorsa non solo per le comunità dei credenti, ma per ciascun essere umano, credente o non credente.
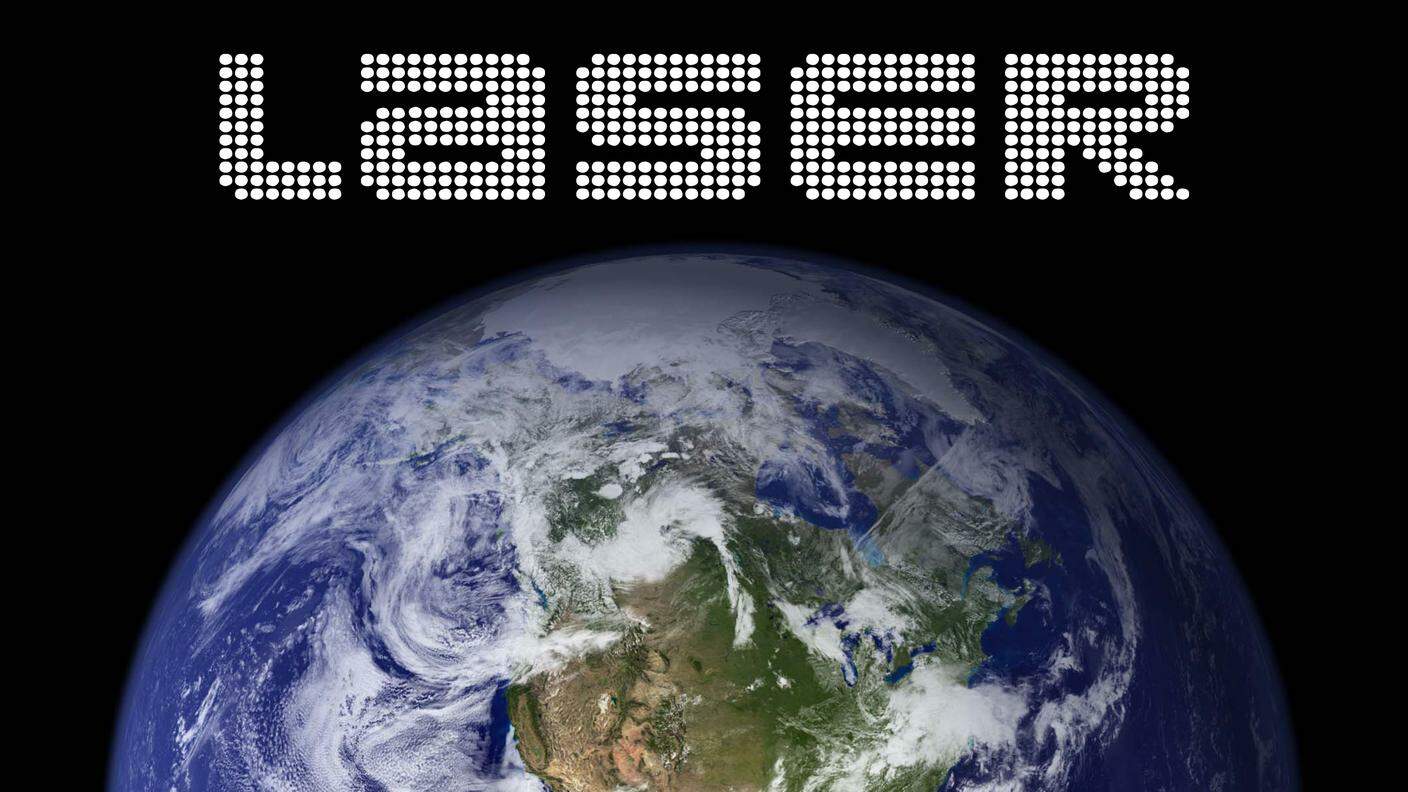
L'altro nella teologia, nella storia e nell'etica ebraico-cristiana
Laser 05.12.2011, 01:00
Contenuto audio
Scopri la serie
https://www.rsi.ch/s/703609