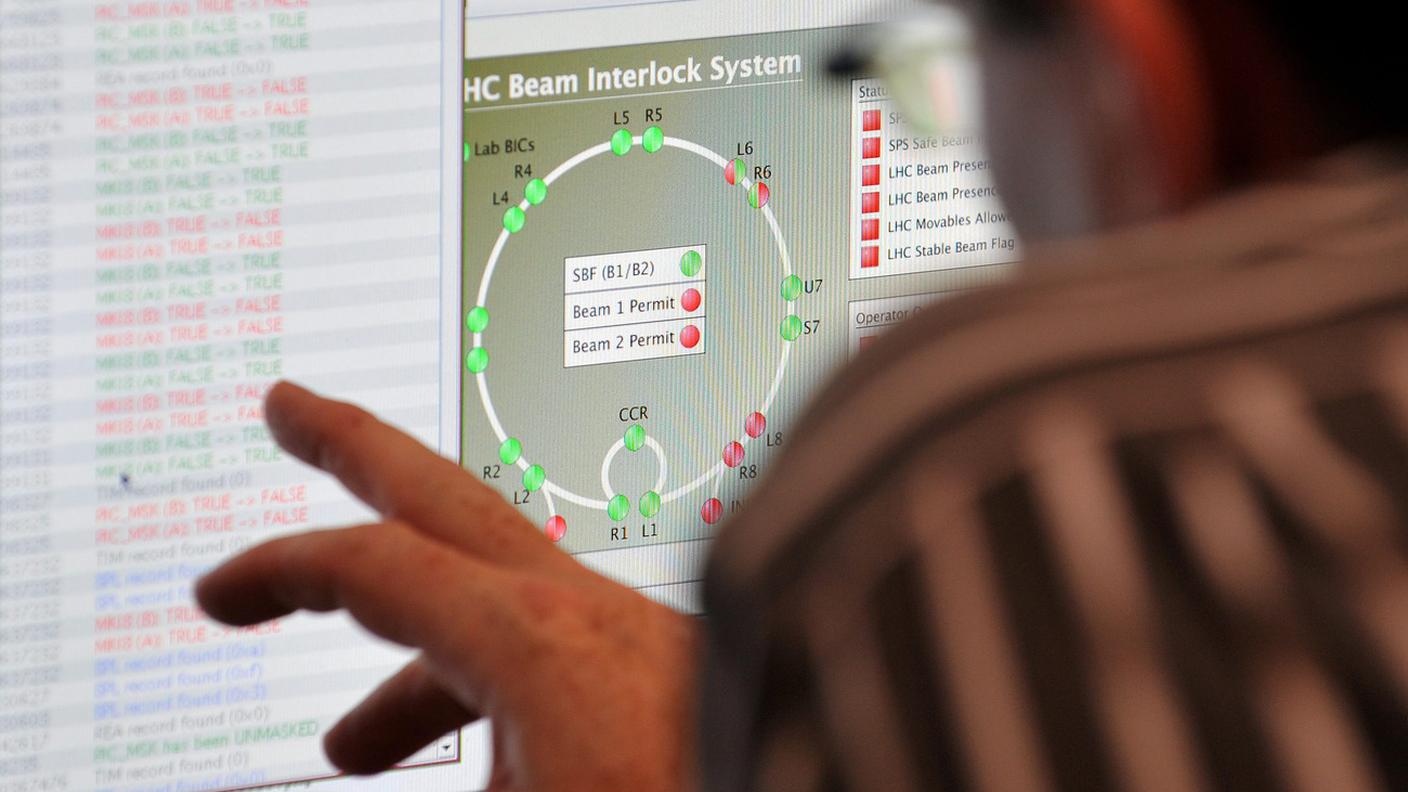Donare il sangue. Un gesto generoso di cui gli ospedali sono grati, data la costante necessità. Eppure ci fu un tempo in cui non tutti erano i benvenuti nei centri trasfusionali. Fu il tempo della migrazione dei cittadini italiani, gli anni dei lavoratori stagionali.
Siamo nel secondo dopoguerra. Decine di migliaia di uomini e donne giungono in Svizzera, vivono nelle baracche e lavorano sui cantieri e nelle fabbriche. Il popolo svizzero li tollera, ma li tiene a debita distanza. Nell’aria aleggiano sentimenti xenofobi.
Nel 1963 un giovane papà italiano impiegato alla ABB di Baden chiede aiuto agli amici: sua figlia versa in gravi condizioni di salute e serve molto sangue. Si precipitano in sei all’ospedale, ma le infermiere non sanno cosa fare: questi italiani cosa vogliono? chi sono? come comportarsi con loro? vogliono farsi pagare o inviare il sangue in Italia?
Incuranti di tanto scetticismo, questi bergamaschi decidono di fondare un’associazione, la AVIS di Baden. AVIS, associazione volontari italiani del sangue, è un’istituzione in Italia. L’entusiasmo è grande, in pochi anni nascono sezioni in quasi tutti i cantoni svizzeri. È una prima mondiale che non avrà uguali. Negli anni 80 gli associati saranno più di 4 mila, anni d’oro che non torneranno più. Oggi gli associati sono appena un migliaio, molte sezioni hanno chiuso.
È anche da AVIS che è passata l’integrazione e l’inclusione di molti italiani nella società di allora. Una realtà nata senza secondi fini, per aiutare chiunque fosse nel bisogno. Un gesto di altruismo e di generosità che riscopriamo nell’approfondimento del Quotidiano di questa sera, grazie alla ricerca di Irene Pellegrini, sociologa all’Università di Ginevra.
Michele Trefogli