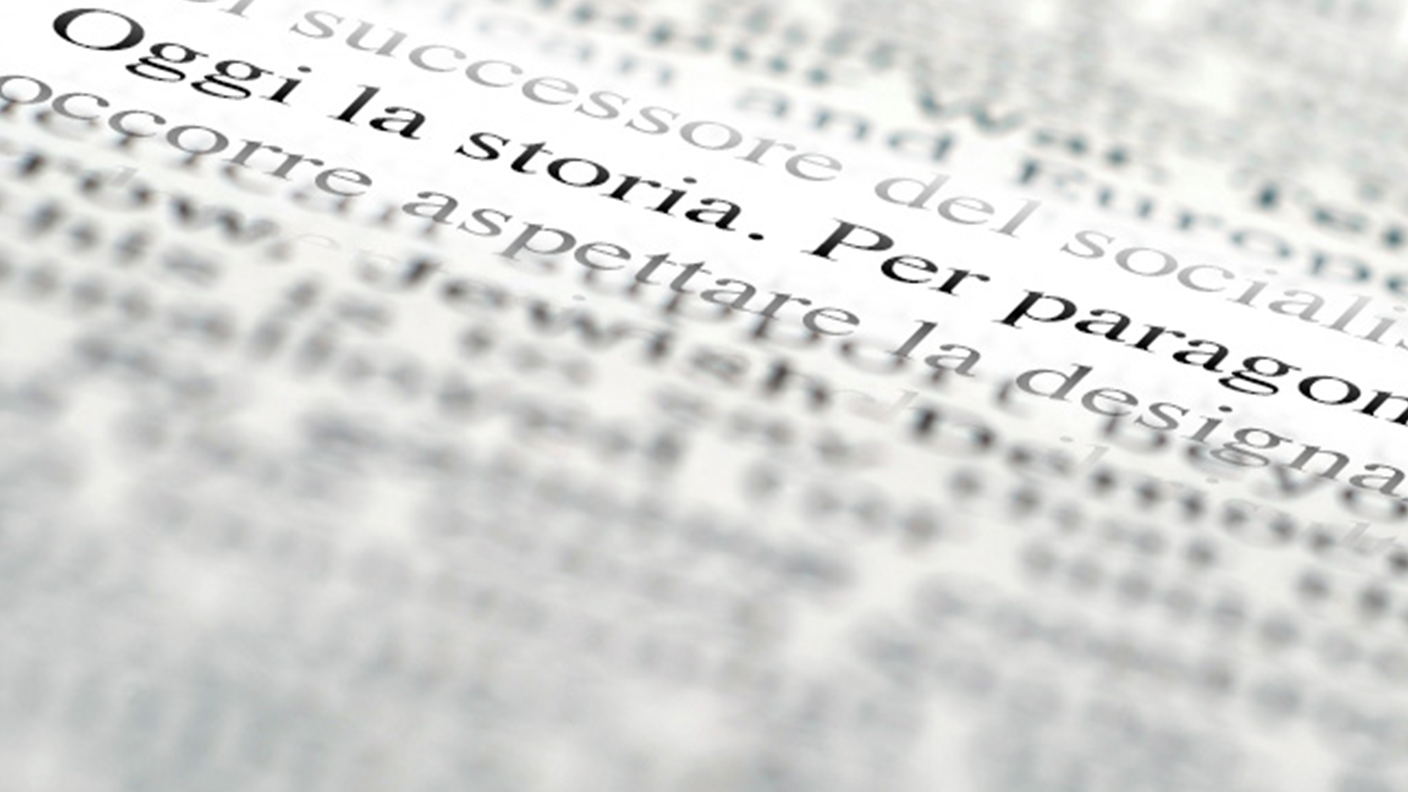
Oggi, la storia 05.12.14
Oggi, la storia 05.12.2014, 07:05
Contenuto audio
È notizia di cronaca di pochi giorni or sono la scoperta di una banda di falsari napoletani, battezzato “Napoli Group” e noto in tutta Europa, che falsificava e diffondeva banconote Euro di vari tagli. In particolare ha sorpreso un dettaglio: una banconota da 300 Euro – taglio inesistente! – smerciata in Germania. I responsabili (29 incarcerati e 10 agli arresti domiciliari) hanno attirato l’attenzione su un mondo da sempre ben conosciuto, quello della contraffazione della moneta, che in certa misura gode della simpatia dell’opinione pubblica: i falsari sono del resto, a loro modo, degli “artisti” e la diffusione del denaro falso, chissà perché, porta con sé un che di goliardico e di beffardo; come non ricordare La banda degli onesti, memorabile film del ’56 diretto da Camillo Mastrocinque che vede protagonisti Totò e Peppino De Filippo?
Del resto già nel mondo antico la contraffazione monetaria era un fenomeno assai diffuso e la produzione dei falsi – nella fattispecie delle monete – era attività praticata non solo dai privati, ma anche da istituzioni pubbliche: Erodoto, ad esempio, narra l’aneddoto di Policrate, il tiranno di Samo che nel 524 a.C. aveva rifilato agli Spartani degli stateri in piombo dorato, e sappiamo che in epoca romana sovente si ricorreva alla cosiddetta “suberazione”. Essa consisteva in una raffinata tecnica di applicazione di una pellicola di metallo nobile sopra un’anima di metallo più vile, ad esempio oro o argento su rame (in latino sub significa “sotto”, ed aes, aeris significa “rame”, da cui “suberazione”): si trattava poi di sottoporre il metallo allo stampo del conio, e la matrice poteva ovviamente essere autentica o contraffatta. È lo stesso Plinio il Vecchio, d’altro canto, a descrivere nei dettagli questa operazione in un passo del libro XXXIII della Naturalis historia. Gli antichi Romani comminavano pene severissime ai falsatori di moneta: la lex Cornelia de falsis, una legge di epoca sillana, poteva prevedere la pena minima della deportazione, quella intermedia dei lavori forzati e quella massima della crocifissione. La contraffazione era, sul piano concettuale, più grave del furto: c’erano la premeditazione, il dolo e la ripetizione del reato: non è un caso che Dante Alighieri nella sua Commedia avesse relegato i falsatori di moneta in fondo all’Inferno, nell’ultima bolgia dell’ottavo cerchio, condannati all’idropisia e ad una sete inestinguibile.
Insomma, è un mestiere antico come la comparsa della moneta, quello della falsificazione: ma artisti o meno che siano i protagonisti, sempre di mistificatori si tratta.
