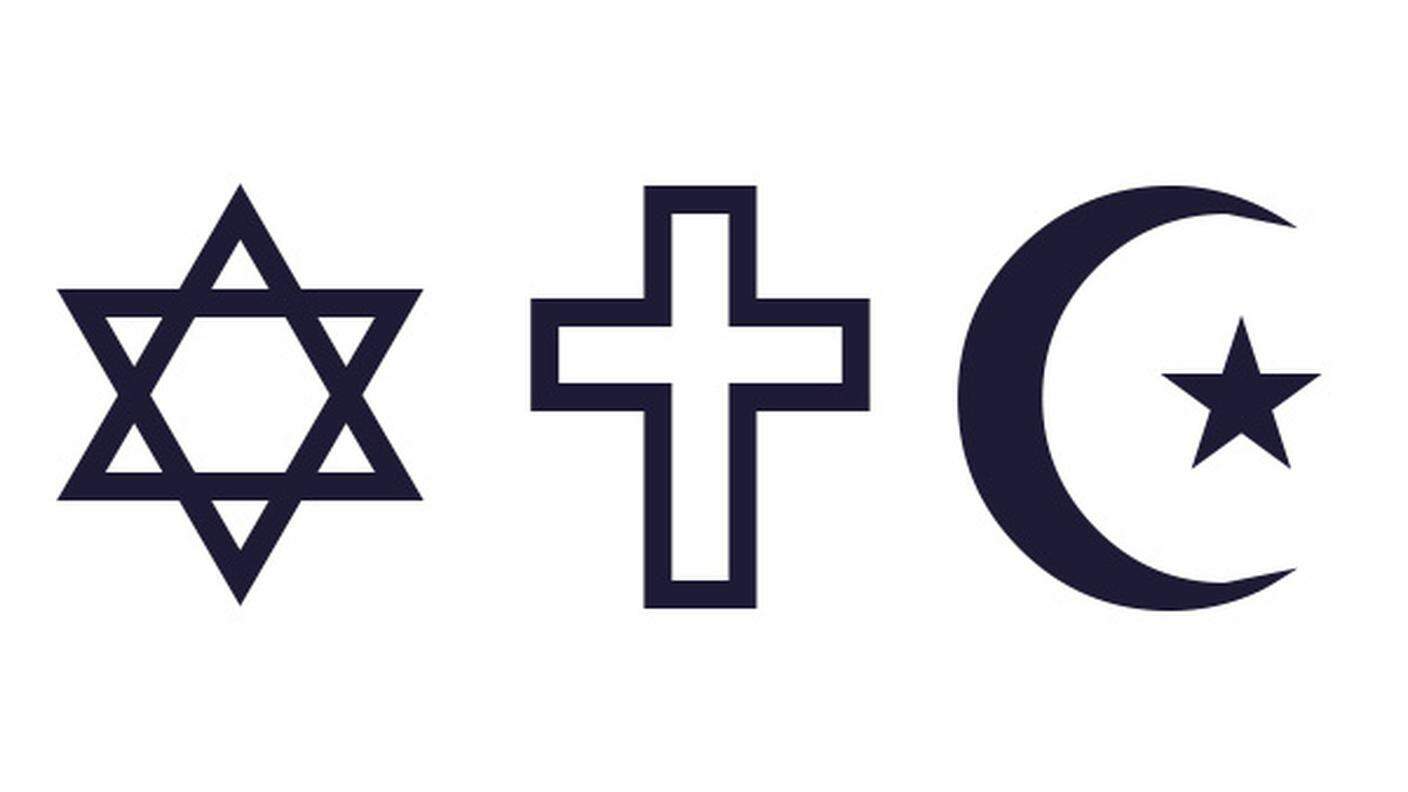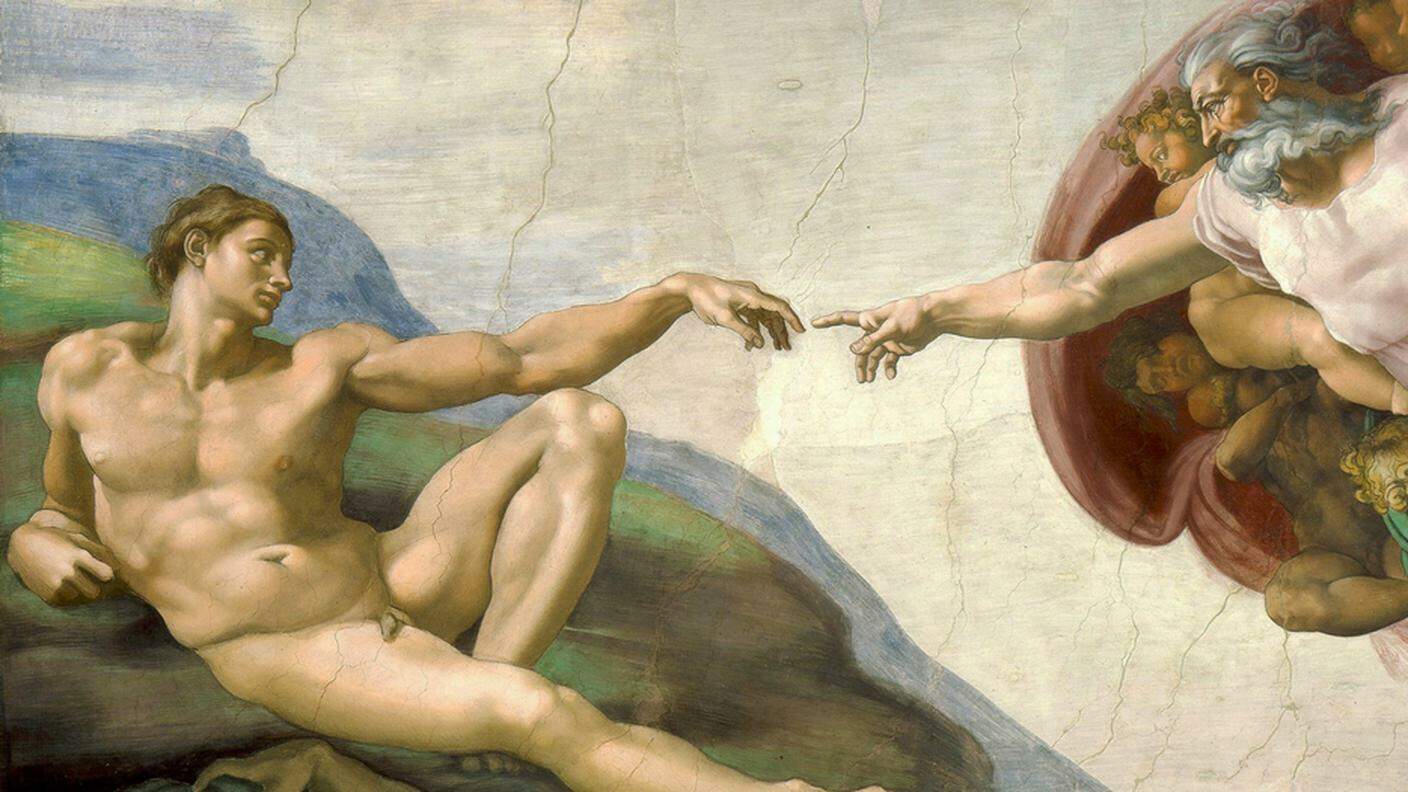Armita Geravand aveva 16 anni. Sì, bisogna parlarne al passato, perché l’1 di ottobre del 2023, ha commesso troppi errori: Armita si era dimenticata di vivere in Iran, si era dimenticata di vivere a Teheran e, colpa conseguente a queste dimenticanze, aveva osato muoversi negli spazi pubblici della metropolitana senza indossare lo Hijab, (il foulard che copre i capelli e il collo). Un “peccato” che non avrebbe mai più commesso: aggredita e picchiata violentemente da membri del Comitato per l’imposizione della virtù e l’interdizione del vizio (un’unità speciale, composta anche da donne, del Comando per l’applicazione della legge dell’Iran), quel giorno Armita è entrata in coma e dopo 28 giorni di agonia è morta.
Questo femminicidio “legale” è stato l’ultimo, in ordine di tempo, che i media occidentali hanno potuto apprendere. Secondo molte testimonianze, le morti e le violenze conosciute, in realtà, sarebbero infatti solo la punta di un iceberg di vicende analoghe che lo stato nasconde, minacciando le famiglie delle vittime per costringerle a sottoscrivere versioni di comodo che assolvono le istituzioni da qualsiasi responsabilità. In ogni caso, Armita è l’ultimo femminicidio “ufficiale” di una serie lunghissima di uccisioni, violenze e soprusi subiti dalle donne per mano delle forze di polizia iraniane impegnate in una sorta di jihad di genere, ossia in una guerra santa contro le donne che non rispettano correttamente le leggi morali dell’islamismo sciita.
Le donne di Tehran
Laser 18.06.2025, 09:00
Contenuto audio
Questo accade nella Repubblica islamica dell’Iran, da tempo al centro dell’attenzione dei media occidentali tanto da risultare quasi un’anomalia politica e religiosa del mondo arabo. I periodici report di Amnesty International, però, riferiscono di situazioni di violenza, connesse con il patriarcato religioso e rivolte contro le donne, in molti paesi mediorientali. Una certa superficialità fa sì che lo sguardo dell’informazione si appunti soprattutto verso quei paesi che, come l’Iran e l’Afghanistan, non mascherano dietro il bon ton diplomatico le proprie disposizioni religiose e politiche in materia di diritti femminili. Il fatto che le donne saudite possano dal 2017 usufruire di cinema, stadi e guidare l’auto senza la presenza di un tutore maschio, ad esempio, ha fatto sostenere a qualche osservatore che il paese stesse vivendo un “rinascimento” sociale e culturale. Forse nei prossimi decenni sarà così, a oggi però non solo è ancora in vigore il “sistema del guardiano” che obbliga le donne ad avere un custode (generalmente il padre o il marito), ma secondo Human Right Watch, l’organizzazione non governativa internazionale che si occupa della difesa dei diritti umani, arresti e misure repressive nei confronti di molte femministe sono all’ordine del giorno.
Due casi, tra i molti, hanno superato le barriere del silenzio: Manahel al-Otaibi, attivista per i diritti delle donne, sotto processo per aver pubblicato un selfie in cui non indossava l’abaya (l’abito tradizionale saudita) e aver postato contenuti per l’annullamento del tutore; Salma al-Shehab, studentessa all’Università di Leeds nel Regno Unito, condannata da un tribunale antiterrorismo saudita a 34 anni di carcere, seguiti da 34 anni di divieto di viaggio, per aver pubblicato, durante una vacanza nel proprio paese, un post su Twitter, nel quale chiedeva il rispetto dei diritti umani e la scarcerazione di un’altra attivista.
Ancora Amnesty denuncia che anche in Egitto: «In ogni aspetto della loro vita, di fronte alle donne e alle ragazze egiziane si presenta (…) lo spettro della violenza fisica e sessuale. Tra le mura domestiche, molte sono sottoposte a vergognosi pestaggi, aggressioni e violenze da parte di mariti e parenti. In pubblico subiscono costanti molestie e aggressioni di gruppo, cui si aggiunge la violenza degli agenti statali».
In Afghanistan, le donne, oltre a essere escluse dalle scuole secondarie, sono tenute a indossare il burka, la veste che le ricopre totalmente e non possono percorrere che pochi passi fuori casa in assenza del loro mahram, il tutore maschio. Inutile dire che le trasgressioni sono punite duramente. E’ quasi pleonastico ricordare che, secondo il Global Gender Gap Report del 2023, l’Afghanistan risulta il peggior Paese al mondo in termini di parità di genere.
Sbaglieremmo però se utilizzassimo queste informazioni per comminare una condanna generalizzata all’Islam. Un conto sono le religioni e i loro principi di osservanza più o meno rigidi, un altro conto sono i fondamentalismi che sul rispetto o meno degli stessi principi, si arrogano diritti di inclusione o esclusione e persino di vita o di morte.
Il Marocco, giusto per fare un esempio “in direzione contraria” (almeno parzialmente), dall’8 marzo 2004 (data ovviamente scelta non a caso), è in vigore il Codice di famiglia che ha riconosciuto la parità di uomo e donna all’interno del nucleo familiare (pur sussistendo la poligamia), con conseguenti ricadute sull’insieme della società e sul concetto stesso di patriarcato.
Il percorso sarà sicuramente lungo, tortuoso e faticoso. Però, come scrisse in occasione della rivolta detta “di piazza Taḥrīr” al Cairo nel 2011, Mona Eltahawy, editorialista del New York Times e attivista per i diritti LGBTQIA+ nel mondo arabo: «Le donne sono le voci della rivoluzione». Voci contro il patriarcato coranico, come hanno dimostrato anche recentemente a Teheran nelle manifestazioni seguite alla morte di Armita; contro il patriarcato ebraico, come mostrano le Ancelle del movimento Bonot Alternativa che fino al 7 ottobre scorso hanno sfilato per le strade di Tel Aviv e Gerusalemme; contro il patriarcato cattolico, come affermano le teologhe che in tutta Europa si ribellano alla misoginia delle gerarchie curiali.
Forse sì, è proprio vero: in campo religioso, le donne sono effettivamente le voci della rivoluzione… o almeno, così speriamo.
Le donne di Tehran
Laser 18.06.2025, 09:00
Contenuto audio