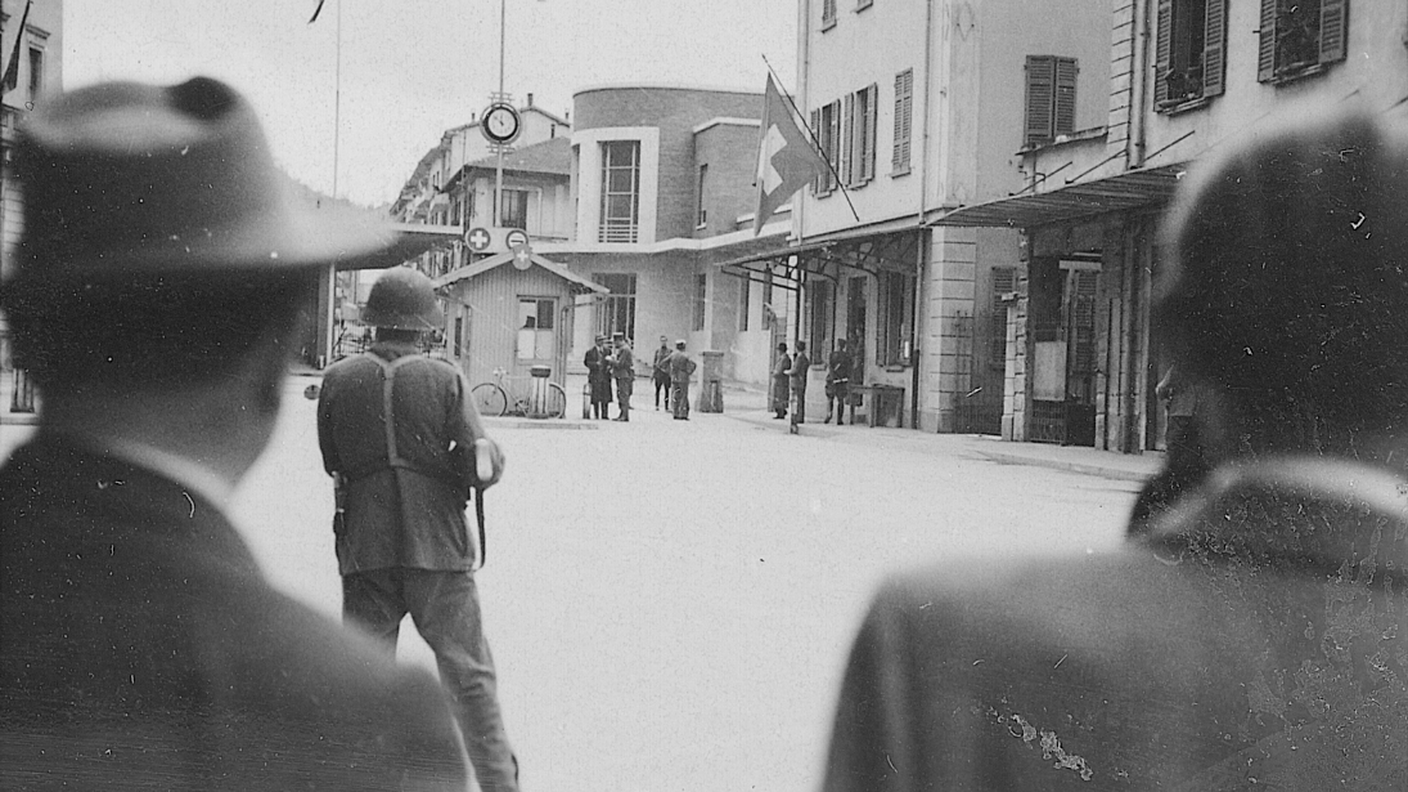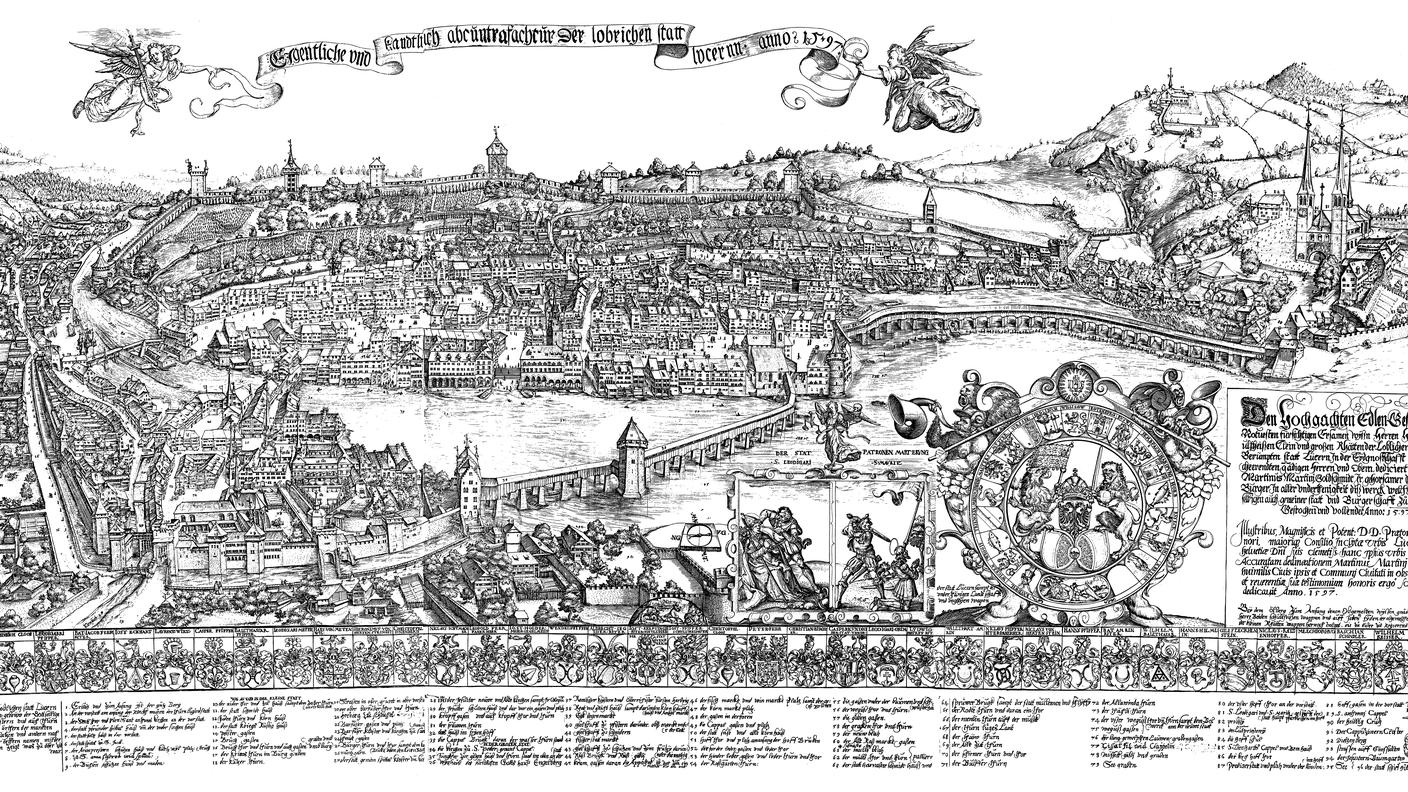La prospettiva può essere parziale, ma sicuramente è esplosiva, perché in fondo domandarsi se la storia del Novecento sia una storia scritta con le bombe è come srotolare una miccia lunghissima lungo tutti quegli eventi che hanno cambiato il corso del secolo, cercando di volta in volta il fiammifero che l’ha innescata. Del resto, per capire quanto la bomba abbia accelerato il tic tac del nostro immaginario basterebbe prendere in esame i bordi estremi delle prime due guerre mondiali. Perché se la partenza del primo conflitto è fatta da qualche colpo di sparo su una strada nel 1914, solo quarant’anni dopo, tutto finisce nelle bombe atomiche sganciate su Hiroshima e Nagasaki che chiudono il secondo. La bomba, insomma, diventa un sinonimo di fine, come punto terminale, anche se poi nei nostri incubi la paura che possa ripetersi la rende una virgola d’inciampo che ci costringe continuamente a trattenere il fiato.
Non a caso, l’immagine del fungo atomico creato dall’esplosione diventa una delle figure simbolo del periodo. All’inizio, senza nemmeno i contorni dello spauracchio, perché le foto delle conseguenze lasciate sul campo nelle città giapponesi restano censurate e mai viste, sorpassate dalla retorica a parole della grande vittoria militare per cui negli Stati Uniti la bomba atomica viene trattata come un’arma amica a cui dover dire grazie. Nelle scuole la si loda e addirittura l’invenzione del costume da bagno a due pezzi, nel 1946, viene chiamato Bikini dal nome dell’atollo delle isole Marshall del Pacifico, famose allora come luogo di sperimentazioni nucleari.
Sarà solo nel decennio successivo che pian piano l’immagine della bomba inizia a incrinarsi, come se la vera onda di propagazione nel resto del mondo arrivasse in ritardo alla piena consapevolezza dei suoi effetti distruttivi. Anche il padre stesso della bomba, J. Robert Oppenheimer cade in disgrazia a causa della sua audizione di sicurezza del 1954. La piena entrata nella guerra fredda cambia il clima ma con quella constatazione che poi si fa certezza: da un’esplosione di una bomba non si torna mai indietro.
Qualcosa che nel 1964 potrà mutarsi persino in satira graffiante con un film come “Il dottor Stranamore” di Stanley Kubrick che trasforma una fine del mondo post-nucleare in un feroce sghignazzo. Ma il cambio di passo ormai è impresso, il contesto è diverso e la bomba, a testimonianza della sua centralità nelle fantasie contemporanee, si fa icona pop. Immagine, volantini, simbolo: grazie alla serialità di Andy Warhol diventa qualcosa di simile al rossetto di Marylin Monroe o alle zuppe Campbell. E da lì in poi ogni cosa che cercherà di sfruttare un effetto sorpresa lo farà imbottendo di esplosivo il linguaggio. Tutto diventa bomba. Dalla notizia-bomba all’offerta-bomba, passando per il tuffo a bomba, la bomba-sexy o la bomba d’acqua.
Insomma, da arma devastante per radere a zero il campo nemico la bomba sembra cambiare mirino, trasformandosi nello strumento più forte per catturare quella che è la merce più rara del nostro tempo: la nostra attenzione. Succede anche quando le bombe tornano a essere tragiche e reali come quelle lasciate sul campo dai vari terrorismi. Bombe che uccidono, fanno stragi ma soprattutto lanciano ovunque schegge di paura, proprio per l’effetto moltiplicatore che generano sui mass-media. Così, in questa prolungata strategia della tensione, per scopi diversi, ci sono bombe che cancellano comizi di piazza o che bloccano le lancette degli orologi nelle stazioni ferroviarie o ancora che fanno esplodere le strade ai più importanti giudici antimafia.
E ogni volta, tra le macerie lasciate sul campo, sembra riaffiorare lo stesso principio di irreversibilità a segnare quel destino per cui una bomba non potrà mai avere un ruolo secondario in una storia. Non accetta comparsate o semplici depistaggi, ma solo scene madri. La bomba resta l’evento per sempre, anche quando i canoni con cui siamo soliti guardare realtà e immaginazione sembrano ribaltarsi.
Quello che succede l’11 settembre del 2001 nel cielo di New York lo sappiamo già tutti. È qualcosa che ci era sembrato di aver visto al cinema e che di colpo trova concretezza nella realtà. È la bomba che addirittura si fa spettacolo, ma è la bomba che trova il suo più inaspettato esplosivo nell’essere umano che decide di immolarsi per la propria causa: il kamikaze. Forse la figura più simbolica con cui andare a chiudere quel secolo, il Novecento, che troppo frettolosamente era stato considerato breve e dato per finito 12 anni prima, con la caduta del muro. In fondo, sia quello di Berlino che quello di New York sono stati due crolli, ma il secondo chiama ancora in causa la bomba implacabile e immancabile, quando c’è da dirottare in modo improvviso il corso della storia. E ancora una volta, viene da dire, non si torna indietro. Anzi, forse è proprio nella costrizione di un dover andare avanti che noi, quell’impotenza da bomba, abbiamo cercato sempre di sdrammatizzarla in tutti modi possibili. Come nelle gag del cinema muto o nei cartoni animati dove la bomba che esplode annerisce il nostro protagonista, ma poi alla scena successiva tutto riparte come se niente fosse. Come se fosse solo un modo per attirare l’attenzione. Il più drastico che ci sia.