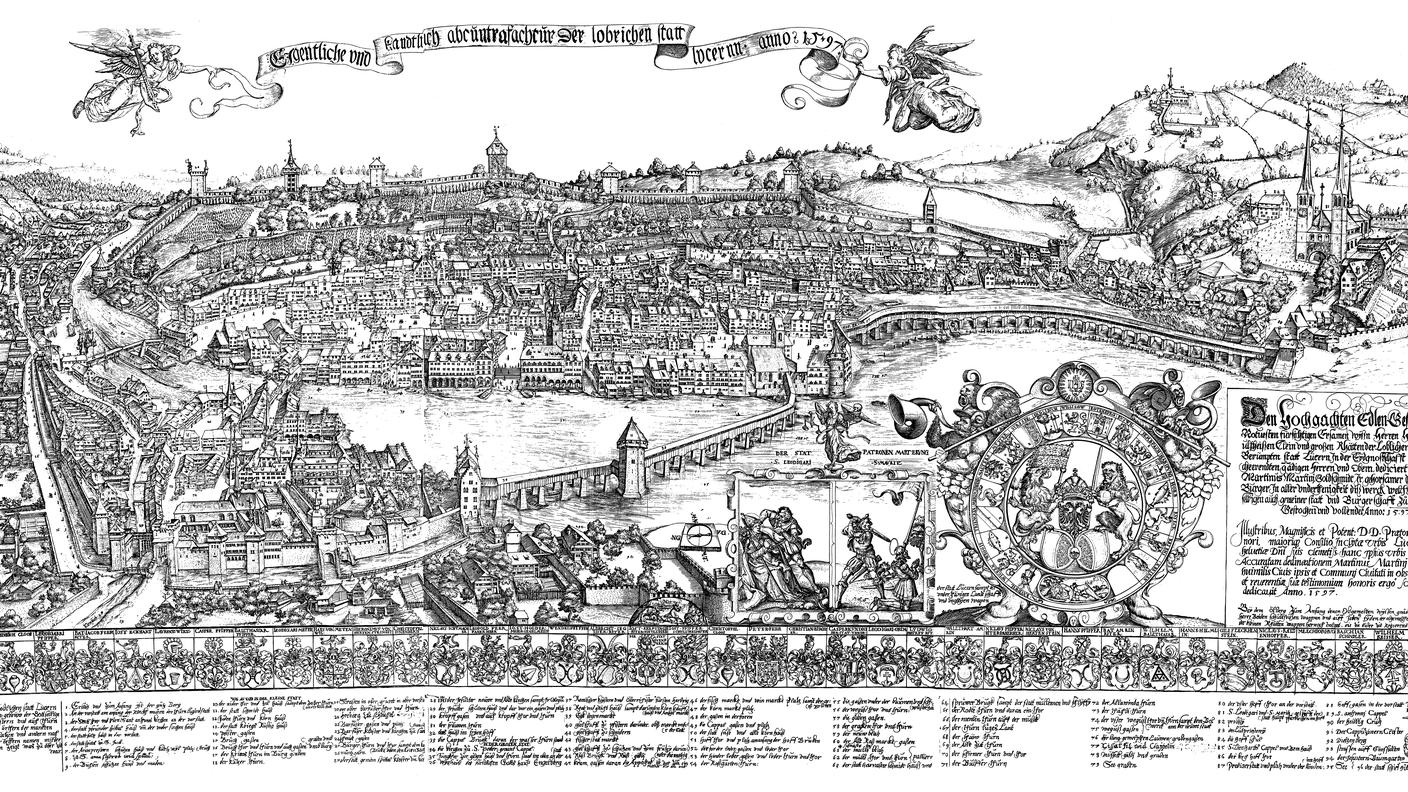«Io non ho potuto partecipare alla sfilata, però. I compagni non mi hanno lasciato andare. Nessuna partigiana garibaldina ha sfilato. Mi ricordo che strillavo: “Io vengo a ficcarmi in mezzo a voi, nel bello della manifestazione! Voglio vedere proprio se mi sbattete fuori”».
Con queste parole una staffetta partigiana piemontese ricorda l’amarezza di non aver potuto prendere parte attivamente alle celebrazioni del Primo Maggio 1945, organizzate nelle principali città del Nord Italia per la Liberazione e la Festa del Lavoro.
Le poche partigiane che riuscirono a sfilare per le strade insieme ai loro compagni vennero ritenute poco serie, perché avevano vissuto a fianco degli uomini in montagna e questo non era certo quello che ci si aspettava da una «brava ragazza» negli anni Quaranta del Novecento.

Tre ragazze aggregate ai gruppi partigiani, in Piazza Brera mentre perlustrano la città insieme ai "gappisti". Milano, 26 aprile 1945
Iniziava subito, già alla fine della guerra, l’oblio del ruolo femminile nella Resistenza al nazifascismo che, invece, per molto tempo è stata narrata come un’impresa quasi esclusivamente maschile, caratterizzata in primo luogo dalla lotta armata.
Furono in effetti poche le donne che chiesero il riconoscimento per le proprie azioni partigiane, visto che per la maggior parte di loro, quello che avevano fatto nella Resistenza, non sembrava avere nulla di eccezionale.

La resistenza delle donne
RSI Alice 09.09.2023, 14:55
Contenuto audio
Dovettero passare trent’anni perché le prime studiose e poi le stesse protagoniste riscoprissero una storia fatta di anonime eroine che, con piccoli e grandi gesti, salvarono migliaia di vite. È infatti solo negli anni Settanta del secolo scorso che si sviluppa un filone di ricerca di storia delle donne che viene inaugurato dal saggio di Rachele Farina e Anna Maria Bruzzone, dal titolo tutt’altro che casuale: La Resistenza taciuta. Dodici vite di partigiane piemontesi, pubblicato nel 1976. Si trattava di una prima raccolta di testimonianze che restituiva il vissuto femminile nella Resistenza, rifiutando di definirlo un semplice contributo, ma mettendo in luce l’importanza della resistenza civile praticata collettivamente dalle donne.
Se dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943 per gli uomini la scelta di abbracciare la Resistenza era stata l’unica via per evitare la leva obbligatoria o la deportazione in campo di concentramento, per le donne la situazione era molto diversa perché si trattava di una scelta volontaria: loro non subivano quella pressione che invece imponeva di doversi schierare con i repubblichini di Salò o con i partigiani. Quelle che decisero di partecipare alla Resistenza lo fecero per libera scelta e soprattutto disattendendo alle aspettative sociali, che le volevano rinchiuse tra le mura domestiche.
Proprio ciò che il fascismo, per un ventennio, aveva insegnato alle donne, segregandole al compito di madri accudenti e di angeli del focolare, diviene il modo con cui esse contribuiscono alla lotta di liberazione. La storica Anna Bravo, in un bel saggio della fine degli anni Novanta - In guerra senz’armi - conia la definizione di «maternage di massa» per descrivere l’azione femminile durante il conflitto, intendendo con quest’espressione tutti quei gesti quotidiani di cura che, in maniera inconsapevolmente sovversiva, assumono una portata rivoluzionaria e permettono di salvare vite e liberare l’Italia. Nelle zone occupate della penisola le donne di tutte le classi sociali, più o meno giovani, politicizzate o no, istruite o analfabete, si mobilitano senza chiedere nulla in cambio. Un’azione, «non concordata, ma concorde», come l’ha definita Anna Maria Bruzzone.
Anche agli uomini era molto chiaro che, senza il sostegno femminile, la guerra partigiana non si sarebbe potuta fare. Sono infatti le donne che mantengono il collegamento tra la montagna e la pianura, che riforniscono di viveri, informazioni e armi le bande, che tessono quella rete di supporto logistico che è vitale alla Resistenza.

La Resistenza taciuta. Dodici vite di partigiane piemontesi, immagine di copertina, di Anna M. Bruzzone e Rachele Farina. Ed. Bollati Boringhieri (2016).
Ma non esistono solo le staffette, altre sono spie, sabotatrici, altre ancora decidono di abbracciare le armi. Alla fine del conflitto saranno ben 35’000 quelle che otterranno il riconoscimento di «partigiana combattente», un titolo che si poteva ottenere dopo aver dimostrato di aver vissuto almeno tre mesi in montagna e di aver preso parte ad azioni di lotta di un certo rilievo. Criteri plasmati sull’esperienza maschile che mal si conciliano con la varietà e la ricchezza delle pratiche di resistenza messe in atto dalle donne.
La Resistenza è poi per molte ragazze e donne soprattutto un’esperienza di emancipazione e di presa di coscienza dell’oppressione subita. Vivere in montagna lontano da casa, a fianco di ragazzi sconosciuti, sentire discorsi politici sono situazioni inedite e formative.
Nel contesto della Resistenza, già nel novembre del 1943, nascono i Gruppi di Difesa della Donna (GDD) con il compito di collaborare con il Comitato di Liberazione Nazionale (CNL) e di coordinare la resistenza femminile. Tra le fondatrici vi sono rappresentati delle diverse sensibilità politiche antifasciste, come le donne del Partito d’Azione, le comuniste, le socialiste e poco più tardi anche le cattoliche. È proprio all’interno di questi gruppi che si sviluppa una coscienza femminista che avanza una serie di rivendicazioni che vanno ben oltre la cacciata dei nazifascisti dal Paese. Le donne diventano consapevoli del loro valore e della loro importanza politica e, per questo, chiedono la parità salariale, il diritto di voto, il diritto al lavoro e il congedo maternità. Tutte rivendicazioni che nei decenni successivi troveranno una concretizzazione formale attraverso le leggi, ma che restano ancora oggi questioni in parte irrisolte e vive nei dibattiti dei movimenti delle donne.
A ottant’anni dalla fine della Seconda guerra mondiale, in un clima internazionale caratterizzato da conflitti efferati e violenza crescente, è doveroso sottolineare il ruolo determinante delle donne del passato e del presente che, mettendo a repentaglio la loro stessa esistenza, contribuiscono attivamente a resistere all’avanzamento dell’orrore e della barbarie.
Retrospettiva storica del Primo Maggio
RSI Notrehistoire 01.05.1989, 17:57