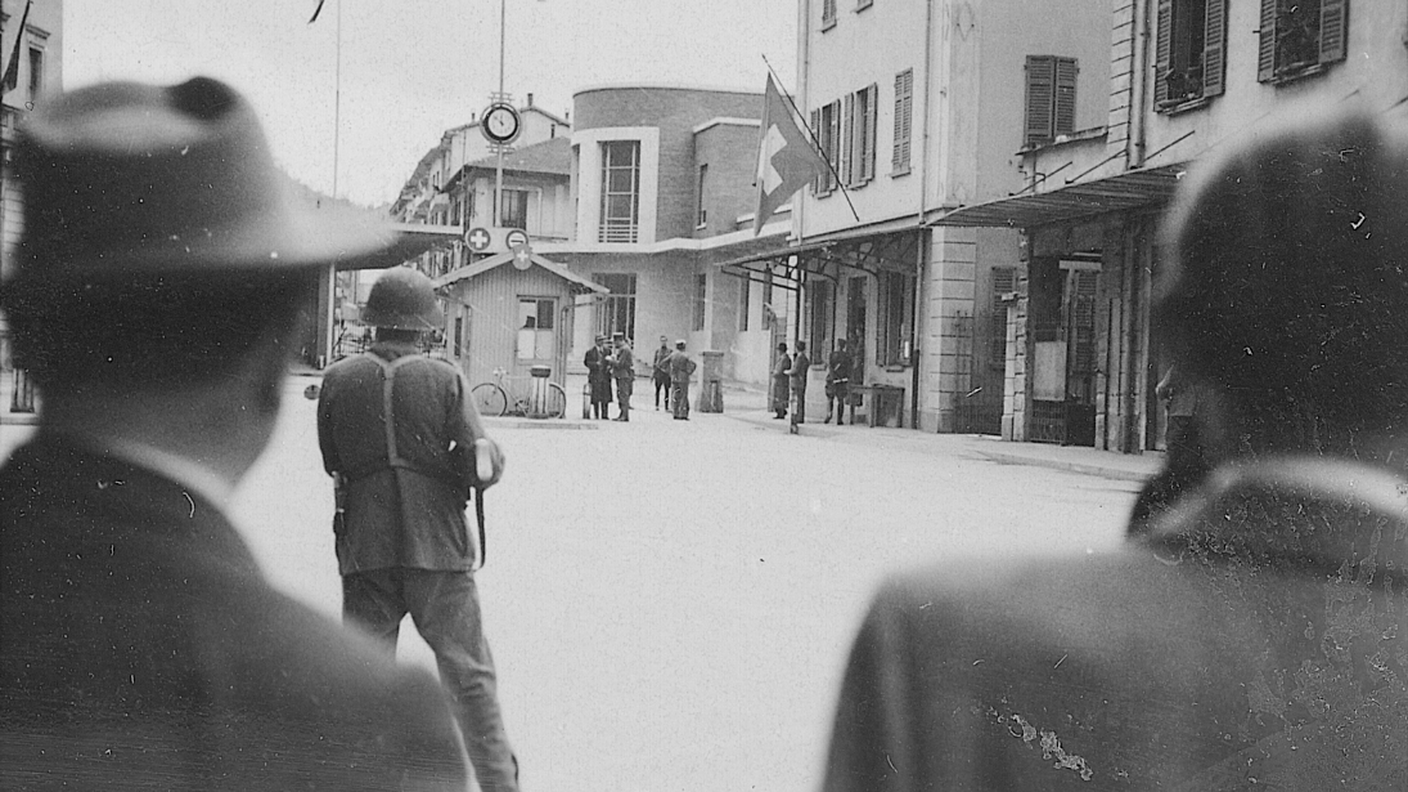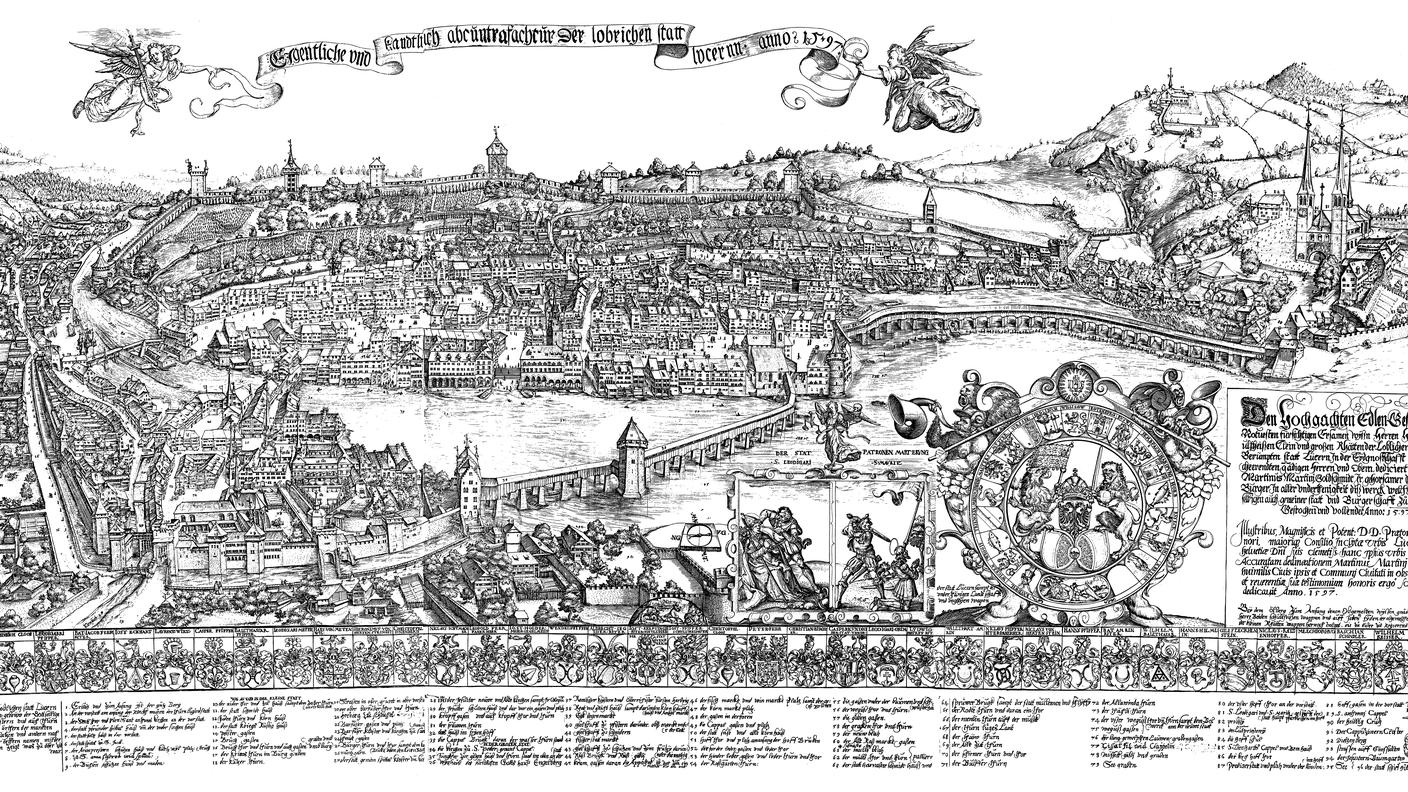La battaglia di Giornico, combattuta il 28 dicembre 1478, fu un evento cruento e intenso in cui un piccolo gruppo di leventinesi riuscì a prevalere contro forze avversarie. Conosciuta anche come battaglia dei Sassi Grossi o, nei Martirologi di Prato e di Mairengo, come la “Vicenda di Giornico”, si svolse in un’area compresa tra Bodio e Pollegio, all’epoca parte di un territorio che si estendeva fino al Brenno. Giornico era considerata una località strategica, sia per il suo valore politico e religioso nella Valle Leventina, sia per la posizione geografica privilegiata, ai piedi delle gole della Biaschina. La zona, infatti, serviva come punto di sosta e approvvigionamento per chi attraversava le Alpi attraverso il passo del San Gottardo.
Come evidenziato dallo storico Paolo Ostinelli nel suo saggio (DSS), la nobile famiglia dei da Giornico ricoprì un ruolo di spicco nel Medioevo, con vasti possedimenti in Leventina e nelle valli ambrosiane della Riviera e di Blenio. Tra il XII e il XIII secolo, questa famiglia era tra i principali proprietari terrieri locali e si schierò con il Sacro Romano Impero contro i canonici del Duomo di Milano. Tuttavia, la sconfitta di Federico Barbarossa nella battaglia di Legnano (1176) riportò la Valle sotto il controllo milanese, ridimensionando dunque anche l’influenza esercitata daida Giornico. Nonostante ciò, la famiglia venne integrata nell’élite dirigente locale.
Va infine sottolineato che, durante la dominazione del capitolo di Milano, Giornico ospitava le sessioni supplementari di giustizia delle Tre Valli, confermando il suo ruolo centrale nella vita politica e amministrativa della regione.
Mappa di Giornico (2016).
Fin dal Medioevo, Giornico si trovava dunque al centro di una contesa territoriale tra due grandi potenze: a sud, il Ducato di Milano, e a nord, i Confederati. Il Passo del San Gottardo, che collegava queste due realtà, assumeva un ruolo strategico, diventando teatro di una competizione serrata per il suo controllo. Questa disputa culminò nelle cosiddette Campagne transalpine, descritte da Hans Stadler nel Dizionario Storico della Svizzera come “operazioni militari condotte nel XV e all’inizio del XVI secolo dai Confederati e dai loro alleati per estendere i loro domini nelle regioni a sud dei passi alpini”. Sempre secondo l’autore “gli Urani e i cantoni interessati al passo del San Gottardo parteciparono in forze alla penetrazione nel Ticino”, cosicché i cantoni di Uri e Obvaldo, insieme ad altri, spinsero verso il Ticino, mentre i Vallesani e i Bernesi guardavano alla Val d’Ossola come a un’alternativa strategica, mentre le valli della Valtellina e di Chiavenna attiravano l’interesse dei Grigioni. In realtà, la politica transalpina era già centrale nel XIV secolo, come dimostrano accordi quali la pace tra la valle d’Orsera e la Leventina del 1331 o il patto di Zurigo del 1351, che ampliò l’area di influenza confederata fino al Monte Piottino; successivamente, nel XV secolo, Re Sigismondo (Re dei Romani prima, Imperatore poi) trasferì ai Confederati la sovranità su alcune aree alpine, sperando di ottenere il loro sostegno militare contro il suo rivale, Federico IV d’Asburgo. Intanto, Uri e Obvaldo rafforzavano i legami con i territori meridionali: nel 1403 strinsero un’alleanza con la Leventina, nel 1407 un accordo con i baroni de Sacco della Mesolcina, e nel 1419 acquisirono Bellinzona, un punto chiave lungo la via del San Gottardo. Il Ducato di Milano, tuttavia, sotto la guida di Filippo Maria Visconti, reagì e cercò di riprendere il controllo delle aree perdute. Nel 1422, la battaglia di Arbedo vide le truppe milanesi prevalere sui Confederati, che persero temporaneamente il Ticino. Le tensioni continuarono con frequenti ribellioni, come quella dei Leventinesi nel 1424, e dispute sui diritti di sfruttamento delle risorse naturali, in particolare i boschi di castagno situati in territorio ducale. Questi contrasti portarono a nuovi scontri e nel 1439 la Leventina fu nuovamente occupata dai Confederati, che consolidarono il loro controllo con la pace del 1441.
Un altro motivo di conflitto emerse con la cessione della Leventina a Uri: i boschi di castagno situati a sud del nuovo confine rimasero sotto giurisdizione milanese, creando difficoltà per i Leventinesi, che dipendevano da queste risorse per il sostentamento. Questo problema, unito al mancato rispetto degli accordi presi dal Ducato nel 1466, contribuì a riaccendere le ostilità. La situazione degenerò ulteriormente quando il duca Gian Galeazzo Maria Sforza si alleò con Carlo il Temerario contro i Confederati, a sua volta impegnato contro i Confederati nelle guerre di Borgogna). Nel novembre del 1478, le truppe urane attraversarono allora il San Gottardo e invasero la Leventina, accolte come liberatrici dalla popolazione locale, che si schierò al loro fianco, portando al celebre scontro della battaglia dei Sassi Grossi.
Gian Galeazzo Maria Sforza, duca di Milano, scolpito da Benedetto Briosco ad inizio 1490.
Il 30 novembre 1478, gli Urani, sostenuti dagli altri sette cantoni confederati in nome della solidarietà federale, diedero il via a un’azione militare su larga scala. L’esercito svizzero, composto da circa diecimila uomini, assediò Bellinzona, saccheggiò le campagne circostanti e spinse le sue incursioni fino alle porte di Locarno e Lugano. Per contrastare gli attacchi dei Confederati e ristabilire l’ordine nella Leventina, il duca di Milano mobilitò un contingente di 8.000 soldati. Il suo obiettivo era punire i “montanari ribelli” e avanzare fino al passo del San Gottardo, così da prevenire ulteriori incursioni; il suo esercito raggiunse la piana di Magadino il 16 dicembre.
Nonostante due settimane di assedio, la fortezza di Bellinzona, protetta da possenti mura e castelli, si rivelò inespugnabile; inoltre le abbondanti nevicate rendevano difficili i collegamenti e il rifornimento dei viveri. Per queste ragioni, i Confederati abbandonarono l’assedio ritirandosi oltre le Alpi, ma lasciarono una guarnigione di 175 uomini a difesa della Leventina. Questa fu rinforzata da circa 400 Leventinesi, che si posizionarono strategicamente sul sentiero che da Bodio conduceva al terrazzo di Sobrio, vicino a Giornico. La loro azione si rivelò cruciale: approfittando delle difficoltà del nemico, costretto ad avanzare in una valle stretta e innevata in formazione di colonna, i Leventinesi sfruttarono la sorpresa, la conoscenza del territorio e la loro abilità nel muoversi sulla neve, per infliggere un colpo decisivo alle truppe ducali.
Stemma di Giornico.
Il 28 dicembre 1478, l’esercito milanese subì un attacco inaspettato da parte dei Leventinesi, che riuscirono a disperdere le truppe del duca di Milano. Per sferrare l’offensiva, i Leventinesi utilizzarono tronchi d’albero e massi, provocando caos tra le fila nemiche e impedendo qualsiasi possibilità di manovra militare. Per i milanesi, la Battaglia dei Sassi Grossi fu devastante, con una perdita di oltre mille soldati. Sul fronte leventinese, si registrarono 50 caduti e più di 60 feriti, mentre i Confederati, rimasti in una posizione più arretrata rispetto al centro del combattimento, riportarono solo 12 feriti da arma da fuoco, venendo coinvolti solo in minima parte nello scontro.
Chiesa dei Santi Innocenti a Pollegio.
I caduti vennero sepolti in fosse comuni, e in segno di ricordo nel 1487 i Confederati decisero di costruire a Pollegio la chiesetta dedicata ai Santi Martiri Innocenti. Tale decisione nacque dalla volontà di commemorare il fatto d’armi e di lasciare un segno tangibile della vittoria: infatti, i vincitori impedirono persino la rimozione dei corpi dei caduti, affinché i Bellinzonesi, che per anni avevano mostrato ostilità verso i Confederati, non potessero dimenticare l’anniversario della sconfitta. Sul luogo della sepoltura, nello stesso anno, fu eretto un ossario, demolito poi nel XIX secolo, mentre nel Seicento, proprio di fronte, venne edificata la Chiesa dei Santi Martiri Innocenti. Questo episodio è ricordato nei martirologi cinquecenteschi conservati a Chironico, Mairengo e Quinto. L’episodio è narrato nei martirologi cinquecenteschi conservati a Chironico, Mairengo e Quinto e recita così il Martirologio di quest’ultimo, al giorno 28 dicembre:
M.CCCC.LXXVIIII, inditione XIa die lune XXVIII Ia mensis decembris super die sanctorum Innocentium facta fuit maxima pugna per magnificos Dominos nostros Uranienses una cum illis de Suizio, de Zurico, de Lucerna et de Leventina super terretorium vicinantie de Zornico contra exercitum Ducis Mediolani et interfecti fuerunt centenaria XIIII de Lombardis. Et statutum fuit quod omni anno super suprascriptam diem Innocentium fiat specialis commemoratio pro suprascriptis defunctis.
Ossia: il giorno 11 di lunedì, 28 dicembre, giorno dei Santi Innocenti, fu combattuta una grande battaglia dai nostri magnifici Signori di Uri insieme a quelli di Svizzera, di Zurigo, di Lucerna e di Leventina, nel territorio del quartiere di Giornico contro l'esercito del Duca di Milano e quattrocento Longobardi furono trucidati. Ed è stato stabilito che ogni anno nel predetto Giorno degli Innocenti si svolga una speciale commemorazione dei suddetti defunti.
Monumento alla Battaglia di Giornico.
Il monumento, raffigurante un guerriero nell’atto di spingere un masso da scagliare contro il nemico, è opera dello scultore Apollonio Pessina di Ligornetto. Questo simbolo commemorativo della battaglia dei Sassi Grossi domina oggi il paesaggio di Giornico, perpetuando la memoria dello storico evento .Il progetto, scelto tra 35 proposte presentate al concorso pubblico indetto il 7 gennaio 1929, affrontò numerosi ritardi prima di essere realizzato. Completato negli anni successivi, fu infine inaugurato il 1° agosto 1937.
Nel 1978, in occasione del cinquecentesimo anniversario della battaglia, furono organizzati un corteo storico e varie celebrazioni. Nello stesso anno, Casa Stanga, attuale sede del Museo di Leventina, fu oggetto di un significativo intervento di restauro e valorizzazione.

Casa Stanga, Museo di Leventina a Giornico.
La battaglia di Giornico rappresentò per il Ducato di Milano una pesante sconfitta, che lo costrinse a rinunciare alla Leventina, tornata così sotto il dominio urano, sebbene Milano mantenesse il controllo su Bellinzona. Con la Pace di Lucerna del 1480 e il riconoscimento ufficiale nel 1487 da parte del capitolo del Duomo di Milano, il ducato abbandonò definitivamente ogni rivendicazione sulla valle Leventina, che rimase sotto il controllo degli Urani fino alla fine dell’Antico Regime, nel 1798 .Gli eventi legati a questo scontro furono narrati anche da Stefano Franscini, politico, pedagogista e in seguito Consigliere federale ticinese, nel suo lavoro La Svizzera italiana, pubblicato in tre volumi (il primo nel 1837 e i successivi due nel 1840):
Ripassarono il Gottardo lasciando in Leventina alcuna compagnia d'uomini di Svitto, Zurigo, Lucerna ed Uri, e le milizie della valle, gli Svizzeri, sotto gli ordini di Troger capitano d'Urania, i Leventini, sotto quelli del capitano Stanga di Giornico. Il conte Torello aveva ricevuti rinforzi e l'espresso comandamento di cacciar gli Svizzeri anche dalla Leventina. Tolte seco più di quindici migliaia di soldati, con grande seguito di cavalli e cannoni, avanzandosi verso il ponte di Biasca. Quindi se gli fece incontro un corpo di Leventini, che non per altro l'affrontarono, se non per condurlo nel piano tra Bodio e Giornico, dove il loro capitano Stanga ogni cosa aveva predisposto a render fatale la giornata a' ducheschi. Allagata era la pianura nell'aspettazione che l'aspro freddo della notte la convertisse in un campo di ghiaccio; e pronta era sulle alture gente che dirupar ne dovea innumerevoli e grossi macigni. Tutto andò a meraviglia. Poche centinaia di Svizzeri e Leventini disfecero quel formidabile esercito di nemici, uccidendogli, chi dice 1400 chi 4000 uomini, pigliando gli cannoni e una grandissima quantità d'altre armi e copia di vittovaglie, inseguendolo sino nella Riviera e facendogli un gran numero di prigionieri. Questa è la battaglia di Giornico, data alli sassi grossi il giorno degl'Innocenti del 1478: guadagnaronla cogli Svizzeri lo Stanga e i suoi Leventini. Lo Stanga carico di ferite, spirò nel riporre il piede nella propria casa, di ritorno dalla battaglia. Di quella vittoria si sparse il grido per tutta Italia; una, come vuole spesso la capricciosa fortuna, degli oscuri Leventini non si parlò, e tutta Italia tremò al nome Svizzero. Tra il terrore di quella sconfitta i Lombardi bramarono la pace, e per introdotto di Luigi XI di Francia fu conchiusa a gran vantaggio degli Svizzeri (1479). Misero a 100.000 ducati il prezzo del ritirarsi, a 24.000 fiorini la spesa dell'armamento: a questa condizione furon rinnovati i trattati, e confermata ad Uri la signoria sulla Leventina, a cui era dovuta in molta parte la insigne vittoria. Tale è la sorte di chi pugna non per suo ma per altrui conto.