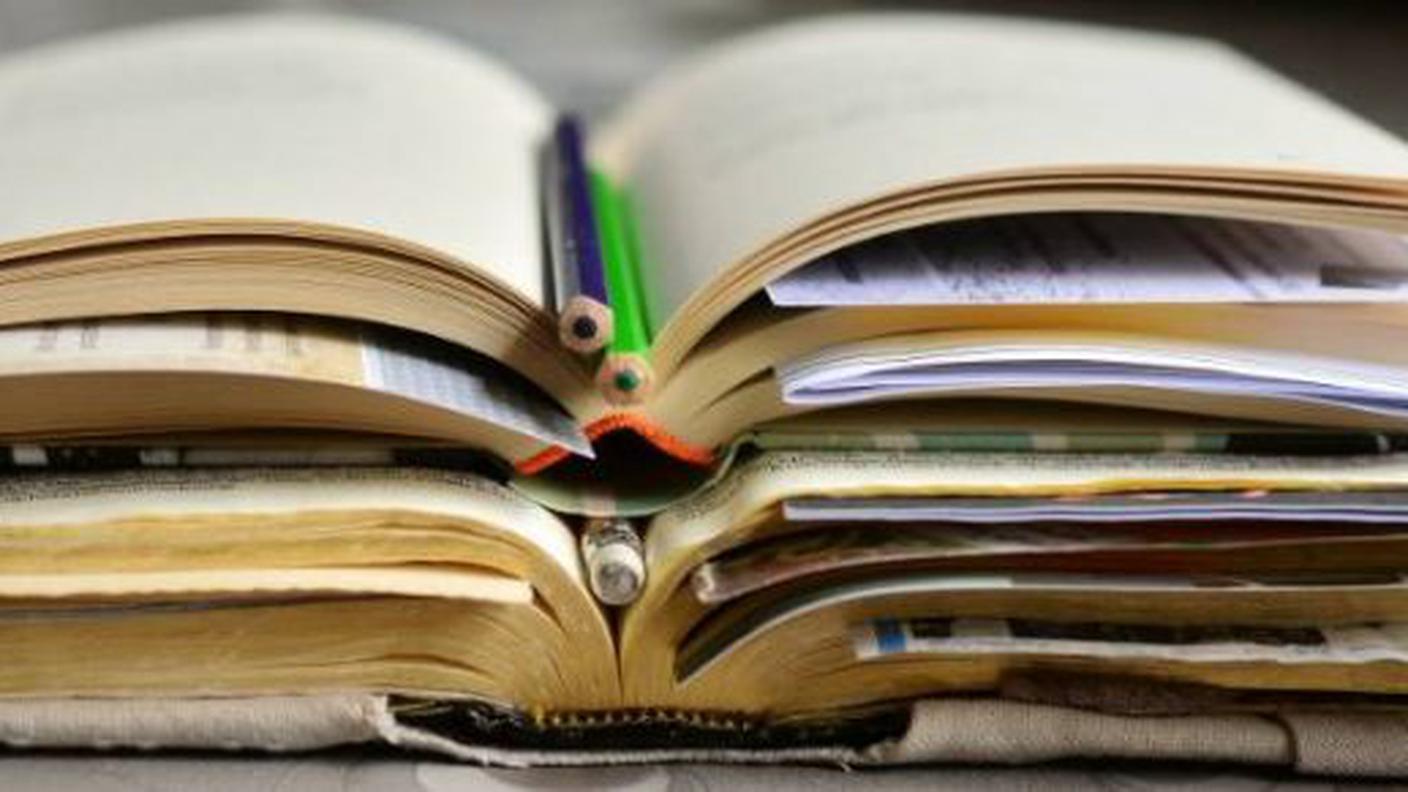L’apprendimento della grammatica a scuola, si sa, non è tra le l’attività preferite dagli studenti e dalle studentesse. Durante le Scuole elementari si iniziano a costruire le fondamenta dello studio grammaticale, per poi approfondirlo in maniera più sostanziosa e sistematica durante i quattro anni di Scuola media. Una cosa è certa, la modalità è sempre la stessa: scheda teorica, memorizzazione ed applicazione attraverso esercizi ad hoc. Insomma, l’insegnamento diventa un atto pratico, quasi meccanico e ciò influenza in maniera diretta l’interesse che tale disciplina genera nei discenti e nelle discenti di tutte le età.
Concepita in questo modo, la grammatica sembrerebbe presupporre che essa esista dall’inizio dei tempi, come fosse stata dettata da una qualche divinità ai primi uomini ospiti del pianeta e a cui abbiamo dovuto adattarci. Non andò certamente così, ovviamente. Un assurdo che, tuttavia, dovrebbe rendere chiara la concezione in cui la didattica dell’italiano si ritrova incatenata da molti decenni a questa parte: le regole grammaticali, l’analisi logica, le categorie del parlato e dello scritto sono elementi percepiti come esterni al parlante, quasi gli fossero estranei.
In realtà, dal punto di vista storico, la grammatica altro non è che una sistematizzazione organica dei fenomeni del parlato cui criterio principe è la frequenza di utilizzo dei parlanti. I protagonisti siamo dunque noi stessi che, attraverso un processo storico-naturale, siamo arrivati al punto di padroneggiare e sviluppare le nostre facoltà linguistiche per esigenze comunicative, sociali, politiche. Basti pensare che il primo tentativo di raccogliere in modo sistematico e scientifico le regole della lingua italiana si ebbe solo nel Quattrocento, quando Leon Battista Alberti annotò su di un quaderno l’uso vivo del fiorentino del suo tempo, dando vita alla famosa Grammatichetta. L’intento di Alberti, con quell’operazione, era quello di inserirsi all’interno del dibattito umanistico riguardo la dignità del volgare italiano: voleva dimostrare, insomma, che la lingua volgare seguiva spontaneamente delle regole proprio come la lingua latina e per questo meritava di essere adoperata non solo in poesia, ma anche nella prosa scientifica e nei trattati. Nel Cinquecento, poi, si ebbero le prime vere e proprie grammatiche grazie a Pietro Bembo ed a Giovanni Francesco Fortunio.
Da questa prospettiva, che ci rende diretti protagonisti delle questioni linguistiche, deriva che la grammatica, per risultare più interessante, debba trasformarsi in una presa di coscienza di sé stessi piuttosto che continuare ad essere una serie di norme, spesso complesse, da apprendere meccanicamente. È pur vero, come ricorda il professore in Didattica dell’Italiano presso il Dipartimento della Formazione e dell’Apprendimento SUPSI Simone Fornara, che l’impostazione tradizionale della didattica è una conseguenza diretta del suo mercato editoriale, poco aperto a sperimentare soluzioni nuove che sovvertano la didattica di stampo tradizionale. La strategia per attuare un cambiamento sarebbe proprio quella di puntare sulla lingua interna che bambini, bambine, ragazzi e ragazze conoscono già inconsapevolmente in quanto parlanti.
Dati alla mano, i risultati dell’impostazione didattica tradizionale della grammatica non sono incoraggianti. Mirko Tavoni, professore ordinario di Linguistica italiana presso l’Università di Pisa, sottolinea che, in Italia, oltre il 70% degli studenti, sottoposti ai test dell’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo di Istruzione e di formazione (INVALSI), non sono stati capaci di riconoscere il soggetto di una frase. Ciò significa, forse, che le centinaia di pagine di cui si compongono tutte le grammatiche tradizionali non adempiono al loro compito nemmeno per un quesito che sta alla base dell’intero sistema grammaticale. Bisognerà metterlo in discussione per trovare delle soluzioni alternative? Secondo Simone Fornara e Mirko Tavoni, la risposta è sì. Occorre un cambio di paradigma, un’impostazione più moderna, più attiva, più coinvolgente. C’è speranza?
Assolutamente sì. Un gruppo di docenti della SUPSI, tra cui lo stesso Simone Fornara, si sono mossi in questa direzione con la creazione di un progetto innovativo: Sgrammit (Scoprire la Grammatica dell’Italiano nella scuola elementare). Si tratta della realizzazione di sei serie di quaderni didattici per allievi ed allieve della Scuola elementare che seguono un approccio diverso rispetto a quello tradizionale. Nel concreto, non si propongono più definizioni e regole per poi svolgere degli esercizi, bensì, al contrario, studenti e studentesse sono sottoposti a delle attività induttive attraverso cui riflettere su parole, frasi, testi per arrivare a scoprire loro stessi le regolarità grammaticali, che corrispondono alle regole tradizionali, fino ad oggi imparate a memoria. Il parlante torna in questo modo ad essere il diretto protagonista dell’analisi grammaticale, perché è egli stesso che attraverso un approccio induttivo riconosce le regole e, così, acquisisce la consapevolezza della sua centralità nello studio linguistico. La tendenza di modernizzare la didattica dell’italiano si riscontra anche in Italia. Mirko Tavoni sottolinea il grande successo del progetto Grammatica nativa: la lingua italiana nella tua mente, nell’ambito di corsi di formazioni per insegnanti, promossi dalla Fondazione Lincei per la Scuola. Invece di fare un corso di formazione fatto di lezioni teoriche, si è deciso, insieme ai docenti, di sperimentare nuovi materiali didattici che rendessero più coinvolgente, attivo e consapevole il ruolo degli studenti e delle studentesse nell’apprendimento delle regole grammaticali. Il successo di questo tipo di impostazione ha goduto di un gradimento da parte dei docenti e delle docenti, nonché degli studenti e studentesse, superiore a qualsiasi aspettativa. Ciò ha portato il progetto ad essere rinnovato per il prossimo anno scolastico.
Bisogna chiedersi, infine, se gli sforzi di modernizzazione della didattica dell’italiano siano necessari nella società di oggi. È davvero così importante la grammatica nella vita di tutti i giorni? È proprio indispensabile studiare la grammatica per riuscire a comunicare, a leggere, a scrivere? Secondo Mirko Tavoni la riflessione sulla lingua è decisiva per passare da un uso naturale ad un uso consapevole di quest’ultima, che ne aumenta la qualità e, dunque, l’efficacia. È della stessa opinione Simone Fornara: si tratta di concentrarsi sulla qualità dell’uso della lingua, perché si tratta di passare da un livello di inconsapevolezza e spontaneità ad una riflessione consapevole.
Apologia della grammatica
Alphaville 18.09.2024, 12:35
Contenuto audio