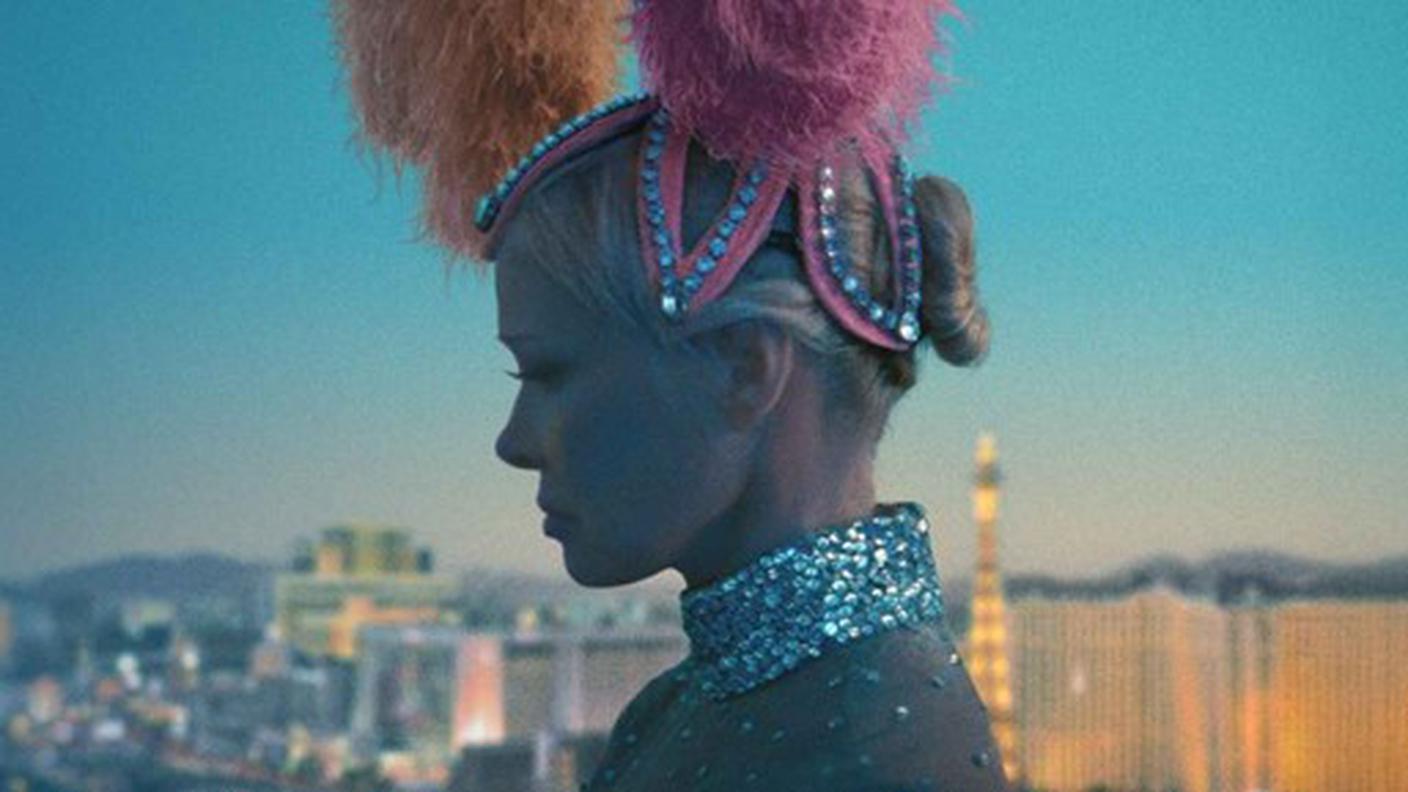Il 29 aprile del 1980 toccava a lui, moriva a Los Angeles per problemi cardiaci e renali Alfred Hitchcock. Capitava a lui di affrontare quella morte che tanto aveva indagato e raccontato e di cui si era così teneramente preso gioco in tutti i suoi film. Di lui il suo più grande estimatore, François Truffaut, ebbe a dire:
"È impossibile non accorgersi che le scene d'amore nei suoi film sono girate come gli omicidi e la scena del delitto come una scena di seduzione. Forse per Hitch amore e morte sono la stessa cosa".
Più compreso in Europa che in patria, dalla generazione successiva che dai suoi coetanei, è a Truffaut e ai Cahiers du cinéma che dobbiamo il pieno riconoscimento della sua opera e il giusto posto nell'Olimpo del cinema di tutti i tempi.
Il maestro del brivido, britannico di nascita e statunitense di adozione, se ne andava all'età di 80 anni senza aver mai conquistato un Oscar. Ma questo non ha impedito alle immagini più forti dei suoi film di rimanere più che impresse, davvero tatuate, nella nostra memoria collettiva per generazioni.
Impossibile ammirare, con lo sguardo rivolto al cielo, uno stormo di gabbiani urlanti in prossimità del mare all'ora del tramonto, senza sentire un leggero fremito lungo la schiena, un richiamo della memoria alla minacciosa e massiccia presenza aviaria che incombe sui protagonisti de "Gli uccelli" (1963). Inconcepibile entrare in un bagno con la tenda della doccia sulla vasca, senza immaginare che dietro possa nascondersi un sanguinoso e raccapricciante corpo del reato, come succede nel suo capolavoro, "Psyco" (1960). La scena della doccia, tutta costruita sul montaggio, fu girata in sette giorni e settanta posizioni di macchina, per un totale di 45 secondi di film.
Sarà che sono cresciuta a pane e cinema, ma ricordo - lo giuro - che durante un viaggio in Arizona, scesa dalla macchina, in mezzo ad una landa desolata e brulla, ho camminato per un centinaio di metri, fino a quando non mi sono sentita minacciata da un misterioso velivolo che, uscito da "Intrigo internazionale" (1959) incombeva planando sulla mia testa. Guardando in aria, non c'era nulla e io non ero Cary Grant, ma certo era meglio tornare in auto.
Come tutti i più grandi classici di tutti i tempi, le sue opere ci hanno raccontato storie che sono universali, storie che appartengono a tutti noi, un po' per aiutarci a scoprire chi siamo, ma soprattutto per rivelarci chi non immaginiamo di essere. Usando la macchina da presa con straordinaria maestria, e i set cinematografici come prosceni del teatro del quotidiano, il maestro indiscusso del brivido si è soprattutto divertito a lavorare con lo specifico cinematografico (i tagli di luce, il bianco e nero, il montaggio ardito, la musica spiazzante, gli effetti speciali semplici ma efficaci, e soprattutto costruiti ad hoc come la lampadina nel bicchiere di latte che Joan Fontaine teme sia avvelenato) per catturare la nostra attenzione e poter giocare a ping pong con il nostro inconscio.
Ricordo da bambina quanto adoravo la serie "Hitchcock presenta Hitchcock". Quando il disegno abbozzato con poche linee del suo famoso profilo si ricongiungeva con la sua ombra che si spostava sullo schermo televisivo per introdurre la sua massiccia e rassicurante figura di uomo ironico e gentile che con compostezza britannica e fare sornione avrebbe esordito con un significativo "Signore e signori, buonasera". Una indispensabile e rassicurante premessa per stabilire un patto con noi, non ci avrebbe fatto del male, ma noi avremmo dovuto consegnargli le nostre paure. Ci avrebbe raccontato una storiella divertente con il suo humor very british, opportuno viatico per entrare con animo leggero nel tunnel degli orrori dell'umana crudeltà, che ogni episodio del telefilm andava restituendoci. Del resto il grande maestro del mistero ebbe a dire che la serie televisiva voleva "riportare il crimine in casa, dove esso risiede".
Non sono crimini dei bassifondi degradati delle grandi città americane quelli che i suoi film costruiscono, ma crimini borghesi, nati dal banale dipanarsi delle nostre piccole vite che scorrono tragicamente simili, le une alle altre. Crimini, lo sappiamo assai bene, sempre attuali ieri come oggi.
Ma è da "La finestra sul cortile" (1954) che riceviamo il più illuminante e appassionato messaggio che il regista indirizza a noi spettatori, estasiati ammiratori della sua opera imperitura.
"O signore, siamo diventati una razza di guardoni. La gente farebbe meglio a guardare a casa propria, tanto per cambiare". Così Stella, l'infermiera che assiste a domicilio il fotoreporter Jefferies, commenta la nuova occupazione del protagonista che, bloccato in casa con una gamba ingessata, frustrato e avvilito per non poter uscire e tornare a fare il suo lavoro sul campo, si diletta ad osservare il vicinato dalla finestra. In quello che è tra i film più geniali di Hitchcock, troviamo il protagonista (James Stewart) assumere i panni dell'alter ego del regista. Nel film, che è la più straordinaria apoteosi della soggettiva nella storia del cinema, lo sguardo sul mondo (il cortile a cui si affacciano le sue finestre e l'edificio prospiciente) è ossessivo e voyeuristico. Impossibilitato a muoversi, il protagonista sublima facendo viaggiare la fantasia, costruendosi una storia, una sua narrazione, una trama avvincente di cui ha vitale bisogno. E in questo modo, quasi inconsapevolmente, trasforma il suo sguardo e la smania di verità nello sguardo di un "guardone".
Il monito di Hitchcock allo spettatore, anch'egli nella stessa condizione del regista, entrambi come il protagonista bloccati su una sedia ad assistere allo spettacolo della vita che scorre davanti ai loro occhi, è preciso: attento guardone, attento a ciò che guardi e a ciò che deduci da ciò che guardi. Il gioco della rappresentazione cinematografica è affare pericoloso, se hai una gamba rotta, rischi di romperti anche l'altra. Il più ironico e solido monito di un genio del cinema a tutti noi, figli della società dell'immagine.
Aveva paura della Polizia
In occasione di un suo passaggio in Svizzera, il 3 dicembre 1972, Enrico Mazzega incontrava il regista a Zurigo. In quell'occasione il Hitchcock parlò della paura: della sua notissima paura per la Polizia e della paura che il suo pubblico si diverte a provare guardando i suoi film.
La paura secondo Hitchcock, RSI 1972
RSI Cultura 28.04.2020, 00:45