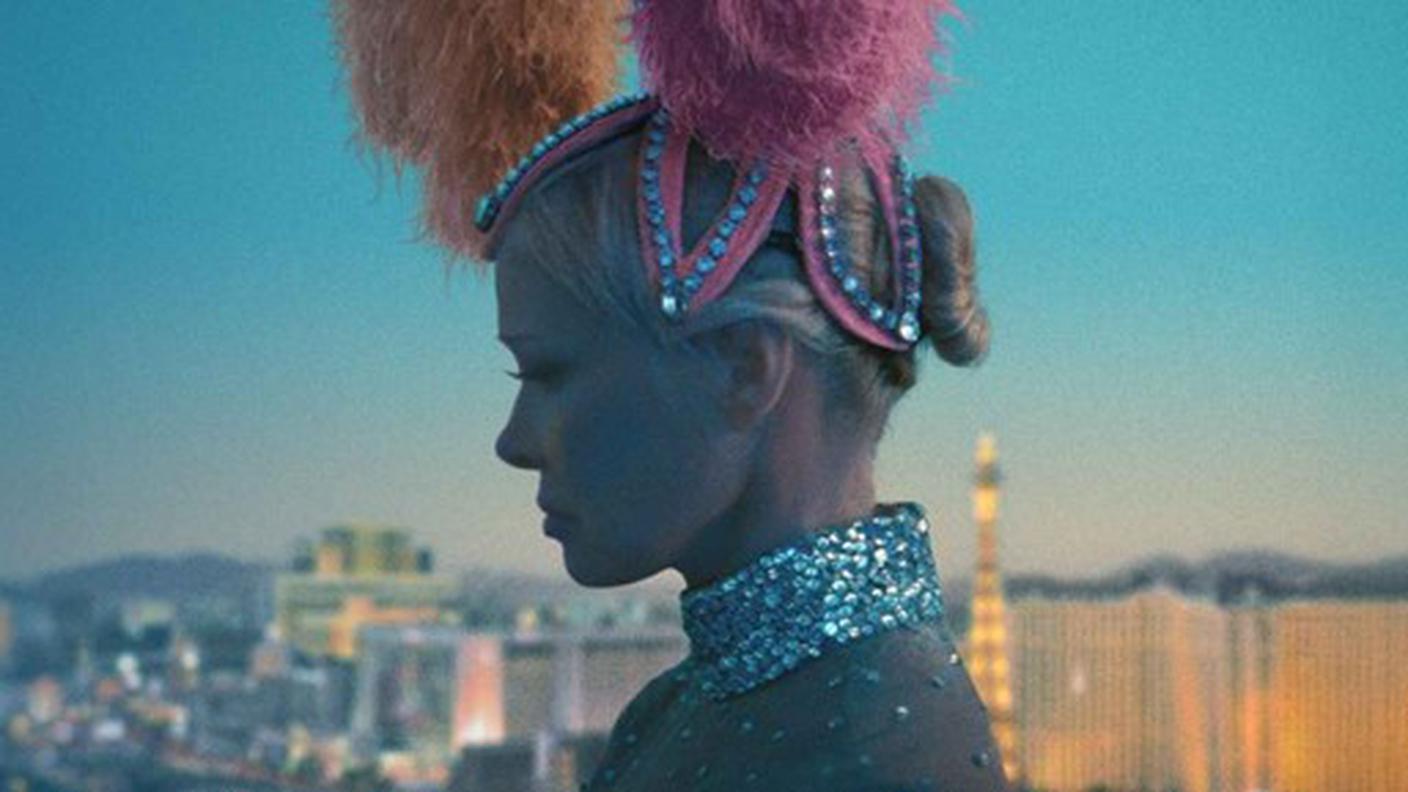Era il 1962 quando Dino Risi alla regia, Scola e Maccari alla sceneggiatura, Gassmann e Trintignant in scena con Cathrine Spaak, uscirono nelle sale con il film culto della cinematografia italiana e mondiale.
Il Sorpasso racconta l’Italia del boom economico. Lo fa a bordo di una Lancia Aurelia decapottabile, anticipando il filone del road movie (tanto che Easy Rider viene spesso considerato un suo remake). Ma non è un film alla On the road di Kerouac, come ci abitueranno le pellicole inneggianti alla libertà e all’emancipazione sessantottina.
Qui ci troviamo in un’Italia ancora fortemente intrisa di un moralismo benpensante. Le scorribande si svolgono tra le strade del centro Italia, connotate ancora da una civiltà contadina e patriarcale.
Eppure nell’aria già aleggiano i venti del cambiamento. Le musiche rock'n'roll iniziano a circolare tra i giovani, e la grande rivoluzione musicale e sociale, in corso oltreoceano, inizia a diffondersi fra i borghi del Bel Paese, in cui si respira voglia di festa e divertimento.
Bruno Cortona (il protagonista del film, interpretato da Vittorio Gassman) è l'uomo del boom economico, della spensieratezza, dell'ottimismo. Il suo motto è divertirsi. Ma Cortona non è un univoco. Sebbene venga spesso etichettato come la personificazione del cialtrone, del cinico e del fanfarone, nel suo sguardo c’è un sorriso tagliente, come di chi sa che non c’è peggior menzogna della menzogna della gioia. E così accanto alla gioia di vivere, di “rimorchiare”, di bere e dimenticare, Cortona nel corso del film mostra anche un lato triste e malinconico. Il dolore di vedere la figlia crescere senza di lui, l’assenza di amicizie vere, durature, minano la sua spiensieratezza, sino a fargli confessare una sua profonda alienazione:
"A me Modugno mi piace sempre, questo "Uomo in frac" me fa impazzi’, perché pare ‘na cosa de niente e invece c'è tutto: la solitudine, l'incomunicabilità, poi quell'altra cosa, quella che va di moda oggi... la... l'alienazione, come nei film di Antonioni”.
Non solo Modugno fa da colonna sonora del film, ma molte hits del momento, canzoni che concorrono a ricreare l’atmosfera di quegli anni, così come molti oggetti, dai telefoni a gettoni ai giradischi. Ed è proprio accanto ad un telefono a gettoni che Bruno Cortona incontra il suo compagno di viaggio, Roberto Mariani (Jean-Louis Trintignant). Un giovane a modo, laureando in giurisprudenza, timido, candido ed introverso. I due si incontrano per caso, e si avvicinano poiché attratti dalla loro lontananza, lontananza che diventa una calamita.
Roberto accetta di salire a bordo della Lancia Aurelia, che lo porta in un mondo fatto di euforia e follia contagiose. A tratti cerca di resistere a questa calamita, ripromettendosi di tornare agli studi accademici, ma la vita di Bruno lo entusiasma e avvinghia come qualcosa di inedito. Roberto scopre il divertimento, le donne e le feste: un nuovo modo di vivere che lo coinvolgerà come un’ossessione.
Emblema di questo nuovo modo di vivere è il sorpasso, meglio se su riga continua, che Bruno Cortona mette in atto a più riprese e che Roberto vive come una sorta di emancipazione dalle regole del buon costume e del buon comportamento. La nuova via è la via della sopraffazione, dell’irresponsabilità, dell’euforia, che non si cura degli altri, ma li sbeffeggia nel gesto delle corna.
L’incontro fra Bruno e Roberto è l’incontro fra gli antipodi. Da un lato c’è il trasgressore pronto a dare un calcio alla morale, dall’altro lo studente modello, erede di una formazione pregna di cattolicesimo, che da questo incontro riesce a trovare la forza per vincere la timidezza e confessarsi alla ragazza che ama.
Le sfrecciate sulle strade d’Italia ci consegnano un film a metà strada fra idillio e disillusione, fra rinascita e precipizio. Ed è proprio su questa ambivalenza che si chiude la pellicola, con un ennesimo sorpasso, un ennesimo affronto alla morale e ai pregiudizi, un sorpasso dall'esito sconvolgente.
L’uomo della spregiudicatezza e della sopraffazione sopravanza, mentre il giovane dai principi morali soccombe.
Non si tratta di moralismo, ma di una cruda fotografia del corso degli eventi: la grande euforia e la chimera del benessere cui tutti hanno pensato di partecipare nel dopoguerra, sarà appannaggio di pochi. Il boom economico sarà accompagnato da un decadimento morale che il regista condenserà in una frase emblematica: “quando tutti hanno finito di comprare tutto, eccoci qui, eccoci nella profonda depressione”.