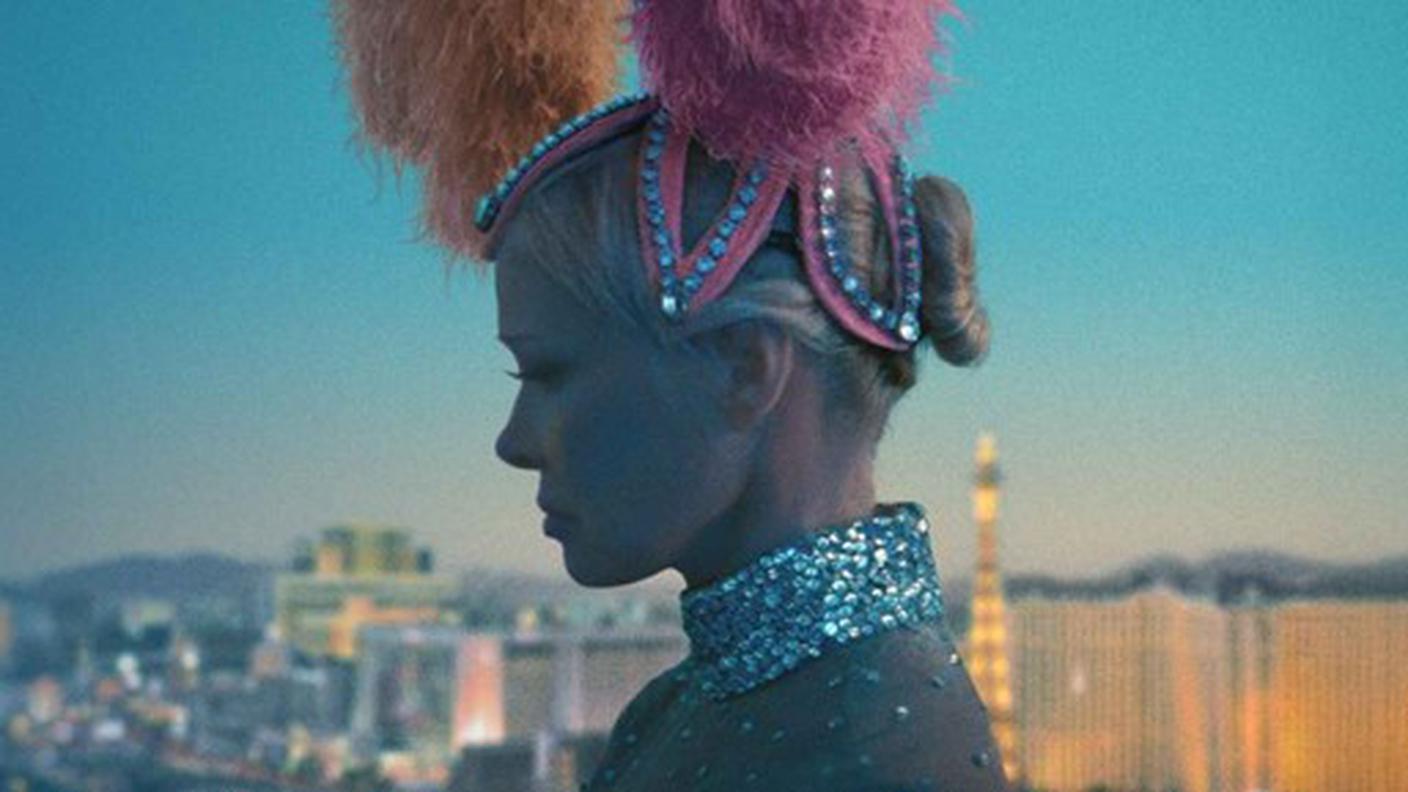Ken Loach, nato il 17 giugno 1936, non ha perso la capacità di indignarsi, anche perché la società in cui viviamo non ha smesso di dargliene motivo. I problemi cambiano veste, ma continuano a ripresentarsi sotto gli occhi del regista inglese, sempre bene aperti quando si parla di sfruttamento della classe lavoratrice. Se una volta questa si concentrava nelle fabbriche, oggi vive le insidie e le incertezze della gig economy. I nuovi modelli di lavoro accessorio, di lavoro su chiamata, il miraggio del “sii tu stesso il tuo capo”, per tanti lavoratori spesso si traducono solo nell’assenza di tutele e in giornate massacranti i cui ritmi sono dettati da impietosi strumenti tecnologici. È il caso di Ricky, protagonista di Sorry We Missed You, un autista fattorino freelance che nell’ultimo, lucidissimo film di Ken Loach, consegna pacchi 14 ore al giorno mentre nel tentativo di arrivare a fine mese vede la sua famiglia andare in frantumi.
L’attenzione di Loach per chi quotidianamente deve lottare per stare a galla in un sistema che ieri come oggi concede poco a molti, è qualcosa che viene da lontano e che ha caratterizzato coerentemente tutta la sua carriera, iniziata negli anni Sessanta come regista televisivo. Assorbita la lezione del Free Cinema e del documentario sociale, Loach si concentra sin da subito sulla realtà quotidiana della working class. Il suo cuore batte a sinistra e della sua militanza politica non ha mai fatto mistero. Insieme al produttore di allora Tony Garnett, realizza una decina di episodi di The Wednesday Play, serie antologica della BBC, considerata un banco di prova per nuovi autori. Esordisce sul grande schermo nel 1967 con Poor Cow, film figlio di uno degli episodi di maggiore impatto di The Wednesday Play, intitolato Cathy come Home, storia di una giovane coppia e della sua discesa nella povertà più nera. Quello di Loach, fin dagli esordi, è un cinema realistico. Anche un film come il successivo Kes, sotto quella che a prima vista può sembrare una sorta di favola (senza lieto fine) sul legame tra un adolescente e un piccolo rapace, in realtà fotografa la durezza della vita dei sobborghi, il bullismo vissuto a scuola, le difficoltà del crescere in un ambiente disagiato.
Negli anni Settanta e Ottanta, mentre il cinema inglese vive fasi di declino e risalita, i film di Loach hanno una scarsa distribuzione e il regista continua a lavorare anche per la televisione, benché alcune sue opere, come un documentario del 1984 sullo sciopero dei minatori, non vengono trasmesse, altre censurate perché troppo politicamente sbilanciate nel decennio dominato dalla figura di Margaret Thatcher. Negli anni Novanta però, si apre per lui una seconda giovinezza, una fase durante la quale firma alcuni dei film che più lo rappresentano. Riff-Raff (1991), Piovono pietre (1993), Ladybird Ladybird (1994) o My Name is Joe (1998) raccontano di solidarietà fra disperati alle prese con le storture del sistema, puntano impietosamente il dito contro i paradossi di istituzioni e servizi sociali malfunzionanti, mettono a fuoco un mondo di invisibili – disoccupati, alcolisti, donne ferite – a cui Loach sente il bisogno inarrestabile di dare voce. È un cinema che per raccontare simboliche finzioni usa stilemi documentaristici e dove a fianco di professionisti come Robert Carlyle o Peter Mullan trovano spesso spazio anche attori non professionisti che danno prove estremamente incisive. Anche la scelta propria di Loach di girare le scene dei suoi film in ordine cronologico, lasciando che gli interpreti scoprano la storia mentre questa si sviluppa, fa parte di una impostazione aderente alla realtà.
Il cinema di Loach non è però riducibile esclusivamente alla denuncia sociale. Oltre al preciso ritratto del contesto in cui le storie sono calate, vi si ritrova l’attenzione per il singolo, per l’individuo in quanto tale. Certo, le problematiche emergono sempre chiaramente. “Ma alla fine tutto questo non conta a meno che il pubblico non creda alle persone che vede sullo schermo, non le abbia a cuore, non sorrida con loro, non condivida i loro problemi. Sono le loro esperienze vissute, riconosciute come autentiche, che dovrebbero toccarci”.
I toni con cui Loach racconta queste esperienze cambiano. Ora il piglio è tragicomico come in Il mio amico Eric (2009), in cui ha diretto la stella del calcio Eric Cantona, o ne La parte degli angeli (2012). Ora il registro è puramente drammatico, talvolta ha degli elementi sentimentali. Ma è sempre un racconto lucido della realtà. Di solito si tratta della realtà più vicina al regista, quella dei quartieri popolari di città e cittadine britanniche. Ma Loach nel corso della sua carriera si è confrontato anche con la Storia, come nel racconto della Guerra di Spagna di Terra e libertà (1995), ne Il vento che accarezza l’erba (2006), film – con cui ha conquistato la sua prima Palma d’oro a Cannes – ambientato durante la guerra d’indipendenza e la guerra civile d’Irlanda nei primi decenni del Novecento, o ancora con Jimmy’s Hall (2014) dove è ritornato a queste atmosfere. A firmare la sceneggiatura degli ultimi due è Paul Laverty, con cui Loach, a partire da La canzone di Carla nel 1996, ha dato vita a un sodalizio artistico, solidissimo e ultraventennale, che ha portato a film come Sweet Sixteen (2002) o al più recente Io, Daniel Blake, straziante ritratto di un brav’uomo costretto a lasciare il lavoro, schiacciato da un sistema assistenziale distorto e da una burocrazia impersonale, con cui Loach ha conquistato la sua seconda Palma d’oro al Festival di Cannes nel 2016. Il Festival francese è stato quello che in maggiore misura e per primo ha incoronato Loach, che oltre ai due massimi riconoscimenti ha conquistato sulla Croisette anche tre Premi della Giuria (L’agenda nascosta nel 1990, Piovono pietre e La parte degli angeli) e tre Premi FIPRESCI (Black Jack nel 1979, Riff-Raff e Terra e libertà). Ma anche gli altri Festival gli hanno tributato onori, con il Leone e l’Orso d’oro alla carriera assegnatigli rispettivamente nel 1994 e nel 2014 dalla Mostra di Venezia e dalla Berlinale e con il Pardo d’onore (2003) e il Premio del pubblico del 2016 vinti a Locarno.
Conversation with Ken Loach
RSI Vita quotidiana 13.08.2016, 11:29
Un articolo dell’edizione online del Guardian si è chiesto che fine farà, dopo Loach, il cosiddetto cinema del realismo sociale inglese, visto che all’orizzonte non sembrano vedersi veri successori. Benché già nel 2014 abbia annunciato la volontà di ritirarsi e ogni tanto gli venga da pensare che quello appena finito sia il suo ultimo film, forse però per Loach non è ancora tempo di andare in pensione. No, il regista nato nel 1936 a Nuneaton nelle Midlands occidentali, che ha studiato diritto ad Oxford prima di essere arruolato dalla BBC e che nella sua carriera cinematografica ha firmato quasi una trentina di film, continua a preoccuparsi, a indignarsi e a catturare la realtà. Perché c’è sempre qualche storia che parla di persone e di diseguaglianze che a gran voce lo richiama al lavoro.