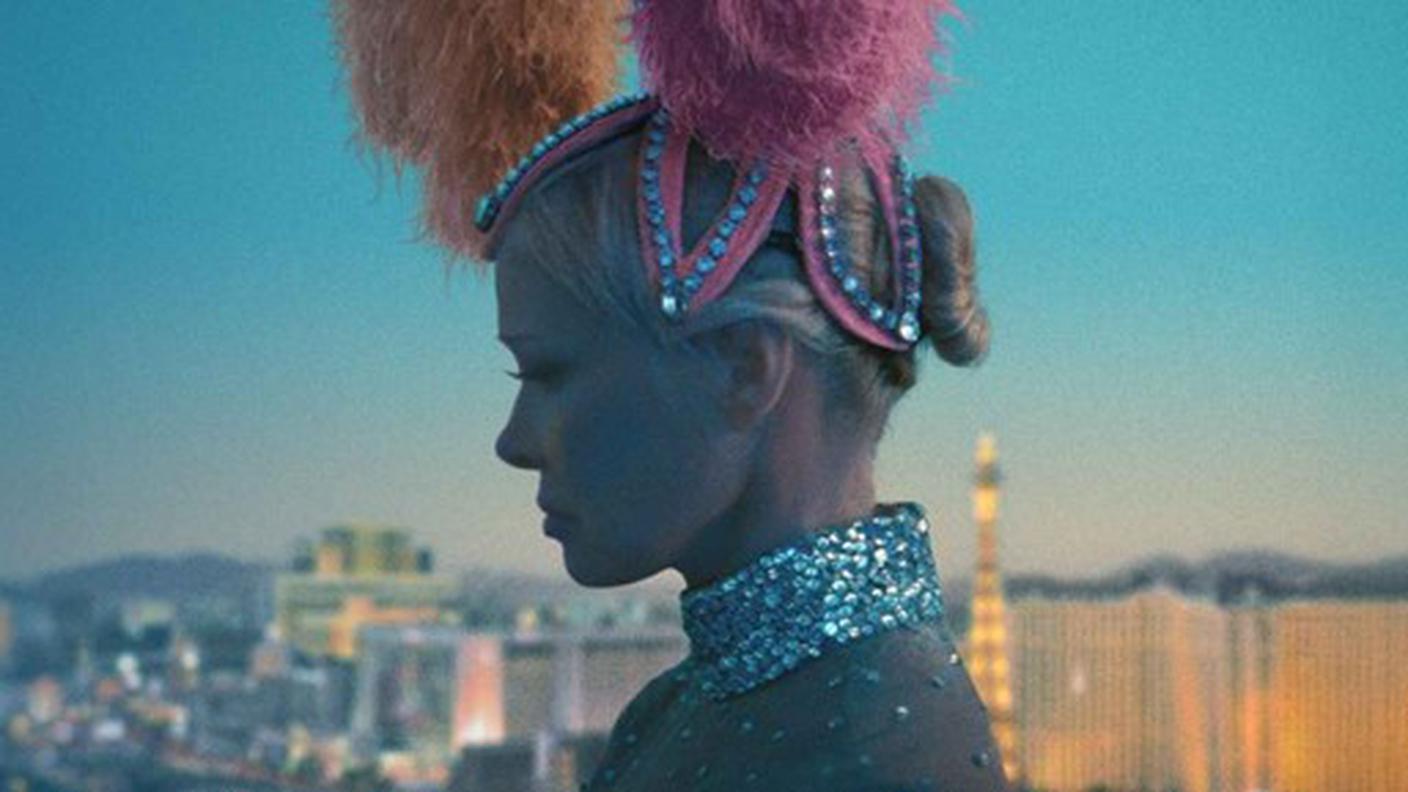Nel 2023 Wes Anderson forse ha esagerato.
Ha presentato un nuovo film a Cannes, Asteroid City, probabilmente uno dei lungometraggi con il più alto numero di star e celebrità mai raggruppato in un’unica pellicola. È protagonista di una mostra alla Fondazione Prada di Milano, che già ospita un bar da lui arredato. È sbarcato anche su Netflix, la piattaforma più diffusa ed utilizzata, con quattro cortometraggi tratti dai racconti di Roald Dahl, tra i più famosi scrittori di romanzi per ragazzi del Novecento.
Quest’abbuffata potrebbe indurre ad una specie di indolenza nei confronti del regista statunitense e ad una lettura superficiale del suo cinema, divenuto molto riconoscibile e riproducibile. Eppure è proprio in questo incrocio temporale di produzioni e progetti che emerge l’unicità di un regista che ha capito come navigare il mercato e che contemporaneamente ha intrapreso la sua fase più sperimentale, intrecciando linguaggi diversi - cinema, teatro, letteratura - con risultati eccellenti, che in molti vorrebbero ottenere ma nessuno riesce davvero a eguagliare.
I quattro preziosi cortometraggi commissionatigli da Netflix - nuova proprietaria della Roald Dahl Story Company, acquistata per 686 milioni di dollari - permettono ad Anderson, che aveva già lavorato sull’opera di Dahl con il riuscitissimo lungometraggio in stop motion Fantastic Mr. Fox (2009), di approfondire il gioco di scatole cinesi già presente nel suo cinema ma esploso completante con Grand Budapest Hotel (2014) e portato a nuovi livelli di sperimentazione in Asteroid City. La rottura della quarta parete, la figura del narratore interno, gli incastri tra storie differenti sul modello di opere monumentali come Le mille e una notte, le scenografie modulabili, il ruolo dell’attore che diventa quasi un cantastorie a cui è richiesto di interpretare più protagonisti: sono innumerevoli i giochi che Anderson utilizza per affinare e tributare, una volta di più, l’arte del racconto, esplorando contemporaneamente gli ampi spazi, stavolta piuttosto cupi, dell’animo umano (Il Cigno è tra questi la storia più dura e allo stesso tempo affascinante).
Il fatto che tutto questo lavoro trovi espressione in una serie di cortometraggi (durano tutti circa 17 minuti salvo La meravigliosa storia di Henry Sugar, presentato a Venezia, che ne dura 40 ed è in effetti il lavoro esteticamente più raffinato), rende ancora più interessante un’operazione coraggiosa, merce rara soprattutto sulle piattaforme di streaming.