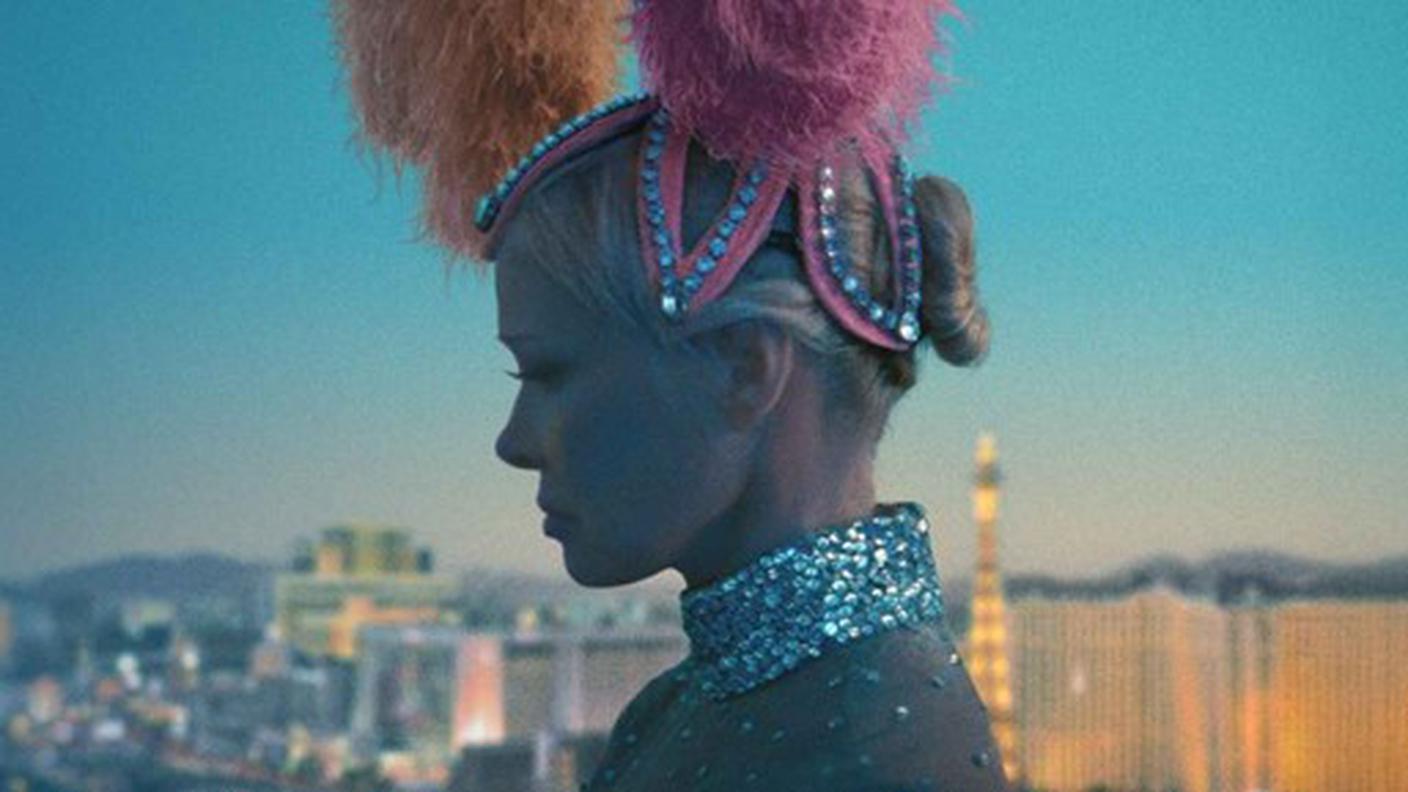Certo, le prime dei film di Hitchcock rimangono imbattibili. Tipo. A quella di Psycho, gli spettatori gridavano e fuggivano dalla sala; per quella di Gli uccelli, erano stati predisposti altoparlanti che trasmettevano grida di volatili, nascosti tra gli alberi all’uscita del cinema (Hitchcock era un genio del marketing).
Ma anche Sam Peckinpah si difendeva: alla prima del Mucchio selvaggio, maggio 1969 al Royal Theater di Kansas City, tra i cinquecento presenti si segnalarono spettatori fuggiti dal teatro, mentre altri addirittura finirono a vomitare nel vicolo adiacente. Pare che Peckinpah quella sera fosse davvero felice, e lo rimase anche quando qualcuno si avvicinò minacciando di denunciarlo alle autorità, affinché quel film tanto violento e pieno d’odio fosse ritirato dalla circolazione. Il suo geniale montatore, Lou Lombardo, ha raccontato che quella sera il regista gli disse qualcosa come: «Vogliono andarsene, ma non ci riescono! Non riescono a distogliere lo sguardo… e questo li fa impazzire». La violenza di uno dei film più meravigliosi della storia di Hollywood aveva provocato reazioni altrettanto violente, insomma. E continuò a farlo, anche tra i critici.
Judith Christ, storica giornalista cinematografica del New York Magazine, scrisse: «Se volete andare a vedere Il mucchio selvaggio, assicuratevi di portare con voi un sacchetto per il vomito». Roger Ebert invece parlò di capolavoro, mentre Time scrisse che Peckinpah era uno dei migliori registi della sua generazione, insieme a Stanley Kubrick.
Al di là delle diverse opinioni, possiamo dire che Peckinpah sicuramente fosse molto diverso da Kubrick. E possiamo dire che sia l’ultimo mito del cinema del Novecento cinematografico americano, anche nel senso che oggi nessuno potrebbe difendere quell’uomo che si era costruito attorno un personaggio misantropo, nichilista, impresentabile per gli standard del nostro secolo. I tratti principali sono noti: grandi passioni per l’uso smodato di alcol e per la prostituzione, figlie del suo periodo passato con i marines nella Cina del dopoguerra; l’apprendistato a bottega dal maestro dei B-movie Don Siegel (il mai troppo celebrato genio dietro L’invasione degli Ultracorpi e, più tardi, la serie dell’ispettore Callaghan con Clint Eastwood); il carattere fumantino che lo portava a litigare con quasi tutti i produttori che avevano la sfortuna di incrociare i suoi passi; l’aggiunta della cocaina alle altre dipendenze, arrivata negli anni Settanta.
Riguardo all’impresentabilità, di citazioni ce ne sono a bizzeffe. Ne prendo una da un’arcinota intervista a Playboy dei primi Settanta, traduzione di Valerio Caprara nel suo (ormai assolutamente vintage nell’edizione Il castoro) saggio su Peckinpah: «Il basilare atto maschile, secondo la sua vera natura, comincia con un atto di aggressione fisica, non importa quanto amore ci sia eventualmente espresso, e per la donna inizia con un atto di passività e sottomissione. È un fatto fisico. Di’ questo a una qualsiasi del Movimento di Liberazione della donna, e lei giurerà che sei un porco maschio sciovinista». E dunque ecco Peckinpah caricatura di sé stesso (vero), maschilista (assai probabile, almeno per gli standard del 2025), perfino fascista (falso: più corretto dire che era un “anarchico anacronistico”, come fa Marzia Gandolfi sull’ultimo numero del settimanale italiano FilmTV). Così, negli anni Settanta Peckinpah è stato abbandonato, o forse si è fatto abbandonare (spero che non suoni come una sorta di vittimizzazione secondaria), dai suoi sostenitori, per poi essere rivalutato tra gli anni Ottanta e Novanta, fino a diventare culto e venerato maestro post-mortem.
Oggi sappiamo che senza il suo modo rivoluzionario di trattare la violenza per raccontare l’uomo – americano in particolare, maschio in particolare – non avremmo avuto parti importanti di Scorsese, Coppola, Cimino. Quentin Tarantino non lo citiamo neanche, perché è troppo ovvio. Ma sappiamo soprattutto che il suo lascito più influente nei confronti del cinema dei nostri anni è fatto di grandi idee tecniche, che sono state fatte esplodere da nuovi cineasti capaci di sfruttarle insieme alle ultime tecnologie.
Infatti, che il montaggio peckinpah-iano sia stato rivoluzionario quanto quello ejzenštejniano, è pacifico. La sua capacità di gestire le immagini di cinque o sei macchine da presa che giravano contemporaneamente, da punti di vista diversi e a velocità diverse (24, 32, 48, 96 fotogrammi al secondo), ha gettato le fondamenta per tante sequenze cubiste del cinema d’azione americano contemporaneo, da Michael Bay in giù (decidete voi se è un bene o un male). Senza il suo uso del ralenti alternato a improvvise accelerazioni, non avremmo mai visto Matrix.
Eppure, nonostante la tecnica cinematografica sia fondamentale nel cinema di Peckinpah, i suoi film rimangono tutt’altro che distaccati dalla realtà: sono, al contrario, viscerali, e pieni di un disagio che spesso diventa quasi fisico per lo spettatore. Sono portatori di un messaggio – prima estetico, poi di contenuto – che scandalizza. In un senso però altissimo, quello di sdegno nei confronti di una realtà inaccettabile, di un’America che svilisce ogni sogno, invece di coltivarlo. In ogni pellicola di Peckinpah c’è un momento (di solito, più di uno) in cui il romanticismo si specchia – e viene spazzato via – dall’unico amore coltivato dall’uomo nel corso della storia: quello per la violenza. Ma ancora una volta, i suoi non sono film a tesi, non ci sono messaggi a senso unico: basta pensare all’ideale di mascolinità tradizionale, sempre presente, ma sempre percorso da dubbi, che diventano angosce sfibranti. Scrive David Weddle nella sua arcinota biografia Se si muovono… falli secchi (in italiano da Minimum Fax), che Peckinpah non offre «grandi conclusioni sul conto dell’uomo che, desideroso del paradiso, corre a tutta velocità verso l’inferno, né soluzioni per un’umanità sprofondata nella colpa, né cartine stradali che ci indichino come essere riammessi nelle nostre stesse case, liberi dal peccato. Dovremo trovare da soli il cammino per arrivarci». Oggi avremmo bisogno di Google Maps invece che di una mappa, ma a parte questo – cent’anni dopo la nascita di Sam Peckinpah, a quaranta dalla morte – il senso del discorso, e del suo cinema, è ancora lì.

Ah, come passa il tempo...
Il divano di spade 22.02.2025, 18:00
Contenuto audio