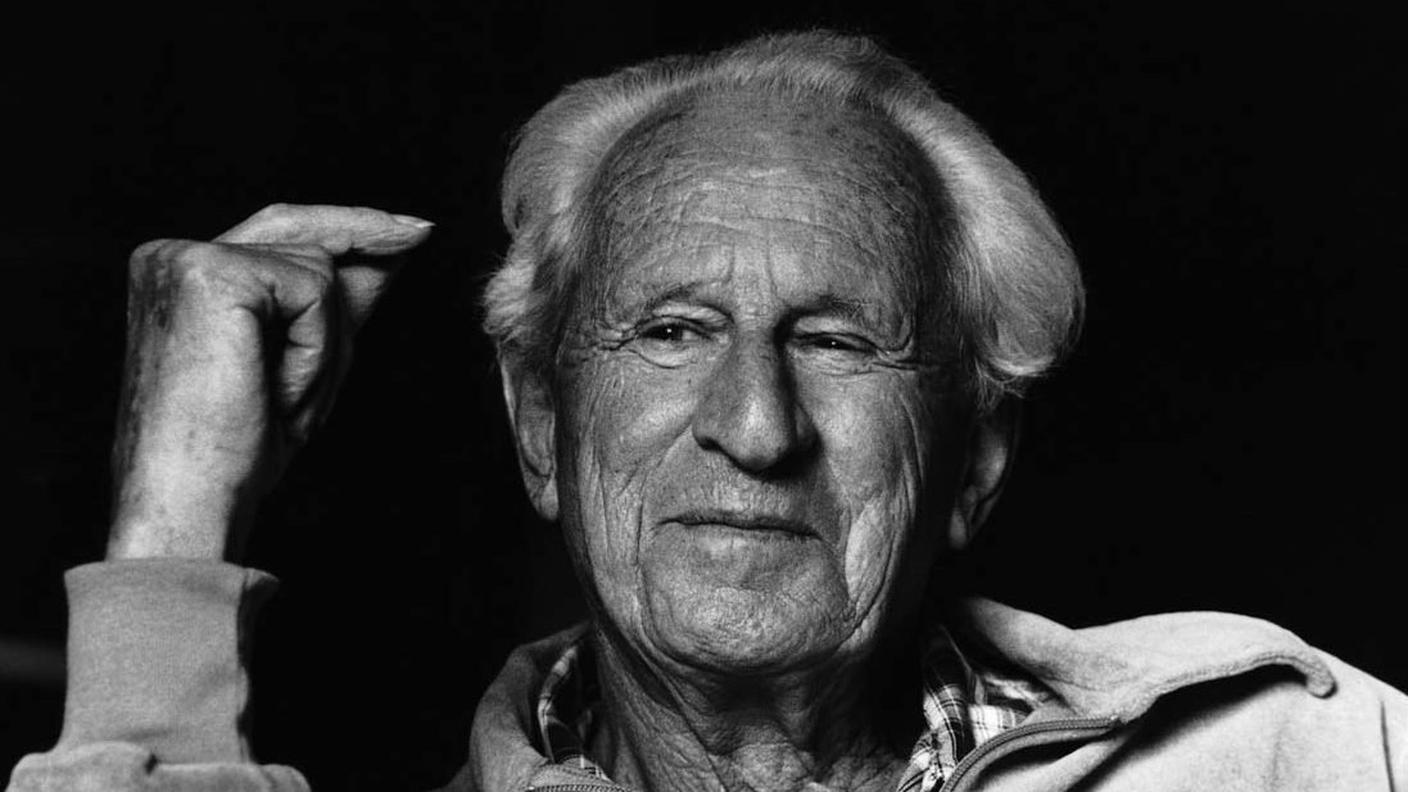Ricordo come se fosse ieri quando, da ragazzina, quando ho chiesto di prendere un analgesico per il dolore delle mestruazioni, mi è stato detto: «Gesù Cristo è morto in croce, tu puoi sopportare un po’ di mal di pancia».
Anche senza scomodare la religione o Gesù Cristo in persona per questioni tutto sommato modeste — tipo i crampi mestruali di un’adolescente — questo resta solo uno dei mille esempi che ognuno di noi potrebbe pescare dal proprio archivio mentale. Perché pare che in questa società occidentale e cristiana il dolore e la fatica non solo siano inevitabili, ma necessari. Come se soffrire facesse curriculum.
La verità è che la retorica del sacrificio e della fatica permea ogni aspetto della nostra vita, dallo studio alla malattia, dallo sport al parto, dal lavoro, alle relazioni, all’aspetto fisico.
È profondamente radicata la narrazione che il sacrificio e il dolore sono virtù necessarie, soprattutto per donne e altre categorie marginalizzate. «Crediamo erroneamente che, in un sistema capitalistico, il duro lavoro ci garantisca il successo», scrive l’artista, attivista e teologa Tricia Hersey (Riposare è resistere. Un manifesto, Atlantide, 2024). In questa cornice, sacrificio e dolore sono prova della statura morale di una persona. Tramandiamo l’idea che il carattere si forgia attraverso la sofferenza, le rinunce sono la prova del nostro impegno, e che il successo è tanto più meritato quanto più arduo è stato il percorso per ottenerlo. Tacchi a spillo e chirurgia plastica per raggiungere ideali di bellezza imposti; diete da fame e allenamenti sportivi stremanti per avere corpi conformi alla norma; violenza ostetrica perché è “naturale” partorire con dolore; metodologie didattiche basate su premi e punizioni; invalidazione del dolore (soprattutto femminile) come “normale”, “comune”, “ovvio”; violenza domestica perché tutte le relazioni sono difficili ed è doveroso cercare di resistere in nome di un impegno preso o “per la prole”: questi sono solo alcuni esempi di quanto sia pervasiva la retorica del dolore e del sacrificio in ogni aspetto della nostra vita.
Il dolore, dal punto di vista evolutivo, esiste come allarme di qualcosa che non va, ed è importante riconoscerlo e conoscerne l’utilità in determinati contesti (Siri Leknes, Brock Bastian, The Benefits of Pain, in “Review of Philosophy and Psychology”, vol. 5, n. 1, 2014). Ma molti studi dimostrano che dolore e stress prolungati hanno effetti dannosi sulla salute mentale e sul funzionamento cerebrale. Un’esposizione prolungata a fattori stressanti innesca il rilascio di cortisolo, adrenalina e noradrenalina. Questi ormoni sono essenziali in situazioni di pericolo, ma la loro presenza elevata e costante può causare infiammazioni e disfunzioni cerebrali, influenzando negativamente l’umore e la memoria. Aumenta il rischio di sviluppare condizioni neurologiche come demenza, depressione, mal di testa, emicrania e ictus. A livello cognitivo, si possono presentare annebbiamento mentale, problemi di memoria, difficoltà a prendere decisioni e a concentrarsi. A livello emotivo, si presentano ansia, depressione, irritabilità. (per esempio, Kenneth Blum, The Impact of Chronic Stress on Brain Function and Structure, in “Neuroscience and Psychiatry: Open Access”, vol. 7, n. 5, 2024; Johns Hopkins Medicine, Worldwide Study Finds High Rates of Depression and Anxiety in People with Chronic Pain, in “ScienceDaily”, 2025).
Eppure il dolore femminile è normalizzato, anche da noi donne: «Ho avuto mal di testa per anni. [...] Solo quando mio marito ha cercato un rimedio per un suo sporadico mal di testa mi sono resa conto che quel giorno, eccezionalmente, io non lo avevo», racconta Soraya Chemaly (La rabbia ti fa bella, HarperCollins, 2018). «Ho finito per rassegnarmi a ciò che gran parte delle donne non solo fa, ma è anche incoraggiata a fare: convivere con il dolore e con il disagio». Il dolore delle donne è spesso minimizzato e ignorato, e i ruoli di genere e gli stereotipi razziali danno forma a questo dolore (Anke Samulowitz, Ida Gremyr, Erik Eriksson, Gunnel Hensing, Brave Men” and “Emotional Women”: A Theory-Guided Literature Review on Gender Bias in Health Care and Gendered Norms Towards Patients with Chronic Pain, in «Pain Research and Management», 2018).
Dal punto di vista didattico, è dimostrato che approcci incentrati sul benessere e sul gioco sono più efficaci rispetto a quelli tradizionali (per esempio, Xiaoyan Li, Marjaana Kangas, A Systematic Literature Review of Playful Learning in Primary Education: Teachers’ Pedagogical Activities, in “Education 3-13”, 2024; Paraskevi Mikrouli, Katerina Tzafilkou, Nicolaos Protogeros, Applications and Learning Outcomes of Game Based Learning in Education, in “International Educational Review”, vol. 2, n. 1, 2024).
E allora, se la mentalità del “no pain, no gain” (“niente dolore, niente guadagno”) ha impatti negativi sulla salute fisica e mentale, perché è così radicata nella nostra società?
Perché, se la mettiamo in discussione, mettiamo in discussione la stessa “società del successo” capitalista. Inoltre, credere che il sacrificio sia necessario giustifica l’oppressione di comunità marginalizzate, e aiuta a mantenere strutture di potere ineguali e inique.
«Mettere al centro il riposo, i pisolini, il sonno, un ritmo di vita più lento e il tempo libero in un mondo capitalista, suprematista bianco, abilista, patriarcale significa vivere come reietti», scrive Hersey (Riposare è resistere). «Il “successo” che questa cultura promuove si incentra su costante fatica, ricchezza materiale e superlavoro come cose di cui vantarsi».
Abbiamo bisogno di un cambiamento di prospettiva per costruire una società non solo più sana e felice, ma anche più giusta ed equa. Una società in cui la realizzazione personale non è un risultato da ottenere attraverso la sofferenza e il sacrificio, ma attraverso la resilienza e la cura di sé e della comunità.
https://rsi.cue.rsi.ch/rete-due/programmi/cultura/geronimo/Filosofia/Ripensare-il-sacrificio--1079097.html