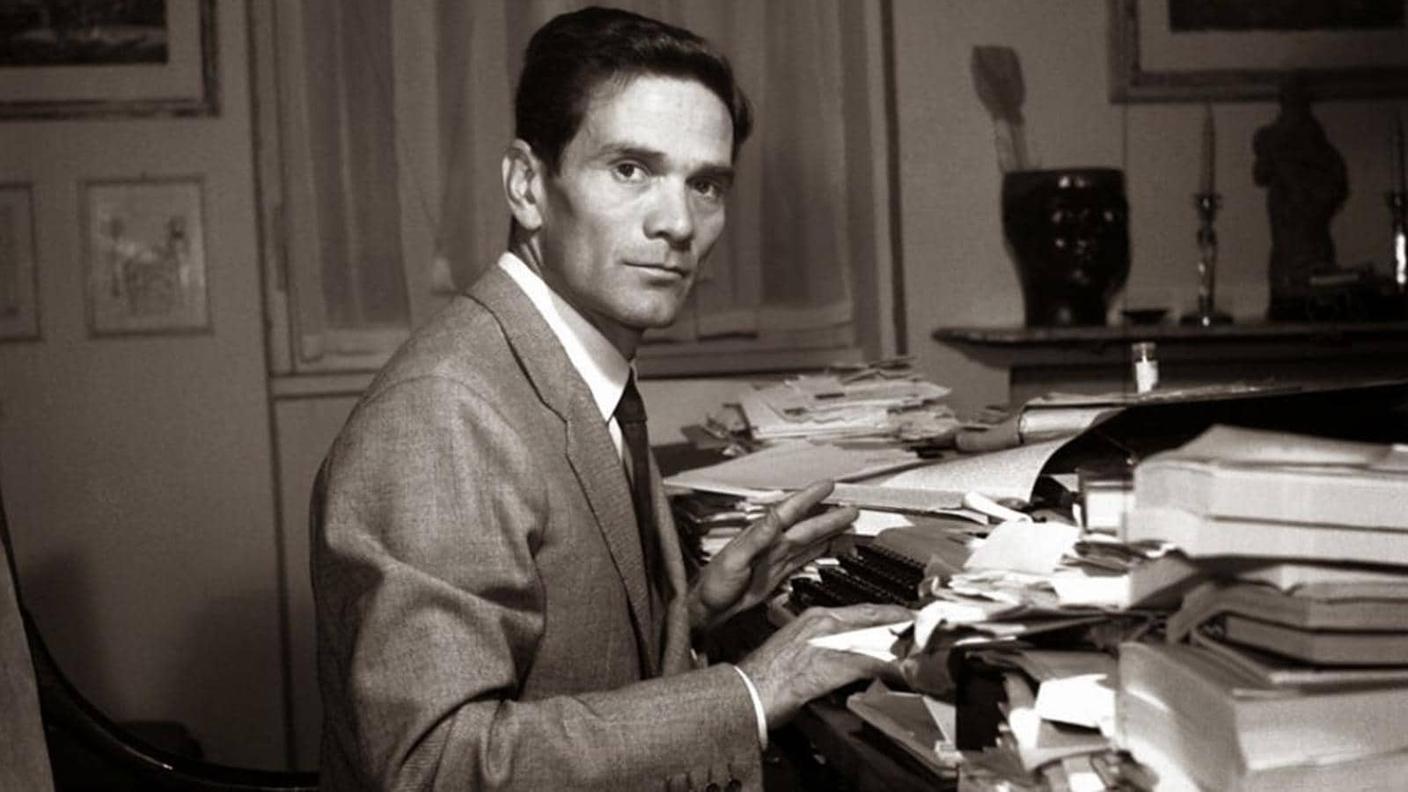Nel XIX secolo Matilda Joslyn Gage, attivista americana per i diritti delle donne, osservò il fenomeno per il quale, specialmente in campo scientifico, si negavano o minimizzavano i risultati conseguiti dalle donne, i cui studi venivano spesso attribuiti ai loro colleghi uomini, non a causa della scarsa qualità scientifica del loro lavoro, ma per motivi di genere.
Per secoli le donne non solo erano state tenute lontane dalla scienza, ma quando nonostante tutto riuscivano a lavorare e anche a eccellere in questo campo, vedevano i propri risultati minimizzati e sottovalutati.
Donne "scienziate" nell’Alto Medioevo
Il giardino di Albert 06.12.2018, 11:35
Contenuto audio
Lo raccontano Maria Pia Abbracchio e Marilisa D’Amico in Donne nella scienza. La lunga strada verso la parità (Franco Angeli, 2023), e Sara Sesti con Liliana Moro in Scienziate nel tempo. Più di 100 biografie di donne che hanno sfidato pregiudizi millenari (nuova ed. aggiornata, Ledizioni, 2023).
Ipazia e le altre

Contenuto audio
23.06.18 Ipazia, matematica, astronoma e filosofa. Incontro con Silvia Ronchey
Ipazia e le altre 23.06.2018, 15:35
30.06.18 Ada Lovelace, Emmy Noether e Sofja Kovalevskaja. Incontro con Chiara Valerio
Ipazia e le altre 30.06.2018, 15:35
07.07.18 Marie Curie, Lise Meitner e Hedy Lamarr. Incontro con Gabriella Greison
Ipazia e le altre 07.07.2018, 15:35
14.07.18 Amalia Ercoli Finzi, ingegnere Aerospaziale
Ipazia e le altre 14.07.2018, 15:35
Storicamente quella delle donne nella scienza è stata una presenza sofferta. I luoghi di produzione del sapere erano riservati agli uomini, della maggior parte delle donne la storia ha cancellato i nomi: molte di loro fin dal Medioevo per poter lavorare e impegnarsi nella scienza hanno dovuto celarsi dietro un nome maschile, e pubblicare sotto pseudonimo o col nome dei mariti. Spesso perciò le loro opere venivano attribuite ai maestri.
Molti gli esempi anche in epoche a noi più vicine: da Sophie Germain che nell’800 si firmava M. Leblanc per poter corrispondere con un matematico, fino al caso paradossale di Mary Sommerville, matematica, astronoma e scrittrice scientifica scozzese, considerata la regina della scienza ottocentesca, autrice di libri che venivano adottati all’Università di Oxford dove però non poteva mettere piede in quanto donna.
Secondo Jacky Fleming, autrice della Breve storia delle donne (Corbaccio, 2017), finché c’erano i corpetti e i bustini le donne non si potevano chinare sui microscopi; perciò la storia delle donne ha cominciato ad avere a che fare con la scienza quando esse si sono liberate di alcuni orpelli che facevano della donna un oggetto. Come a dire: liberazione del corpo come strumento per liberare anche la mente.
Ma anche in secoli più recenti le donne scienziate sono state per lo più vittime di oblio e luoghi comuni. Poco importa che siano state pioniere: nell’ingegneria e chimica ambientale, come Ellen Swallow che nel 1870 già si occupava scientificamente di problemi ecologici (anche se il settore fu classificato come “economia domestica”); nella scoperta della fissione nucleare, come Lise Meitner (1878-1968); o del Dna, come Rosalind Franklin (1920-1958). Poco importa che abbiano aperto la strada al funzionamento del primo calcolatore digitale della storia, come le programmatrici di Eniac (electronic numerical integrator and computer) tra il 1943 e il 1945; o scoperto la materia oscura e le pulsar, come le astronome Vera Rubin (1928-2016) e Jocelyn Bell-Burnell (1943).
Non è un caso che in più di 120 anni solo sessantuno donne (cioè circa il 4% dei premiati) siano state insignite con il Nobel. E il numero scende ad appena 25 se consideriamo le studiose che lo hanno ottenuto nelle discipline scientifiche, economia compresa.
Malaria: dall’oblio al Nobel
Il giardino di Albert 24.10.2015, 18:00
Contenuto audio
Oggi il mondo della fisica, dell’astronomia, della biologia e della scienza in generale è ricco di presenze femminili. Ma rimane ancora, un po’ ovunque, il numero esiguo delle scienziate cui vengono affidati ruoli di rilievo nella ricerca e nelle istituzioni, malgrado da anni gli istituti scientifici delle università registrino una maggiore presenza femminile.
Non tanto per questioni di discriminazione, che pure permangono, ma per la difficoltà nel conciliare lavoro e famiglia, che resta in gran parte responsabilità della donna.
Una pioniera tra le stelle (1./2)
Il giardino di Albert 11.01.2018, 11:35
Contenuto audio
Secondo l’ultimo report sulla parità di genere nell’Unione europea, pubblicato il 7 marzo scorso, la percentuale di donne laureate nelle discipline STEM (Science, Technology Engineering e Mathematics) è costantemente inferiore a quella degli uomini, e relativamente stabile.
Come mostra anche She Figures, un report dell’UE sulle questioni di genere nella ricerca e nell’innovazione pubblicato nel 2021, il divario di genere aumenta con l’aumentare dei livelli di anzianità: il 35% delle posizioni di grado C (il livello base per un neodottorato) è ricoperto da donne, ma solo il 19% delle donne ricoprono posizioni di livello A, come possono essere quella di professoressa ordinaria nei campi STEM.
Nel settore così importante e attuale delle ICT (Information and Communication Technologies), poi, la presenza delle donne, a tutti i livelli, è ancora più basso, tanto che a livello europeo il Digital Decade Policy Programme 2020 fissava l’obiettivo di raddoppiare il numero di professionisti ICT incrementando quello delle donne.
Difficoltà e discriminazioni si riflettono anche nelle disparità di genere tuttora presenti nelle pubblicazioni scientifiche. Qui per le donne è ancora più difficile, rispetto ai colleghi maschi, firmare gli articoli (soprattutto come prime autrici) e superare il processo di peer review. E ancora una volta i fattori alla base sembrano essere culturali e difficili da sradicare. In particolare, le donne hanno meno probabilità di sottoporre un proprio articolo a riviste con un impact factor molto alto, e meno di un articolo su cinque fra quelli di un solo autore è firmato da una donna. Vari studi recenti – come il report della Royal Society of Chemistry (RSC) Is publishing in the chemical sciences gender biased?, pubblicato nel 2020 – denunciano ancora una discriminazione da parte dei comitati, prevalentemente maschili, che valutano le ricerche ed erogano i finanziamenti.
Una discriminazione di cui i media sembrano in parte – seppur inconsapevolmente – corresponsabili: un chiaro e poco virtuoso esempio lo si è visto durante la pandemia di Covid-19. Il contributo delle scienziate nei vari campi legati al virus è stato fondamentale (si pensi per la Svizzera a Emma Hodcroft, epidemiologa molecolare presso l'Istituto di Medicina Sociale e Preventiva dell'Università di Berna, nota come "la cacciatrice di virus”, che è stata determinante nel tracciare l'evoluzione del virus SARS-CoV-2 in tempo reale attraverso l'analisi di nuove varianti). Eppure, pochissime di loro sono state interpellate dai media, dove hanno campeggiato per mesi gli stessi “esperti maschi”.
Anche in Svizzera, uno dei Paesi più innovativi del mondo, che vede i suoi due istituti politecnici in cima alle classifiche mondiali, malgrado il numero di donne che si iscrive a facoltà scientifiche sia aumentato, le scienziate in ruoli di rilievo sono ancora poche e il divario di genere nei ruoli dirigenziali risulta evidente. E questo malgrado qualche bel caso recente: dall'estate del 2022, per esempio, l'Empa Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology è guidato da una donna) .
Fabiola Gianotti. La signora della fisica
Laser 22.11.2019, 09:00
Contenuto audio
Secondo il già citato report She Figures (2021) della Commissione Europea, le donne costituiscono solo il 24% del corpo docenti delle 12 università svizzere. Una percentuale inferiore alla media dei 27 Stati membri dell’UE (26%). E il numero delle professoresse è ancora minore se si guarda alle discipline scientifiche: solo il 20% nel 2000. Secondo l’Ufficio federale di Statistica, «Tra le principali ragioni di questo divario, molti studi citano gli stereotipi culturali: le STEM sono considerate un dominio prettamente maschile, sebbene le donne tendano a laurearsi e a conseguire dottorati più degli uomini».
Nei sondaggi molte donne hanno ricondotto la propria decisione a «difficoltà nel conciliare la vita accademica e quella familiare, alla mancanza di modelli femminili e di un networking adeguato, oltre che all’esistenza di pregiudizi di genere nelle procedure di assunzione e promozione. La Svizzera, poi, presenta diversi problemi anche a livello strutturale: i servizi per l’infanzia sono spesso scarsi e molto costosi rispetto ad altri Paesi europei, mentre la disponibilità di lavori ben remunerati in ambito industriale costituisce un’alternativa molto allettante al mondo accademico».
Insomma, niente di veramente nuovo sotto il cielo. Anche se qualcosa si muove: il Politecnico di Zurigo, ad esempio, ha organizzato corsi di formazione sui pregiudizi di genere per professori e comitati di selezione, mentre il Politecnico di Losanna ha istituito una commissione per affrontare il problema e fornire raccomandazioni in merito (cfr. le prese di posizione dell'11 febbraio 2022 e del 24 agosto 2022).
Tuttavia Ursula Keller, prima donna a ottenere la cattedra di fisica presso il Politecnico federale di Zurigo nel 1993, fondatrice nel 2012 del Women professor Forum, è convinta che tutto questo non basti a spingere le donne verso le STEM, in particolare ai livelli di professorato più elevati, dove il divario tra uomini e donne aumenta. In una lettera pubblicata a gennaio dell’anno scorso
ha scritto che: «L’attuale cultura costituita da reti informali e perlopiù dominate da uomini, con pregiudizi di genere intrinseci, scarsa attribuzione delle responsabilità e poca trasparenza a livello decisionale e di distribuzione delle risorse, ha un effetto negativo sulle donne, poiché scoraggia le generazioni future dal voler assumere ruoli di rilievo».
Insomma, modelli di successo e iniziative dedicate possono senz’altro contribuire a invertire questa tendenza, ma sarà fondamentale un cambio di cultura che possa scardinare i modelli che si perpetuano da tanto tempo, e abbattere le costruzioni simboliche che fin dall’antichità differenziano il genere femminile e quello maschile, innestando stereotipi e pregiudizi. Solo così potrà realizzarsi l’auspicio formulato dalla grande neurologa, Nobel per la medicina, Rita Levi Montalcini: «Il futuro del pianeta dipende dalla possibilità di dare a tutte le donne l’accesso all’istruzione e alla leadership. È alle donne infatti che spetta il compito più arduo, ma più costruttivo, di inventare e gestire la pace».