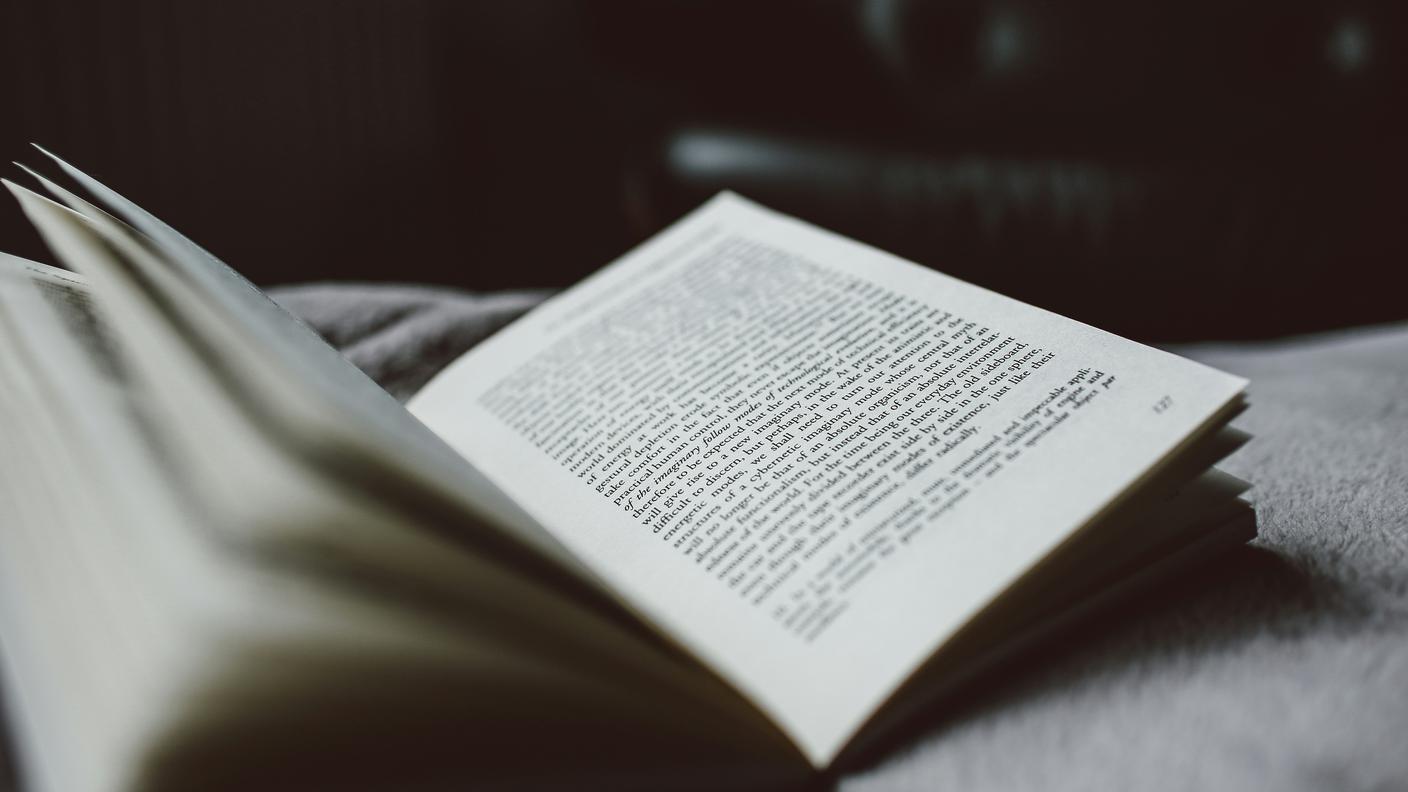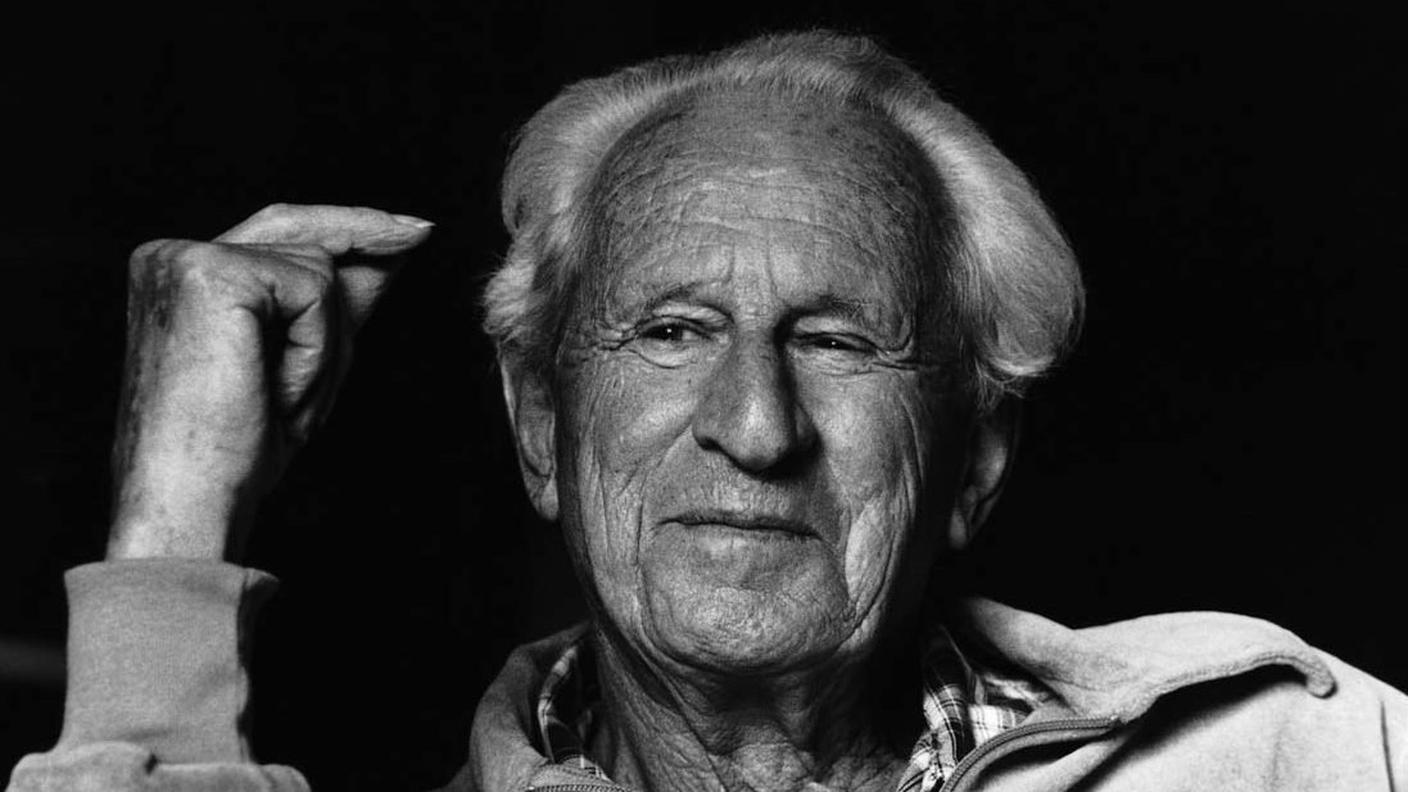«Prendemmo a spargere le carte sul tavolo, scoperte, come per imparare a riconoscerle, e dare loro il giusto valore nei giochi, o il vero significato nella lettura del destino. Eppure non sembrava che alcuno di noi avesse voglia d’iniziare una partita, e tanto meno di mettersi a interrogare l’avvenire, dato che di ogni avvenire sembravamo svuotati, sospesi in un viaggio né terminato né da terminare. Era qualcos’altro che vedevamo in quei tarocchi, qualcosa che non ci lasciava più staccare gli occhi dalle tessere dorate di quel mosaico» (I. Calvino)
I tarocchi in Calvino
È da queste tessere dorate che ha inizio il racconto silenzioso dei protagonisti de Il castello dei destini incrociati di Italo Calvino (Einaudi 1973). I tarocchi (mazzo Visconti e mazzo Marsiglia) sono un escamotage che Calvino (1923-1985) utilizza brillantemente per narrare le vicende individuali dei personaggi del suo romanzo breve, i quali, dopo uno stremante viaggio attraverso il bosco, si inventano un modo per comunicare fra loro essendosi ritrovati tutti senza voce, come vittime di un sortilegio. Ad accomunarli, oltre alla perdita della parola, è pure la scelta del rifugio: un castello, che pare più una locanda, ma che lascia trapelare la fastosità di tempi ormai lontani. L’opera di “letteratura combinatoria” si basa sulla scelta di utilizzare le carte miniate come strumento dal quale Calvino trae ispirazione per le varie storie che la compongono e il mezzo attraverso cui i personaggi stessi, riuniti attorno ad una tavola, si raccontano. Le loro storie, tutte di carattere allegorico, nascono da un numero finito di elementi - gli arcani maggiori e gli arcani minori - che possono essere associati fra loro in modo praticamente infinito. Tutte le vicende sono legate le une alle altre dalle carte già scoperte sul tavolo; si intrecciano per descrivere eventi, luoghi e storie molto distanti fra loro creando una sorta di matrioska nella quale passato, presente e futuro si mescolano fino a non rendere più riconoscibili le singole storie e creando un unico grande racconto per immagini. La frase «ciò che è in alto, è come ciò che è in basso» attribuita al leggendario Ermete Trismegisto, riflette accuratamente l’operazione narrativa compiuta da Calvino che utilizza le carte dei tarocchi come tessere di un mosaico, trasformando l’intero mazzo in una mirabile e complessa «cosa unica» la quale può essere letta da destra a sinistra, dall’alto verso il basso e viceversa. Quindi, una volta narrata una vicenda, un nuovo narratore si può riallacciare per raccontare tutt’altra storia, che nulla ha a che vedere con quella precedente, ma alla quale si lega inevitabilmente, avvicinando così fra loro personaggi sconosciuti che, per qualche ragione, il destino ha voluto far incontrare.
Le origini letterarie
L’idea di utilizzare i tarocchi come una «macchina narrativa combinatoria», Calvino, l’attinge dal semiologo Paolo Fabbri, ma le origini di queste carte - nate nelle corti principesche del Nord Italia -risalgono alla prima metà del Quattrocento. Inizialmente i tarocchi venivano utilizzati come giochi di società dal carattere letterario e sapienziale (l’uso divinatorio è scarsamente documentato fino alla fine del Settecento): ai membri della corte venivano assegnate delle carte estratte dal mazzo le quali dovevano essere interpretare al meglio, ad esempio declamando un sonetto, oppure un altro modo di utilizzare le carte era quello di “appropriare i tarocchi”, ovvero attribuire ad una persona nota uno dei trionfi (i primi documenti in cui appare la parola “tarocchi” appartengono agli inizi del Cinquecento, prima di quel periodo si parla più che altro di “trionfi”) a volte per lodarla, altre per sbeffeggiarla. Testimonianza di questa moda è il poemetto satirico di Pietro Aretino (1492-1556) sul conclave che elesse Adriano VI, nel quale descriveva i cardinali impegnati nel gioco dei tarocchi. Anche il celebre poeta Ludovico Ariosto (1474-1533), nella sua commedia Cassaria, fa pronunciare una satira contro il malcostume dei funzionari governativi che «perdevano tempo dietro a diversi giochi, tra cui anche il Tarocco». Infatti il successo riscosso da queste carte fu così grande che ben presto abbandonarono le corti per trasformarsi in gioco d’azzardo, molto popolare in osterie e locande prendendo piede in tutta Italia, dove si moltiplicarono presto le varianti regionali. Nel Cinquecento, infine, la fama di questo passatempo ludico varcò i confini italiani approdando in Svizzera, Francia e Boemia.
Carte dal carattere ludico e in seguito divinatorio (la prima volta in cui vengono citati i tarocchi per interpretare la sorte è nel Caos del Triperuno di Teofilo Forengo, 1491-1544, principale esponente della poesia maccheronica) che fin da subito hanno affascinato scrittori e poeti. Tanto che alcuni studiosi sostengono che fu Petrarca il primo ispiratore dei Trionfi grazie ad un poemetto omonimo nel quale egli presenta le principali forze in gioco nella vita: Amore, Pudicizia, Morte, Fama, Tempo ed Eternità. A spingere i sostenitori in questa direzione è stato il ritrovamento di un gioco in voga nel Quattrocento che si chiamava “giuoco dei Trionfi del Petrarca”, purtroppo però non se ne conoscono né le caratteristiche né la diffusione. Altre prospettive fanno pensare che l’origine del nome sia riconducibile più che altro alle sfilate cittadine tipiche nel Medioevo: delle rappresentazioni teatrali di piazza che mettevano in scena virtù, vizi e vicende umane (soprattutto a Firenze, Bologna e Ferrara) per celebrare le personificazioni di virtù morali o l’insediamento al potere dei nobili. Ma a stabilire, quasi sicuramente, la struttura che conosciamo anche noi oggi, fu ancora una volta un letterato: Matteo Maria Boiardo (1441-1494) con un’opera poetica dal titolo Cinque Capituli, sopra el Timore, Zelosia, Speranza, Amore et uno Trionfo del Mondo (databile fra il 1469 e il 1478), che sancisce la struttura del mazzo in 78 carte, tra cui 22 trionfi e 56 carte divise in quattro semi spuri: Amore, Speranza, Gelosia e Timore.
I Tarocchi, da Bembo a Calvino
RSI Cultura 14.10.2019, 09:29
Esoterismo ed archè
Calvino non fu dunque il primo letterato a scrivere di tarocchi ma, forse, fu il primo ad utilizzarli per scrivere racconti. Come già citato, per questa impresa, Calvino si è servito del mazzo Visconti e del mazzo Marsiglia. Il primo mazzo, quello dei Visconti, è il più antico a noi pervenuto, sotto questo nome generico sono raggruppati tre mazzi distinti che recano sulle loro carte stemmi araldici e motti della famiglia Visconti; essi vennero commissionati ad artisti e artigiani famosi tra cui anche il pittore e miniatore Bonifacio Bembo (1420-1480). Il modello “Marsigliese” (termine utilizzato per la prima volta nel 1930 e attribuito a Paul Marteau, 1885-1966) invece si impose nella prima metà del Settecento, grazie alle capacità imprenditoriali di numerosi fabbricanti di carte che si installarono in una zona compresa fra Marsiglia, Avignone, Lione e Digione. Fu proprio il modello marsigliese a dare il via agli usi esoterici e divinatori delle carte. Parallelamente anche in Inghilterra nasceva una scuola esoterica: mentre quella francese (per gli arcani maggiori) ha il merito di aver indicato le carte come tappe di un viaggio iniziatico verso la virtù e l’illuminazione, la scuola inglese (per gli arcani minori) è stata invece fondamentale per aver creato nuovi mazzi in cui gli arcani minori sono illustrati, ponendo le basi per la lettura intuitiva delle carte. Una lettura che trova consensi negli studi dello psichiatra svizzero Carl Gustav Jung (1875-1961), il quale ritiene che alcune immagini, concetti e situazioni siano in qualche modo innati nella mente umana, o meglio, derivino da un inconscio collettivo, e condiviso. Infatti durante un suo seminario sull’immaginazione attiva, Jung si espresse sui tarocchi definendoli «archetipi di trasformazione personale». Una trasformazione, potremmo dire, compiuta anche dal protagonista de Il Castello dei destini incrociati, che attraverso gli archetipi, i racconti allegorici degli altri commensali, è arrivato a confondere la propria storia con le altre, senza più distinguerla e in fine, quindi, liberandosene: un viaggio interiore alla scoperta di sé stessi attraverso la conoscenza e l’immedesimazione nell’altro.
Le idee di Jung sono state ulteriormente sviluppate da molti studiosi, tra cui anche il saggista e storico delle religioni Joseph Campbell (1904-1987) che ha approfondito appunto il tema del viaggio, sviluppando il concetto di “viaggio dell’eroe”, che si rifà proprio all’intuizione che tutte le storie, le fiabe, i racconti popolari si basano sui miti, che altro non sono che modelli di storie universali e questi miti rispondono tutti allo stesso codice narrativo, ovvero allo stesso percorso fatto di decisioni, tappe, cadute e incontri, che infine porta alla piena realizzazione personale. Il viaggio dell’eroe, come anche il viaggio del viandante di Calvino attraverso il bosco, sono la metafora del viaggio della vita di ogni persona. L’eroe-viandante è chi parte per l’avventura e riesce a portare a casa la risposta che dà nuova vitalità e consapevolezza alla sua vita e alla comunità; i tarocchi, in questo senso, sono un’emanazione di questo background culturale: i 22 Arcani Maggiori descrivono le molte sfaccettature che caratterizzano la vita; nei primi sette Arcani prende avvio il viaggio terrestre in cui ci imbattiamo in situazioni che definiscono il nostro posto nel mondo; nella seconda sequenza, dobbiamo formare il nostro carattere definendo i sentimenti, i ritmi, le priorità, i valori e le regole e infine, nella terza successione, acquisiamo una nuova consapevolezza e scopriamo di essere parte di un Tutto. boiardo
Derivazioni pop
Oggi il lavoro di Campbell è diventato un modello di riferimento nella creazione di contenuti narrativi, cinematografici, televisivi e multimediali; è stato ripreso, fra i tanti, dallo sceneggiatore Christopher Vogler che lo ha posto alla base di moltissimi film e saghe hollywoodiani. Spesso le immagini dei tarocchi appaiono nei film o perché citati direttamente, come in 007 Vivi e lascia morire (1973), in Scoop (2006) di Woody Allen, o perché i personaggi si rifanno direttamente a quei modelli fondamentali che troviamo riflessi nei tarocchi, come per la saga Guerre Stellari, in cui il personaggio di Obi-Wan Kenobi ricorda la carta dell’Eremita. Una chiave di lettura pop, che nella contemporaneità ha trasformato i tarocchi anche in oggetti d’arte e in fumetti, un connubio quest’ultimo, particolarmente profondo visto che il fumetto comunica prima di tutto con le immagini, che non hanno solo una valenza estetica ma anche narrativa, così come le carte dei tarocchi. Tra i personaggi dei fumetti legati ai tarocchi ci sono Corto Maltese, il celeberrimo Dylan Dog, Martin Mystere, Nathan Never. Troviamo inoltre i supereroi Marvel, ognuno dei quali è stato associato a un diverso Arcano in funzione dei propri poteri. Persino il mondo della musica è stato influenzato dal fascino dei tarocchi: nel 2018 è stato pubblicato Starman Tarot, un mazzo di tarocchi pensato e progettato a quattro mani da David Bowie (1947-2016) e dall’amico Davide De Angelis, il quale ha portato a termine il progetto dopo la scomparsa di Bowie. Le carte da loro ideate trovano la loro ispirazione dai testi e dalle atmosfere dell’album Earthling e la loro funzione primaria, ancora una volta, è quella di «catalizzatore creativo». La creatività, appunto, è quella dote che i tarocchi hanno saputo stimolare nel corso dei secoli fino ad oggi, attraverso le loro immagini archetipiche in grado di generare narrazioni inesauribili.