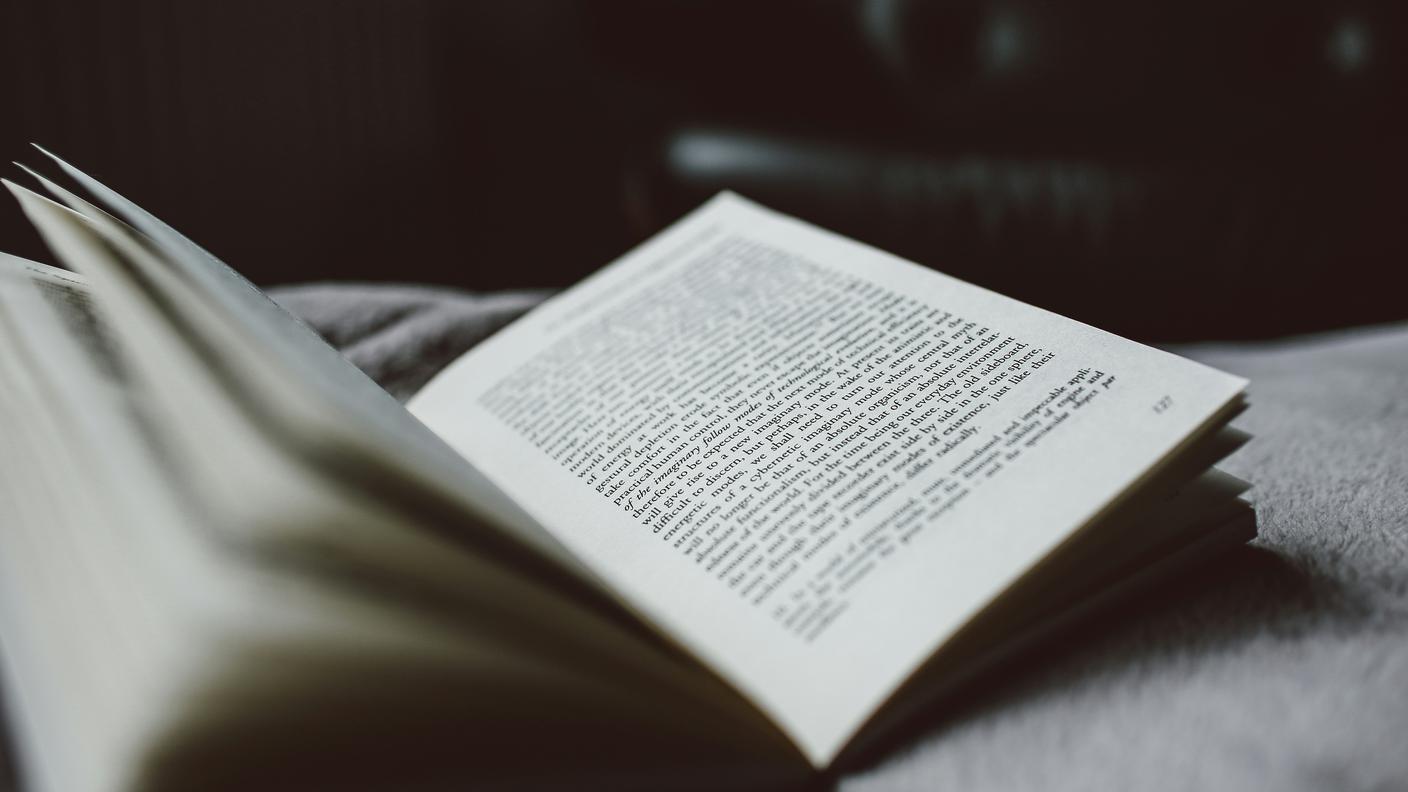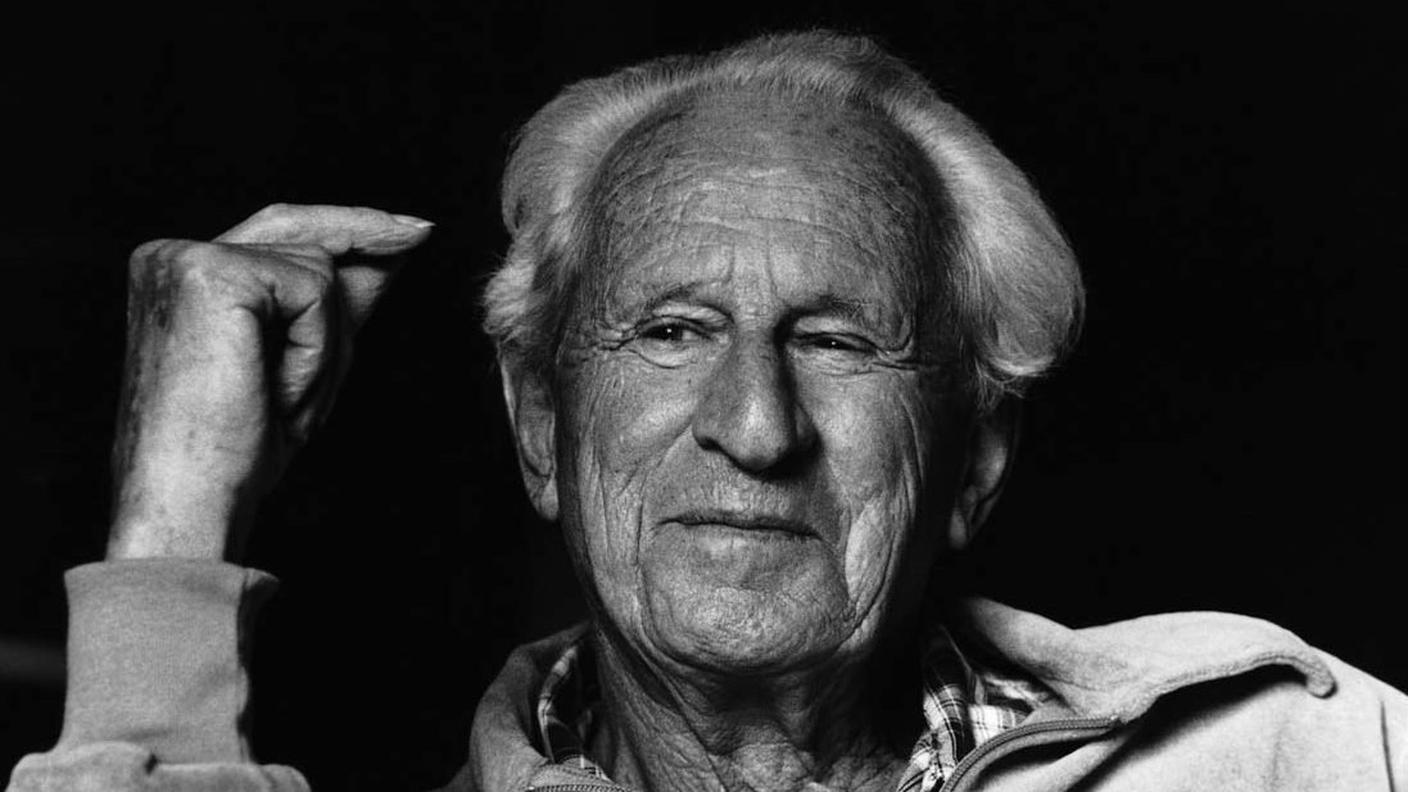I filosofi, si sa, non fanno esperimenti così come accade invece nelle scienze empiriche: non hanno a disposizione laboratori, non fanno uso di strumentazioni costosissime né di tecniche avanzate. C’è però un tipo particolare di esperimento, legato alla facoltà dell’immaginazione, che fin dagli inizi (pensiamo ad esempio al mito della caverna di Platone) si trova al centro della metodologia filosofica: stiamo parlando dell’esperimento mentale (dal tedesco Gedankenexperiment). Un esperimento mentale consiste nell’immaginare uno scenario e nel trarre delle conseguenze, delle conclusioni a partire, per l’appunto, dalla dinamica dello scenario descritto.
Ora, di tanto in tanto capita che certi fortunati esperimenti mentali si trovino ad avere, nonostante la loro disarmante semplicità, un impatto notevole sulla società. È questo il caso dell’esperimento del “bimbo nello stagno” ideato dal filosofo americano Peter Singer e contenuto nel suo volume del 2009 Salvare una vita si può (edito da Il Saggiatore).
Immaginiamo di essere diretti al lavoro e di imbatterci, durante il tragitto, in uno stagno all’interno del quale un bambino sta affogando. Abbiamo la possibilità di salvarlo senza correre nessun rischio (il livello dell’acqua è basso, lo stagno non è abitato da animali pericolosi, ecc.). L’unico costo è che ci sporcheremo i vestiti con tutto ciò che ne consegue (arriveremo in ritardo sul lavoro, bisognerà spiegare al nostro capo cos’è successo, ecc.).
La domanda è la seguente: abbiamo l’obbligo morale di salvare il bambino? La risposta è unanime: l’importanza di salvare la vita del bambino eccede di gran lunga il prezzo da pagare (i vestiti rovinati, il ritardo sul lavoro, ecc.).
Qual è dunque la conclusione che bisogna trarre dallo scenario descritto da Singer? Il punto è che la maggior parte di noi si trova in una situazione analoga. Ovvero, la maggior parte di noi ha la possibilità di salvare una vita umana (o comunque di contribuire a farlo) a costo di subire una piccola perdita economica, ciò che corrisponderebbe a una donazione, e senza correre alcun pericolo. L’unica differenza rispetto allo scenario è che la vita umana in questione si trova, nella più parte dei casi, in un altro paese, spesso lontano, e che quindi la nostra operazione di salvataggio deve essere mediata attraverso un istituto di beneficenza.
Si diceva prima che l’esperimento mentale del “bimbo nello stagno” ha avuto un grande impatto sociale. Esso è infatti un caposaldo di uno dei più noti e discussi movimenti sociali e filosofici contemporanei, l’Altruismo Efficace. Sostenuto da miliardari come Dustin Moskovitz (co-fondatore di Facebook), Jaan Tallinn (co-fondatore di Skype) e Elon Musk, l’Altruismo Efficace, come viene spiegato dai suoi membri, si basa sulla massimizzazione del bene che si può fare attraverso le donazioni, la carriera e altre decisioni di vita. Nato a Oxford, l’Altruismo Efficace conta decine di migliaia di seguaci e si è diffuso in più di settanta stati, tra cui la Svizzera con sedi a Basilea, Berna, Ginevra, Losanna e Zurigo.
L’altruismo efficace
Attualità culturale 23.06.2016, 08:00
Contenuto audio
Il movimento agisce sul piano della ricerca, con lo scopo di identificare i problemi più urgenti a livello mondiale, ma anche attraverso delle azioni concrete. L’aggettivo “efficace” si riferisce alla volontà di cercare il modo più utile, più vantaggioso di fare del bene dato che, si sa, di buone intenzioni è lastricato l’inferno. Torniamo per un attimo all’esperimento mentale del “bimbo nello stagno”. Una delle reazioni più immediate e naturali è quella di mettere in dubbio l’efficacia delle donazioni. Come facciamo a essere sicuri che quello che doniamo arrivi a chi ne ha veramente bisogno? E se le donazioni vengono sprecate? Se si perdono nei costi legati alla burocrazia o, addirittura, a causa di corruzione e truffe? L’Altruismo Efficace si prefigge, prima di tutto, di stabilire delle priorità nella lunga serie di problemi che affliggono il mondo, di classificare l’efficacia degli istituti di beneficenza (attraverso il portale GiveWell) e, infine, di calcolare, nel vero senso della parola, la maniera migliore di contribuire al bene comune, mettendo la ragione davanti ai pregiudizi e senza cadere nella demagogia.
Secondo il movimento, la donazione non è il solo strumento con il quale si può contribuire al bene comune. Lo si può fare anche per mezzo di tutte quelle decisioni importanti, esistenziali che si prendono durante la vita. Per esempio, con il suo progetto 80’000 hours (il nome si riferisce alle ore durante le quali si lavora mediamente nell’arco di un’intera vita — 40 ore per settimana, 50 settimane all’anno, per 40 anni), i membri dell’Altruismo Efficace offrono consigli e raccomandazioni su quali carriere scegliere e in quali settori specializzarsi al fine di massimizzare il proprio contributo alla crescita del bene collettivo.
I risultati non mancano. Il sito effectivealtruism.org propone una lista impressionante di conquiste in vari campi, dallo sviluppo economico alla salute mondiale, dalla protezione degli animali alla prevenzione di catastrofi esistenziali.
Ma non mancano nemmeno le critiche. Una recente, per certi versi immeritata, è connessa all’affiliazione di Sam Bankman-Fried, il noto imprenditore statunitense, al movimento, il quale non ha tardato a disconoscerlo. Ricordiamo che Bankman-Fried, fondatore di FTX, una delle principali società per lo scambio di criptovalute, è salito agli onori della cronaca alla fine del 2022 quando è stato arrestato per bancarotta fraudolenta e truffa aggravata. Simile in questo senso è il pasticcio legato alla leadership di OpenAI, un laboratorio di ricerca sull’intelligenza artificiale, in parte no profit, causato proprio da attriti riguardanti la filosofia dell’Altruismo Efficace che guida e sprona molti dei leader nel settore dell’AI. Ma ovviamente il comportamento di singoli individui così come le dinamiche di gruppo non possono pregiudicare i principi di un intero movimento.
Altruismo efficace
Modem 22.12.2015, 08:30
Contenuto audio
Critiche più sostanziose muovono dal fatto che alla base dell’Altruismo Efficace vi è l’utilitarismo, la teoria secondo la quale un’azione è giusta se produce il più alto grado di benessere per il maggior numero possibile di persone, e l’utilitarismo, per quanto intuitivo, non è estraneo alle obiezioni. Per esempio, secondo la visione utilitaristica, il bene comune viene prima di tutto, rendendo di fatto obsoleta la nozione di diritto individuale. Un altro problema è che l’utilitarismo sembra essere troppo esigente poiché pretende che, per ogni azione e a ogni secondo della propria vita, si debba pensare a come massimizzare la felicità complessiva dell’universo. Viene da chiedersi se sia ragionevole avanzare una tale pretesa. Infine, come spiega bene il filosofo americano Bernard Williams, la filosofia utilitarista allontana gli individui da ciò che è più importante per loro: le relazioni con le persone a cui tengono (la famiglia, gli amici, ecc.), i loro progetti personali, le loro aspirazioni, i loro valori, i loro impegni politici e sociali. Passando in secondo piano rispetto al bene collettivo, tutte queste cose cessano di giocare un ruolo nella scelta di come si debba vivere o di cosa si debba fare. Ciò, secondo Williams, vuol dire rinunciare a ciò che rende una vita veramente degna di essere vissuta.