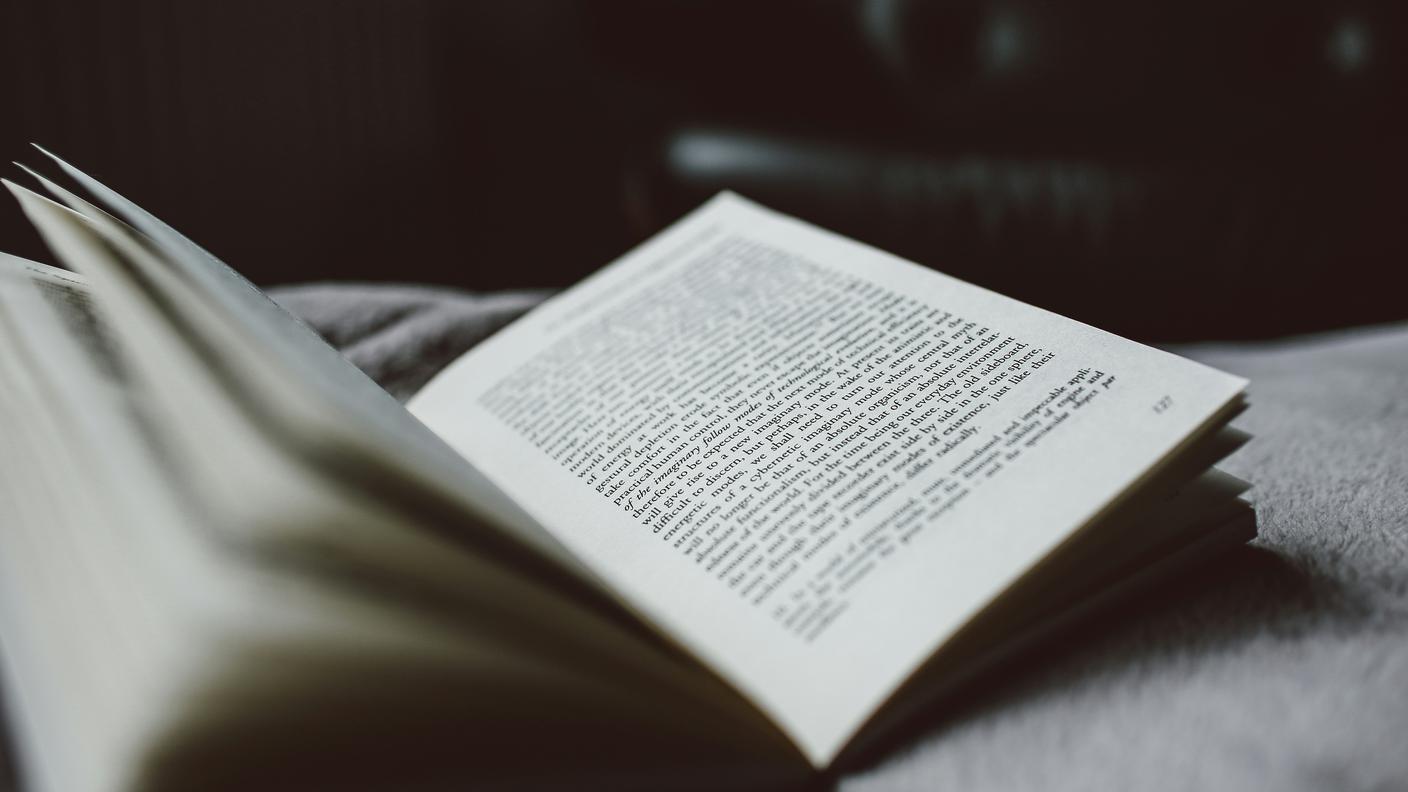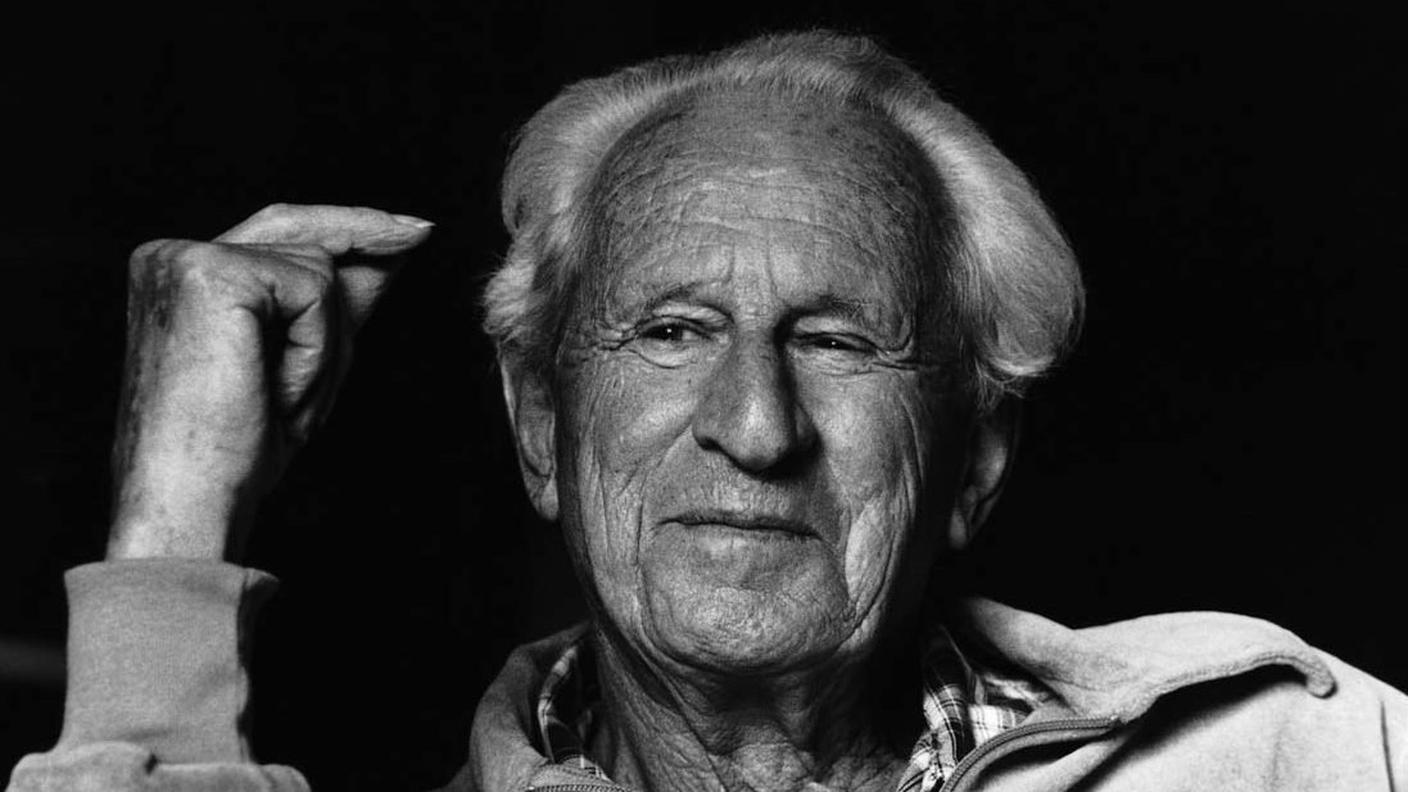“Su tutto si fa ormai chiara luce e lascia che una volta o luce ancora ti guardi”.
Sono le parole pronunciate da Edipo prima di accecarsi. Nel momento in cui tutte le tessere della sua storia finalmente iniziano ad incastrarsi, la verità perseguita con tanta perseveranza viene a galla. È fatta luce, ma quella luce è troppo forte e la verità è troppo dolorosa, una verità e una luce accecanti.
La verità può accecare, per questo proviamo paura, lo facciamo per renderci attenti. La paura è sana, non va rimossa. La paura che prova Giocasta quando capisce, mentre Edipo non comprende ancora. Fermati Edipo, non andare oltre, ma lui anela alla luce accecante della verità, l’ansia di sapere è più forte di tutto.
Nella tragedia di Edipo, Sofocle ci ha consegnato uno dei miti più eloquenti della storia universale dell’uomo. È noto, Freud ne fece tesoro per estrapolarne uno dei leitmotiv della psicanalisi. Ciò che fu considerata dal padre della psicanalisi una costante nelle nostre vite, il complesso di Edipo, appunto. Un’attitudine della psiche che, condurrebbe ogni bambino, nei primi anni di vita, a desiderare tutto per sé l'amore del genitore di sesso opposto, alimentando, per il genitore dello stesso sesso, un inconscio sentimento di rivalità.
La celebre lettura freudiana del mito antico ha forse oscurato un po' un altro piano di lettura di questa che possiamo considerare la tragedia per eccellenza della sventura e della paura. Se affrontiamo la complessa e affascinante lettura della storia di "Edipo re" dal punto di vista non di Edipo, ma di suo padre, il cui sconsiderato agire condiziona l’intero sviluppo narrativo della tragedia, cogliamo della storia, giuntaci dall’antichità, altri aspetti interpretativi utili per capire la debolezza dell’umano agire sottoposto al potere annichilente della paura.
Edipo non è ancora nato, quando il padre, Laio, re di Tebe, riceve la nefasta predizione dall’oracolo: egli verrà ucciso per mano del figlio che avrà dalla moglie Giocasta. Per sfuggire al prospettato epilogo oracolare Laio, alla nascita del figlio maschio, decide di affidarlo ad un servo perché gli sia data morte. Indubbiamente persuaso, in cuor suo, che un ordine valga più dell’umana pietas. Non contempla, il re tebano, che il servo, mosso a pietà, possa disubbidire ad un ordine del suo padrone.
E invece accade. Il servo non ha il fegato di uccidere il bambino e fa il lavoro a metà, lo abbandona su un monte, lo affida ad un pastore, lasciandolo in vita. A quel punto un evento si intreccia con l’altro e l’inevitabile tragedia, del nostro sventurato e inconsapevole protagonista, si compie. La storia si può così sviluppare in tutta la sua verosimiglianza narrativa. Edipo ucciderà il padre, sposerà sua madre con tutte le più sconcertanti conseguenze del caso.
È la paura di morire per mano del figlio che muove l’azione di Laio, dunque. Il re tebano è convinto di poter condizionare gli eventi. Crede di poter sfuggire alla sua morte e di poter scegliere un destino diverso da quello disegnatogli dall’oracolo. Accecato dalla paura diviene vittima della luce abbagliante della verità. Come Edipo che si acceca dopo aver scoperto di non essere uno stimato re e marito, ma un incestuoso parricida.
La paura è cattiva consigliera dice la saggezza popolare, di certo causa catastrofiche tragedie, sembra suggerirci Sofocle. Ma chi ha innescato la paura in Laio è l’oracolo. E senza le visioni oracolari Sofocle avrebbe ben poco da raccontare in "Edipo re".
E se Laio non avesse reagito alla predizione dell’oracolo? Edipo sarebbe cresciuto in casa come figlio legittimo e non si sarebbe verosimilmente sognato di uccidere il padre, men che meno di giacere con sua madre. Il rapporto stretto tra predizione, proiezione sul futuro e paura è un tema caro a Sofocle che sembra metterci in guardia nell’"Edipo re" da quelli che potremmo definire ladri di futuro, gli oracoli appunto.
Ma la voce oracolare sta pure dentro di noi, sta nel nostro prefigurare il peggio, e lasciarsi prendere dalla paura, bloccarla in noi, lasciare che la paura divenga ossessione. E la paura non è più benigna, qualcosa che ci stimola a vivere e a superare le difficoltà, ma diviene qualcosa che ci blocca e ci fa fare passi falsi, madornali errori.
Come accade al giovane persiano del racconto antico che incontra casualmente la morte, si spaventa e viaggia fino a Samarra (o Samarcanda secondo una nota canzone di Roberto Vecchioni) per sfuggirle, mentre era proprio lì che la nera signora lo aspettava.
Crediamo di scegliere e non abbiamo scelta, è questa la morale del racconto della inevitabilità della morte giuntoci dalla tradizione orientale nella rielaborazione di Jean Cocteau, Jorge Luis Borges, John Henry O’Hara e Roberto Vecchioni. Versioni moderne della antica parabola orientale di Re Salomone raccontata nella 53ª sukkah del Talmud Babilonese.
Un giorno Re Salomone si accorse che l’Angelo della Morte era triste. Gli chiese perché fosse così triste. «Perché mi hanno ordinato di prendere quei due Etiopi», risponde l’Angelo della Morte, riferendosi a Elihoreph e Ahyah, i due scribi etiopi di Salomone. Il re preoccupato per la sorte infausta dei suoi preziosi uomini li incoraggiò a scappare, a fuggire lontano, fino a Luz, ma appena giunti nella città i due scribi morirono. Il giorno seguente Salomone incontrò di nuovo l’Angelo della Morte e vide che sorrideva. «Perché sei così felice?» gli chiese. La morte gli rispose: «Hai mandato i due etiopi proprio nel posto in cui li aspettavo!». «I piedi di un uomo sono responsabili per lui: essi lo portano nel luogo dove egli è atteso» disse allora Re Salomone.
Ma se le cose stanno così come possiamo, per usare un eufemismo, non lasciarci accecare dalla paura della fine, come ci insegna la parabola della morte inevitabile e non accelerare il passo per incontrare la nera signora troppo presto, prima di quel che lei stessa, peraltro, aveva previsto?
La saggezza antica d’occidente e d’oriente sembra davvero suggerirci di non concedere un eccessivo ascolto alle voci oracolari, siano esterne od interne a noi stessi.
Meglio sarebbe non rimanere accecati dalla paura.
La paura è un campanello d'allarme che entra nella nostra vita perché c’è qualcosa che chiede la nostra attenzione. La paura va ascoltata, capita e attraversata. È la paura di morire che ha portato re Laio al compiersi del suo tragico destino. Se avesse allevato il figlio Edipo in casa con l’amore e la dedizione di un padre, insieme alla moglie Giocasta la storia non sarebbe stata certo quella.
Sofocle e il Talmud Babilonese ci dicono la stessa cosa, non rifiutiamo la paura, la paura non è un virus, fa parte di noi. È un errore pensare di liberarci dalla pura. La paura è uno stimolo alla vita, a capire e risolvere la situazione che ci ha procurato quella paura, non può essere uno stimolo a bloccarla, a negarla. La paura deve essere per noi uno stimolo alla conoscenza, alla comprensione, al sapere, l’alba che giunge ad illuminare Giacobbe dopo una lotta strenua con l’angelo (Genesi, 32, 24-34).
Lo stimolo adrenalinico della paura ci ingegna, ci fa studiare meglio la strategia per uscire dalla situazione problematica, ci aiuta a incontrare altri che hanno lo stesso problema. Non siamo individui soli e persi, capaci solo di accelerare il passo e correre più veloci verso Samarra.
“Ho sempre pensato di essere estraneo a questa città e di non aver nulla a che fare con voi. Ma adesso che ho veduto quello che ho veduto, so che il mio posto è qui, lo voglia o no. Questa storia riguarda tutti”, così Rambert ne “La peste” di Camus.
E anche quando a farci paura è l’indefinito, il diverso, lo sconosciuto non conviene cedere al buio, alla “notte delle notti”, alla paura di provare paura. Lasciarsi guidare dalla forma oracolare, antica quanto contemporanea, di propagazione della paura che diviene ansia non è proprio la strada giusta. Anzi non c’è come nel flagello che l'umanità può scegliere di vincere ogni timore della morte per scegliere la vita. La vita è l’arte di stare tra tenebra e alba, tra luce e ombra, tra parola e silenzio, gioia e paura. E ci sono più cose da ammirare che da disprezzare.