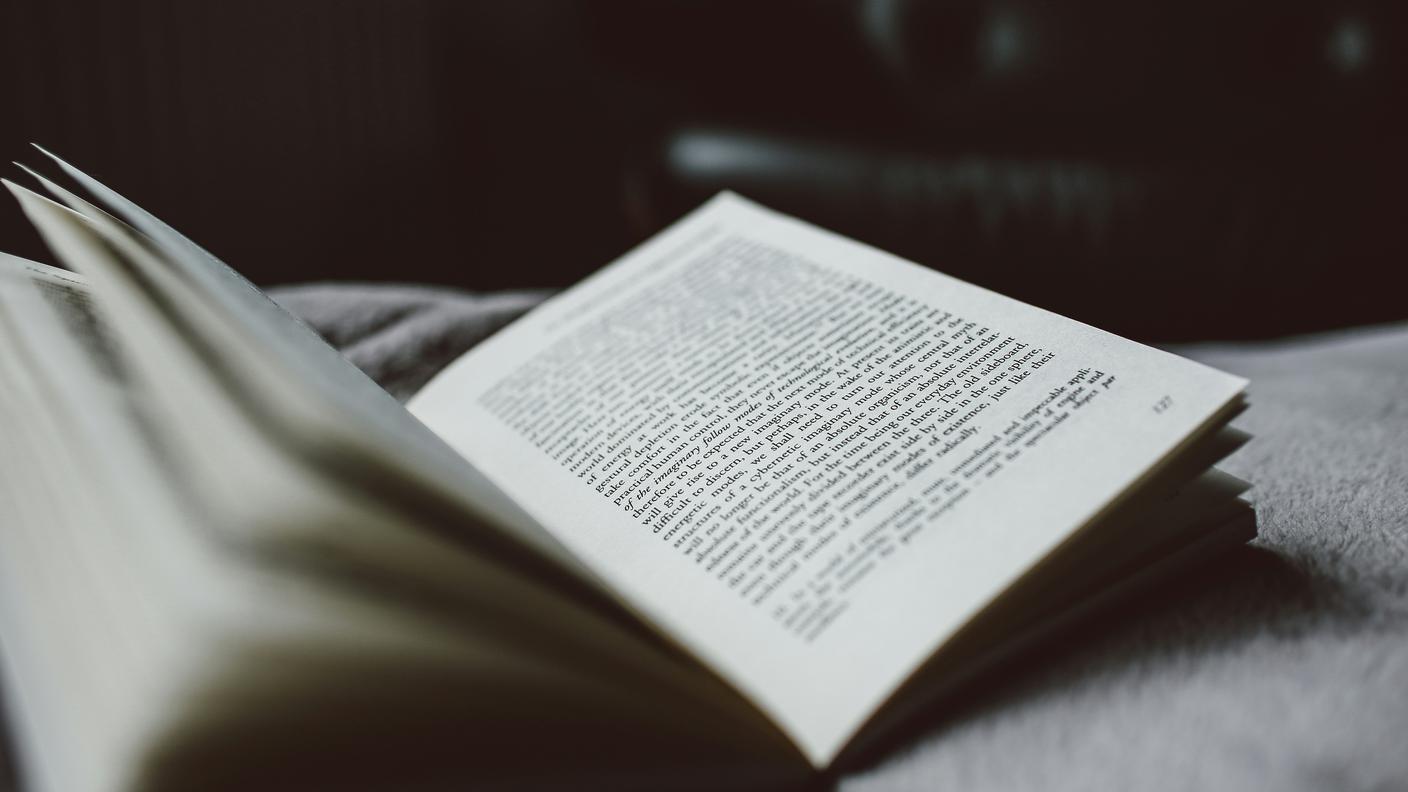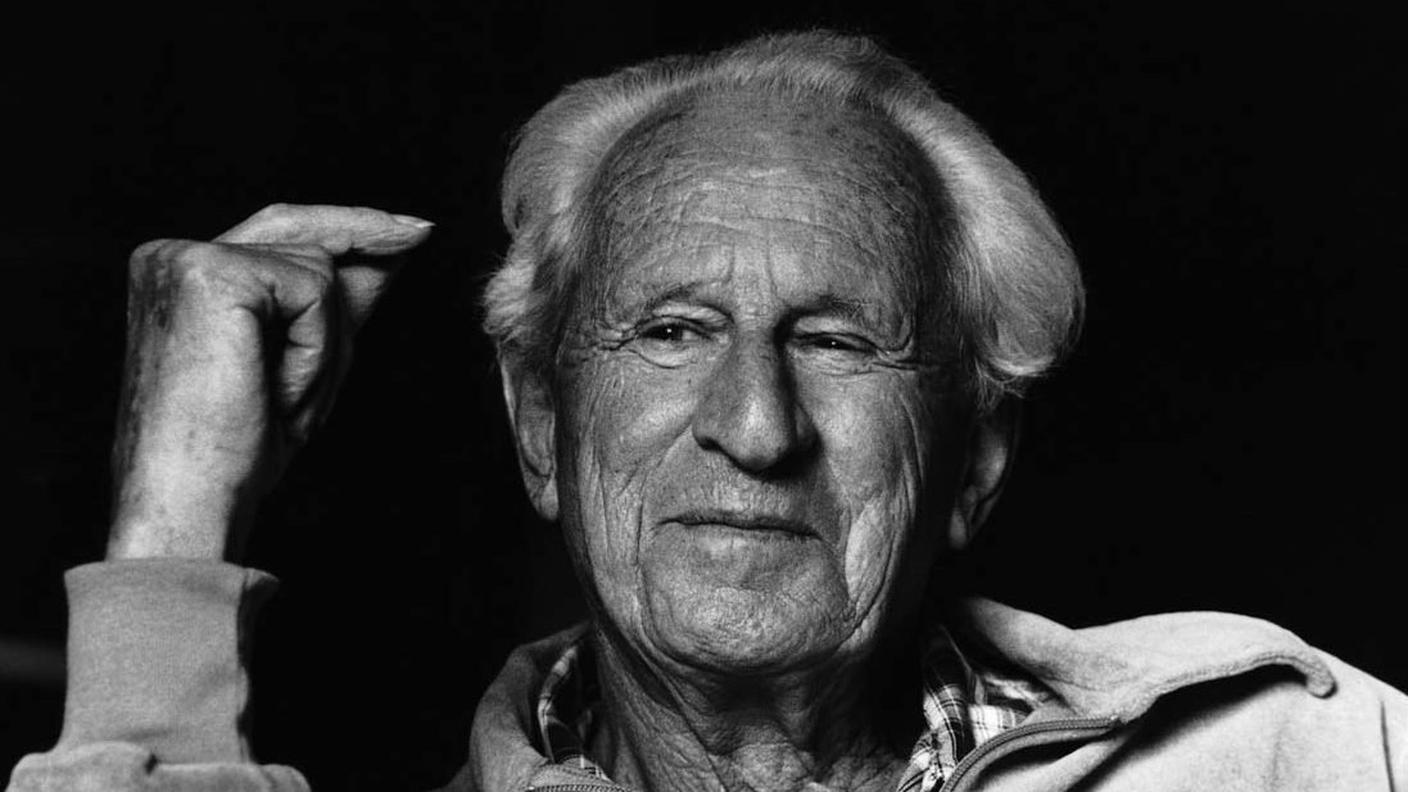Ha ben ragione chi richiama le radici greco-cristiane dell’Europa. Potremmo anzi dire che nessuno meglio di Cristo, in un certo senso, abbia espresso mondanamente il pensiero platonico. Ma questo frettoloso appello al cristianesimo come fondativo dell’Europa elude una contraddizione fatale: che se altrettanto fondativo è da ritenersi il mondo greco, delle due l’una: o è fondativa l’idea greca (e poi romana) di politeismo o è viceversa fondativa l’idea cristiana di monoteismo. E sfido chiunque a non ritenere ossimorico definire «greco-cristiano» l’atteggiamento che assumiamo maggioritariamente, nell’Europa di oggi, rispetto al divino. Fuor di dubbio, esso è invece sommamente e orgogliosamente cristiano e basta.
Significa questo che abbiamo rimosso o dimenticato, per non dire osteggiato, la lezione greco-romana insita nell’approccio politeistico al divino? Non solo: significa che in termini di monoteismo abbiamo organizzato e permeato un modus pensandi che ancora informa di sé l’intera comunità europeo-occidentale in cui ci troviamo a vivere. Al punto, potremmo dire, che laddove la secolarizzazione ha eroso gran parte dei riferimenti di senso di tradizionale appannaggio della religione, pure il sostrato mentale è rimasto identico: escatologico è l’orizzonte della fede, escatologico l’orizzonte della scienza.
Monoteismi e violenza
Filosofia 23.02.2016, 11:35
Contenuto audio
Il pensiero monoteistico ha però così smarrito per strada – affrancandosi da quello politeistico – proprio quello che era un primato assoluto del pensiero greco e a riporto di quello romano: la capacità di osservare l’Alterità altrimenti che nel segno della dicotomia vero/falso ovvero consapevolezza/ignoranza o modernità/primitività. Così ecco che il «princìpio di flessibilità e duttilità proprio delle religioni antiche», come ci ricorda Maurizio Bettini, si è convertito nel «monolitismo culturale» di una presunzione assoluta (cattolica, universale) di Verità che ha finito per favorire il nostro attuale pregiudizio anticipatorio verso chiunque non si conformi al nostro «modello di Verità». Dal «Dio geloso» dell’Antico Testamento al monito del Catechismo a «trattare con pazienza gli uomini che sono nell’errore o nell’ignoranza circa la fede», al richiamo islamico La ilah illa Allah («Non vi è altro dio all’infuori di Dio»), il mondo è venuto configurandosi come terra di guerra (Dar al-harb, secondo il richiamo coranico) tra ragione e torto, con le conseguenze che tutti conosciamo.
Cosa di autenticamente greco o romano sia conservato in questa deriva assolutistica non riesco allora a comprenderlo. Al contrario, oggi che la Grande Migrazione dal Terzo Mondo produce e suscita afflati di respingimento sempre più politicamente connotati, mi chiedo se la grande vittima della contemporaneità non sia proprio la mentalità politeistica da cui prese forma – e a cui diede forma – la curiosità filosofica dei Greci e la loro naturale, fondativa apertura nei confronti dell’Ignoto e dell’Altro.
Intervista a Thomas Römer (a cura di Roberto Antonini)
Contenuto audio
La nascita di Dio: la Bibbia e la storia, la storia della Bibbia (1./2)
Laser 14.05.2015, 09:00
La nascita di Dio: la Bibbia e la storia, la storia della Bibbia (2./2)
Laser 15.05.2015, 09:00
Certo, i Greci chiamavano «barbari» i loro nemici di Persia. Ma la loro era pur sempre un’ostilità (e quando necessario una contesa) spesa sul piano umano e di popolo. Laddove il monoteismo elettivo ha imposto o cercato di imporre l’assoluto della Verità ovunque non regnava «paganesimo», «idolatria», «politesimo» e affini, il margine di apertura verso il Diverso ha viceversa cessato semplicemente di essere, ontologicamente, fideisticamente, ammesso.
E non serve evocare a ritroso le Crociate o lo sterminio degli Indiani d’America o Lepanto o le Torri Gemelle per avallare l’ipotesi che tutto questo orrore sia in definitiva orrore monoteistico. La stessa contemporaneità ci presenta ogni giorno un’immagine dell’Europa (e dell’Occidente) che della lezione greca non ha assimilato alcunché. E della capacità di offrire «cittadinanza» allo straniero – alla maniera di Cicerone o di Augusto – ha preferito il richiamo proto-monoteistico «Or you are with us or you are against us». Richiamo a cui il coraggioso appello di papa Francesco a chiamare «fratelli» non solo i cugini abramitici ma persino gli atei è forse l’unica, paradossale risposta – se non proprio «politeistica» – davvero misericordiosa a cui stiamo assistendo.