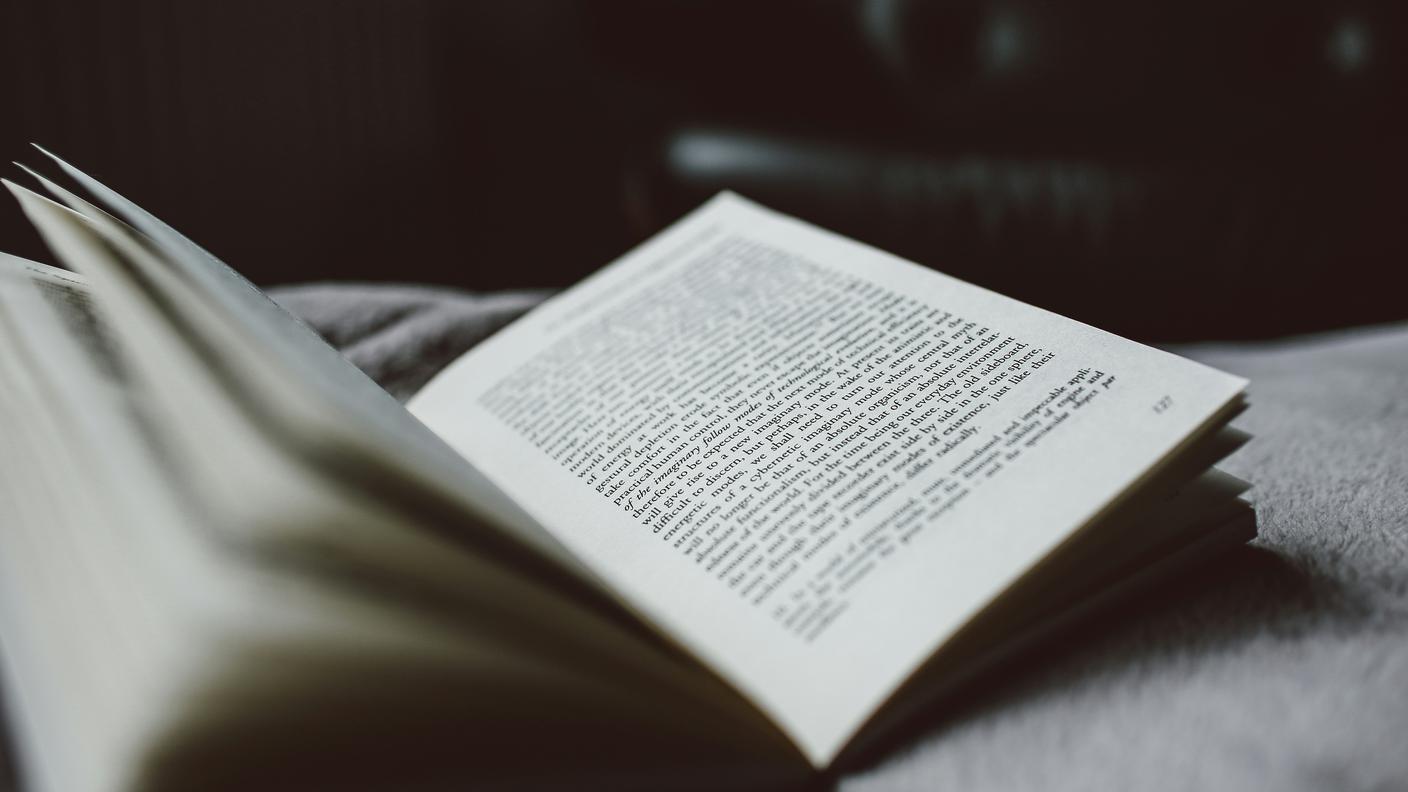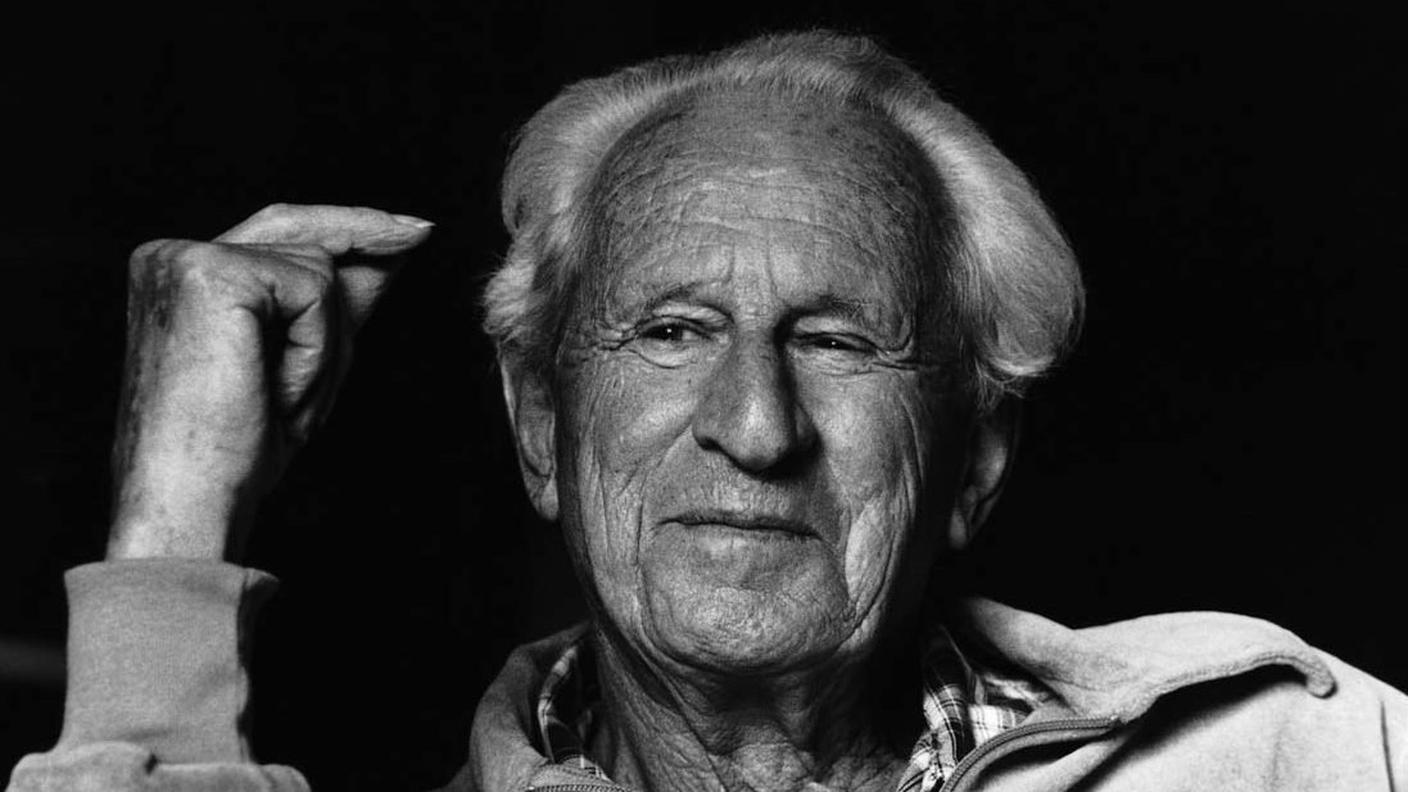Cosa sono i sogni, perché si sogna, che cosa succede nei sogni, che cosa vogliono dire? Sono quesiti che hanno interrogato l’uomo fin dall’antichità. Gli egizi ci hanno lasciato il "Libro dei sogni ieratico", che risale a circa 4000 anni fa (2052-1778 a.C.): un testo di veloce e pratica consultazione che elenca il significato delle immagini oniriche. Anche nella cultura babilonese vi era molta attenzione ai sogni: quella che viene considerata la prima vera descrizione di un sogno si trova nell’"Epopea di Gilgamesh", che risale al 2000 a.C. Di sogni parlavano anche i Sumeri; Giuseppe salvò il popolo ebraico grazie alla sua capacità di decifrare i sogni del faraone; e nel santuario di Asclepio a Pergamo (IV-V sec. A.C.) c’è addirittura il corridoio della stanza dei sogni, perché gli antichi greci avevano un rituale terapeutico legato ai sogni. Come in tutti gli altri santuari di Asclepio, i pazienti speravano di essere visitati nei loro sogni dal dio, che li avrebbe portati alla guarigione. L’elenco potrebbe continuare a lungo.
Nel mondo dei sogni
Il giardino di Albert 17.09.2020, 11:35
Contenuto audio
D’altra parte, non c’è da stupirsi: se nell'arco di tutta una vita dedichiamo al sonno in media 23 anni, ne impieghiamo ben quattro sognando: anche se di tutto questo tempo non abbiamo coscienza.
Certo è curioso pensare che l’evoluzione ci abbia dotato di questa capacità così singolare: ad un certo momento il nostro cervello piomba in un altro luogo, cambia completamente attività e ne succedono di tutti i colori. Una sorta di seconda vita che, con la luce del giorno, svanisce o lascia solo flebili tracce. Un’attività che, evolutivamente e non solo, risulta ancor più paradossale se si considera che mentre sogna il cervello richiede una quantità di ossigeno e di zuccheri addirittura superiore a quella consumata da un cervello sveglio e pensante. Impensabile, dunque, che l’attività onirica non abbia una funzione importante.
Come ti risveglio la coscienza
Il giardino di Albert 07.06.2018, 11:35
Contenuto audio
Di fatto, malgrado il sogno sia, neurologicamente parlando, un’allucinazione, una sorta di delirio, noi vediamo, sentiamo, sperimentiamo cose che non esistono vivendo quello che sogniamo con le stesse modalità percettive delle esperienze che facciamo durante la veglia. Ma allora, che ne è della coscienza? Anche nei sogni c’è coscienza?
Sogno e coscienza sono un binomio fino a non molto tempo fa ritenuto del tutto improbabile, giacché i sogni sono sempre stati collegati all’inconscio. Invece le ultime ricerche in campo neuroscientifico dimostrano che i sogni sono di fatto una finestra sulla coscienza e sui suoi disturbi.
Negli ultimi anni i sogni sono stati studiati nel loro aspetto neuronale, come un prodotto del nostro cervello, aldilà delle interpretazioni offerte dalla psicanalisi, dalle religioni e spesso anche dalle pratiche esoteriche. E dunque perché sogniamo e che cosa rappresentano i sogni nel percorso della coscienza?
I benefici dei brutti sogni
RSI Info 09.06.2021, 17:20
Alla domanda “perché si sogna?” la scienza non ha ancora fornito una risposta chiara. Ma ci sono molte teorie in proposito, e alcune ipotesi ben documentate.
I sogni potrebbero concorrere alla pulizia e alla riorganizzazione della plasticità cerebrale: se il sonno ripulisce il cervello da tutte le scorie del cervello che si formano durante il giorno, eliminando tutte quelle sinapsi che erano state create per assimilare informazioni rivelatesi inutili, il sogno potrebbe essere un epifenomeno di queste attività di pulizia e riorganizzazione della plasticità cerebrale. Ma questa è solo un’ipotesi.
Qualcuno parla del sogno anche come di una palestra emotiva per l’essere umano. Ricerche recenti come quelle di Matthew Walker (professore di neuroscienze e psicologia e direttore del laboratorio del sonno e di neuroimaging all’Università della California, a Berkeley) indicano che i sogni ci aiutano a elaborare le emozioni e a risolvere i problemi. In Why we sleep (2017) Walker rivela che almeno una delle funzioni del sognare è quella di “rimuovere gli spigoli emotivi della nostra vita quotidiana”. Quando le persone vedono immagini toccanti e poi le riguardano dopo aver avuto avendo il tempo di sognarle e digerirle, la loro reazione cambia in modo significativo: sono molto meno stressate da quelle esperienze.
Secondo altre ricerche il sogno aiuterebbe a fare scoperte creative e a risolvere problemi. L’ingresso nel sonno e l’uscita dal sonno, in particolare, sarebbero momenti particolarmente creativi – e non a caso sono utilizzati da artisti e scrittori proprio per cercare l’ispirazione. D’altronde quando sogniamo, le parti del nostro cervello associate all’elaborazione visiva e alle emozioni si scatenano, mentre le parti associate alla logica si spengono, lasciando più libera la creatività.
Quello che è ormai certo è la presenza della coscienza nei sogni, ambito di ricerca di cui si occupa da anni Marcello Massimini, neurofisiologo presso il Dipartimento di scienze biomediche e cliniche dell’Università di Milano e alla fondazione Don Gnocchi, interessato in particolare alla coscienza e ai suoi disturbi. Da tempo le sue ricerche stanno dimostrando come i sogni siano di fatto un modello importante per capire come funziona la coscienza e soprattutto dove cercarla e misurarla. E questo ha una ricaduta prima di tutto pratica: è infatti molto utile in clinica per valutare pazienti in coma, uno stato che per molti versi ricorda quello in cui tutti noi ci troviamo mentre sogniamo.
I sogni infatti sono esperienze vivide e intense che sono però tutte generate dentro il cervello, senza che quest’ultimo scambi un bit di informazione con il mondo circostante. Nel sogno il cervello è disconnesso sia dal punto di vista degli input sensoriali che da quello degli output motori; durante i sogni siamo quasi del tutto paralizzati. Ma finora, per valutare la capacità di un paziente in coma di capire, sentire ed essere in qualche modo cosciente, si utilizzavano solo protocolli funzionalisti: uno dei test tipici consiste nel chiedere al paziente di rispondere a delle domande stringendo un pugno o chiudendo gli occhi. Se ciò avviene, non c’è dubbio che il soggetto è cosciente.
Il problema insorge quando un paziente non risponde a questo protocollo input-output: infatti può darsi benissimo che il soggetto sia cosciente, capisca quello che gli si dice ma semplicemente non sia in grado di reagire (output), ad esempio a causa di una lesione delle vie motorie. Da qui l’idea di Massimini di studiare l’esistenza di isole di coscienza nei pazienti in coma o con gravi disturbi di coscienza, prendendo come modello il sogno e il suo funzionamento. Un problema reale che si incontra tutti giorni in clinica perché i pazienti potenzialmente in stato di coscienza disconnessa sono tanti: ben 50 mila solo negli Stati Uniti (cfr. l’articolo Trends in neurosciences: Are there islands of awarness?, scritto assieme al filosofo Tim Bayne e allo scienziato cognitivo Anil K.Seth).
L’intento di Massimini è quello di misurare se un paziente in coma possa essere un soggetto cosciente, valutando le capacità del cervello di sostenere non tanto un dialogo con l’esterno, bensì un dialogo interno. E capire così se gli strumenti dell’orchestra cerebrale – ovvero i tantissimi elementi con funzioni e caratteristiche diverse che compongono il cervello – siano in grado di interagire tra di loro producendo un dialogo complesso, che potremmo chiamare la sinfonia della coscienza. Il metodo sviluppato ricalca quello che avviene in un’orchestra: dare il la facendo partire uno strumento, per poi registrare la musica che l’orchestra produce. È quello che Massimini e i neuroscienziati attivi in questo ambito hanno fatto, bypassando le vie di senso e le vie di moto e andando a stimolare direttamente l’orchestra cerebrale, per vedere che tipo di musica produce. Se gli strumenti non parlano tra di loro, ovviamente non viene fuori un granché.
Concretamente i neuroscienziati hanno “bussato al cervello” utilizzando uno stimolatore magnetico transcranico, che attiva direttamente un gruppo di neuroni (una procedura non invasiva e del tutto indolore), registrando poi la “musica” elettrica prodotta dal cervello con l’elettroencefalografia. Misurazioni di questo tipo di si possono compiere anche in pazienti che sono completamente disconnessi sul versante sensoriale e motorio. L’assunzione è che quando la coscienza è presente, il cervello dovrebbe produrre una musica ricca e complessa, dovuta all’interazione tra tutte le sue parti, che dovrebbe svanire quando la coscienza si perde. In situazioni di veglia cosciente, infatti, a una stimolazione simile si ottiene una risposta complessa, nel senso che pur stimolando solo un’area cerebrale è tutto il cervello a rispondere, e ogni sua parte lo fa con il suo timbro e con le sue caratteristiche, confermando così la presenza della coscienza. Quando invece il soggetto si addormenta in un sonno profondo e senza sogni, la risposta diventa paradossalmente più grande ma decisamente più semplice e anche più locale: si attiva cioè intensamente il modulo che è stato stimolato, ma tutto il resto non risponde. È come se il cervello si fosse disgregato, e la musica della coscienza si fosse perduta.
Massimini e i suoi colleghi hanno sviluppato questa tecnica di misurazione nel 2005, e nei successivi 15 anni l’hanno sperimentata in diverse condizioni, inclusi i sogni, dimostrando che anche se il cervello è disconnesso, anche se il soggetto non interagisce con l’ambiente, c’è sempre un’attività cerebrale complessa.
Il sogno dunque mostra che può esservi una coscienza molto presente anche in un cervello disconnesso. Molti fra i pazienti con gravi lesioni frontali, infatti, sono coscienti, a patto che sia integra la corteccia posteriore, che non a caso è proprio la zona che si attiva quando sogniamo. Grazie a queste acquisizioni Massimini è in grado di stanare le coscienze nascoste negli individui in uno stato definito vegetativo, perché questa capacità interna di complessità, la stessa che troviamo nel sogno, ci dice che il soggetto in realtà è sì disconnesso ma cosciente, e quindi non è davvero in stato vegetativo.
Il sogno dunque non solo ci permette di aprire una finestra sulla coscienza, ma per il neurofisiologo è addirittura un esempio di coscienza pura: mentre la veglia sarebbe una forma particolare di coscienza che ci serve per sopravvivere, che è modulata dai sensi e ci fa reagire all’ambiente in modo appropriato, il sogno è una forma “pulita” di coscienza, e proprio per questo particolarmente interessante da studiare.
E dato che noi siamo la nostra coscienza, forse aveva ragione Shakespeare quando scriveva che siamo fatti della stessa materia di cui sono fatti i sogni.