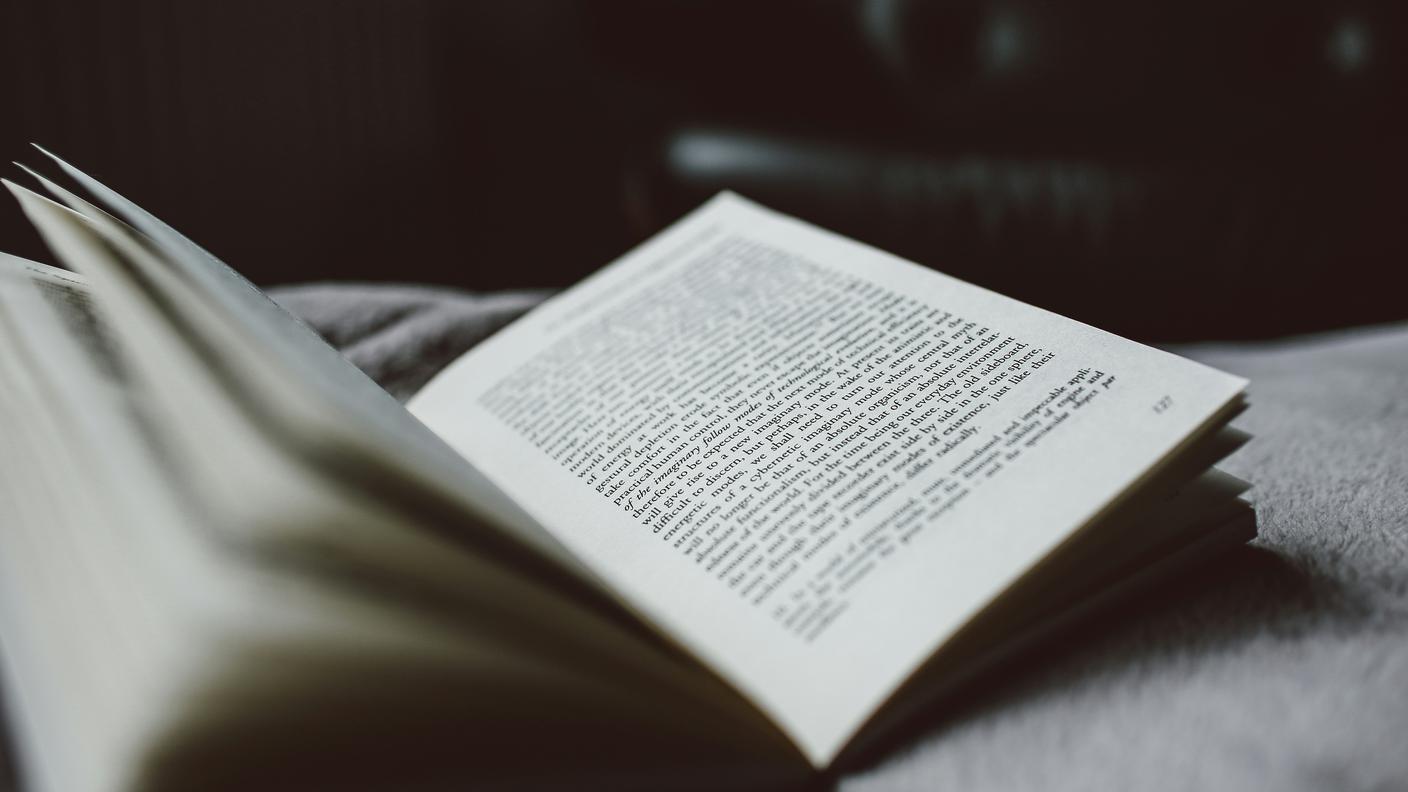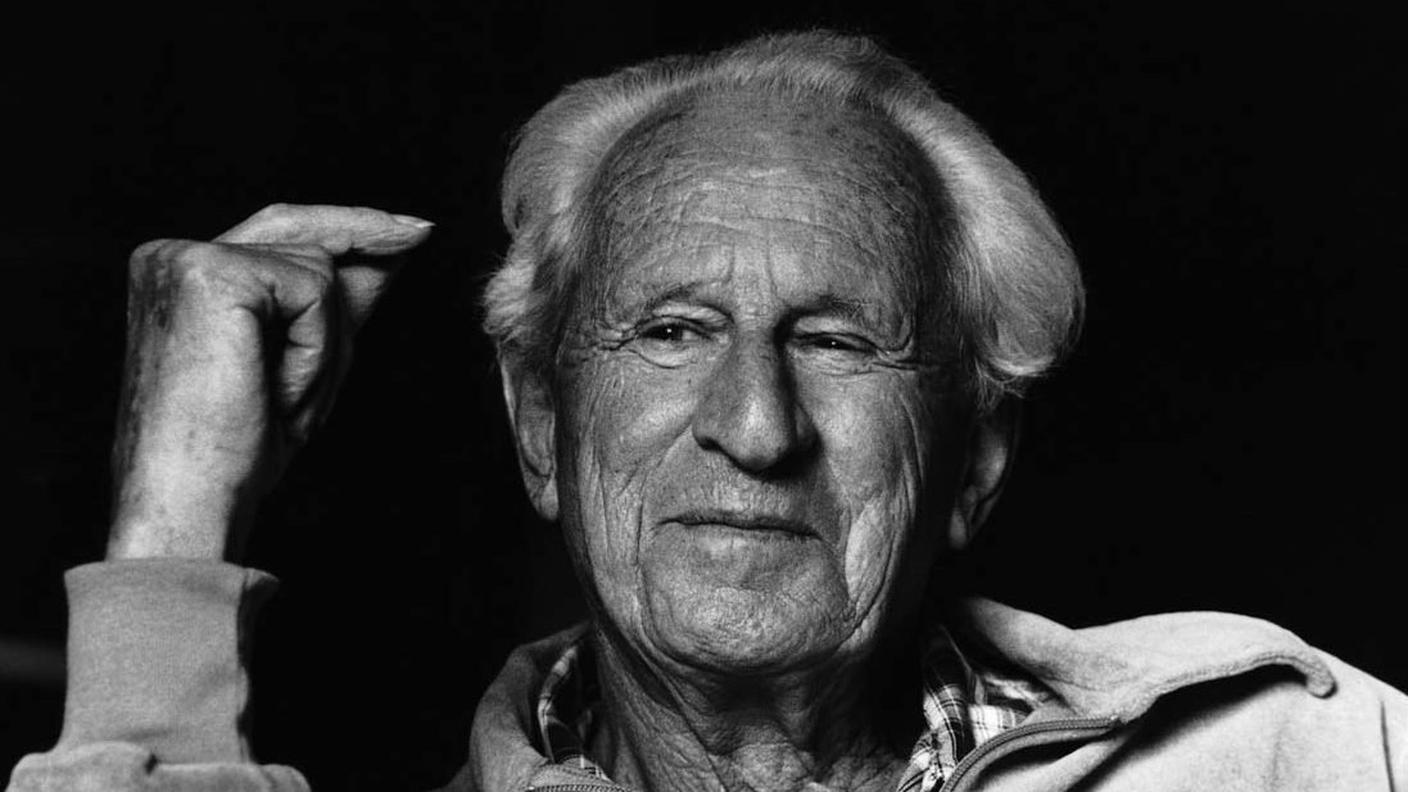«Che cosa lega la diffusione di un virus ai prodotti che acquistiamo ogni giorno sui banchi di un supermercato? Che vincolo c’è tra il tasso di cambio di una Borsa europea e il destino di una foresta tropicale? E che relazione esiste tra la crescita di un titolo azionario, l’espansione di una metropoli e la fusione di una banchisa polare? Domande di questo genere, che fino a qualche decennio fa potevano apparire bizzarre o provocatorie, hanno cominciato da tempo a farsi strada nel dibattito scientifico, aprendo la strada a risposte spesso più complesse e scivolose di quanto si sarebbe potuto pensare.
Riconoscere che la nostra presenza e la nostra organizzazione economica e sociale abbiano un profondo impatto sul pianeta che ci ospita, e che questo impatto sia sempre più devastante e imprevedibile nelle sue conseguenze, è infatti una conclusione recente e scomoda, capace di destabilizzare a fondo l’ottimismo che ha guidato lo sviluppo degli ultimi secoli».
Inizia così, con una serie di domande e considerazioni ‘scomode’ uno degli ultimi e tanti volumi dedicati alla crisi climatica e alle problematiche ecologiche, che però, contrariamente alla maggior parte di essi, non adotta un approccio strettamente ambientalista, ma sceglie invece di prendere in esame le cause, e dunque di analizzare le motivazioni storiche ed economiche all’origine dell’attuale situazione.
Il libro è Un autunno caldo. Crisi ecologica, emergenza climatica e altre catastrofi innaturali (Codice 2023) di Andrea Fantini, ricercatore in ambito socio-ambientale e di comunicazione scientifica presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari dell’Università di Bologna. Un saggio molto godibile, in cui l’autore ravvisa nel sistema economico dominante – fondato sulla crescita continua e lo sfruttamento sistematico degli ecosistemi e di altri esseri umani per creare profitti da reinvestire nel ciclo capitalistico – le dinamiche che conducono alla preoccupante situazione attuale. Un sistema che affonda le sue radici nel colonialismo, partendo dal processo di globalizzazione iniziato con la colonizzazione del Sud America, per poi svilupparsi nel capitalismo. Ne aveva già parlato, magistralmente, lo scrittore indiano Amitav Ghosh nel suo ultimo bellissimo La maledizione della noce moscata, che attraverso la storia emblematica e terribile del commercio di questa spezia spiega come all’origine della nostra crisi climatica contemporanea vi siano una storia di conquista e sfruttamento, sia della vita umana che dell’ambiente naturale, e una narrativa di crescita illimitata.
Quella di Fantini non è dunque una riflessione inedita, ma l’autore di Un autunno caldo ci offre una esposizione davvero molto approfondita e documentata, e un’analisi dell’evoluzione della società umana degli ultimi 500 anni che permette di far luce sull’intreccio tra crisi ecologica, emergenza climatica e dinamiche di riproduzione economica e sociale.
Perché, e questa è una delle tesi di fondo, non si può provare a limitare le conseguenze della crisi climatica se non se ne comprendono le cause scatenanti e i pilastri del sistema socio-economico dominante, riconoscendo «l’incompatibilità tra le dinamiche di conservazione e riproduzione del sistema in cui viviamo e quelle di rigenerazione della biosfera».
Anche perché, come evidenzia il ricercatore romagnolo riferendosi pure ad eventi emblematici come la pandemia, la crisi economica e l’alterazione climatica, tutto nel nostro mondo è correlato, giacché l’interdipendenza è la dinamica di base dell’universo e del nostro viverci: «quelli che potevano sembrare aspetti separati – ecologici, sanitari, economici, sociali e politici – sono in realtà correlati, e la loro complessa e intima interazione segna profondamente il nostro modo di stare al mondo».
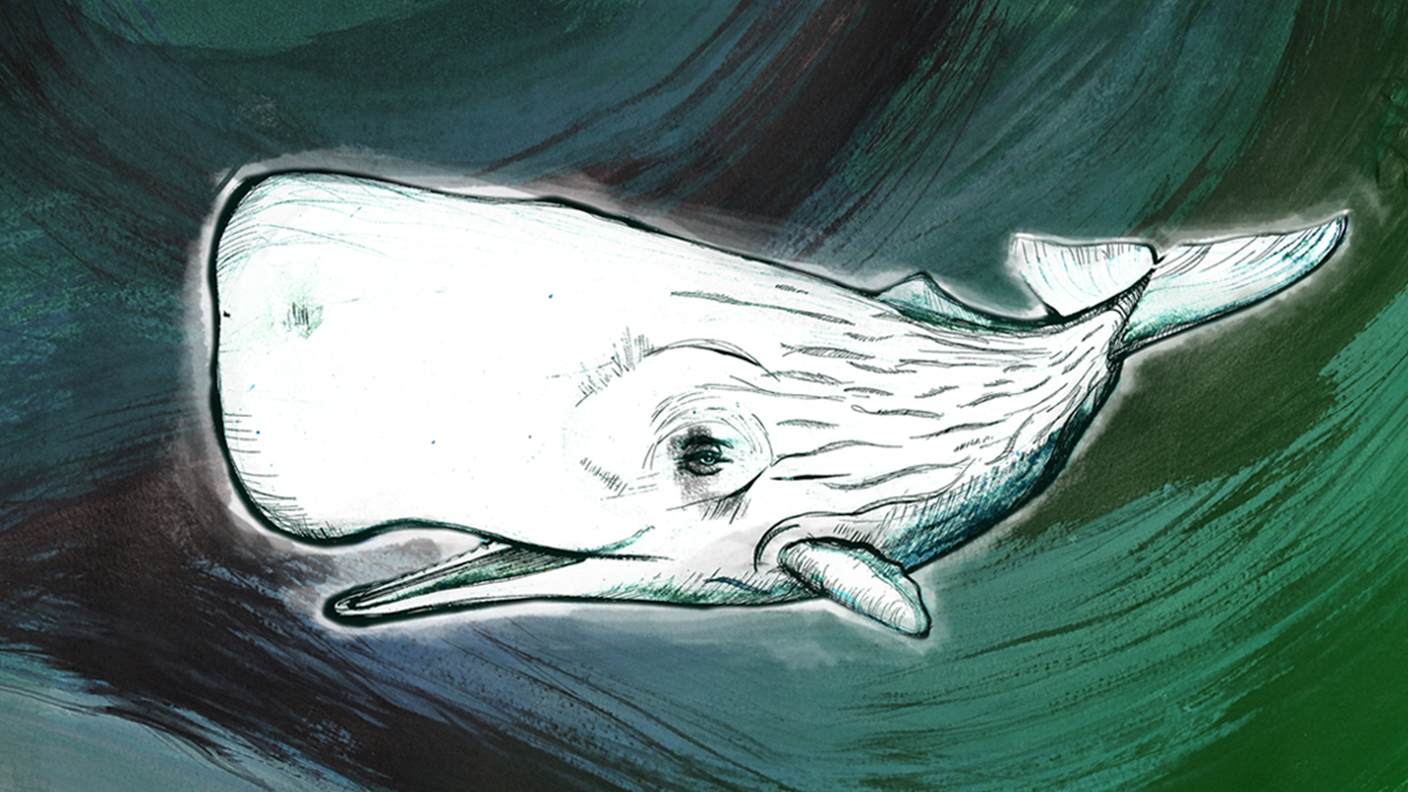
Siamo pronti a cambiare vita?
Moby Dick 28.11.2015, 11:00
Contenuto audio
Ad arricchire l’attenta e approfondita disamina storica dei nodi reali della questione climatico-ecologica, vi è pure una presa in esame di tutti quei pionieri delle scienze che già a partire dal ‘600, ma soprattutto dal ‘700 e ancor più dalla seconda metà dell’800, avevano parlato dei cambiamenti climatici e dell’attività umana nel suo diventare vera e propria ‘forza tellurica’, in largo anticipo sull’odierno concetto di Antropocene. Basti pensare che già nel 1873 il geologo italiano Antonio Stoppani aveva coniato il termine Antropozoico per designare la nuova era caratterizzata dall’impatto dell’uomo sull’ambiente. Ancor più sorprendente come già la mitologia e la filosofia greche si soffermino spesso sulle conseguenze funeste dell’aggressione ai danni della Natura. È il caso del mito di Erisittone, «avido re di Tessaglia, che, dopo aver abbattuto un bosco sacro a Demetra, viene condannato dalla dea dei raccolti a una fame insaziabile. Così, dilapidata ogni ricchezza, il sovrano è spinto fino a darsi lui stesso la morte, divorando, un arto dopo l’altro, sé stesso».
Ma il libro, che ha il grande merito di non indulgere nel catastrofismo, non ha come obiettivo solo ‘individuare e descrivere i processi, le ramificazioni e le dinamiche di fondo di un sistema insostenibile’, ma anche definire una serie di strumenti teorici e pratici che aprano lo sguardo ad alternative reali, a partire da dati ed esperienze concrete rintracciabili nell’ampio corredo di note (si veda per esempio il concetto del buen vivir, affermatosi in America Latina come risposta all’estrattivismo e alle politiche imperialiste e neocolonialiste). Perché se da un lato non si può provare a limitare le conseguenze della crisi climatica se non se ne comprendono le cause scatenanti, riconoscendo «l’incompatibilità tra le dinamiche di conservazione e riproduzione del sistema in cui viviamo e quelle di rigenerazione della biosfera», dall’altro bisogna cercare di immaginare un modo diverso di stare al mondo, cercando di superare «la dipendenza materiale e psicologica dal sistema in cui viviamo, i potenti interessi in gioco e i mezzi da essi dispiegati, il timore di destabilizzare certezze consolidate e una serie di abitudini percettive che ci impediscono di cogliere, in tutta la loro ampiezza e gravità, gli eventi che abbiamo di fronte, spesso troppo grandi per la nostra immaginazione e la nostra capacità raziocinante». Un’analisi e una riflessione seria e lucida, a fronte di una carenza di idee e proposte che disertino i percorsi prestabiliti e si allontanino dallo status quo del sistema in cui viviamo, e della sua narrativa che impone per lo più percorsi obbligati. Un sistema in cui siamo talmente immersi da non riuscire più a immaginare un altro modo di stare al mondo. Un po’ come quei due pesciolini che, alla domanda del pesce più anziano ‘com’è l’acqua oggi ragazzi?’, rispondono perplessi: ‘l’acqua? Cos’è l’acqua?’.
Ma il modo ci sarebbe: un modo in cui la relazione e la cura – e non più l’espropriazione, la separazione, la mercificazione, «i tre processi con cui si è imposto e continua a imporsi il sistema economico e politico attuale»– siano i veri pilastri su cui costruire il nostro rapporto col pianeta e con tutti gli esseri viventi, umani e non, riconoscendoci come parte di una rete complessa e interdipendente.
Per arrivarci è necessario rafforzare la cooperazione internazionale e implementare accordi globali per affrontare le sfide ambientali, così come investire nell’istruzione pubblica e nella ricerca scientifica. Ma non solo: occorre infatti costruire anche una nuova narrazione, perché non basta ‘sapere’: noi umani siamo soggetti simbolici bisognosi di narrazioni simboliche. Quando le cose sono solo ‘sapute’, basta una crisi o un’emergenza e tutto il resto finisce sullo sfondo. E prevale l’immediatezza del vissuto e quella che Fantini definisce la grande «perizia gattopardesca e autoassolutoria che regna ai piani alti delle nostre società».