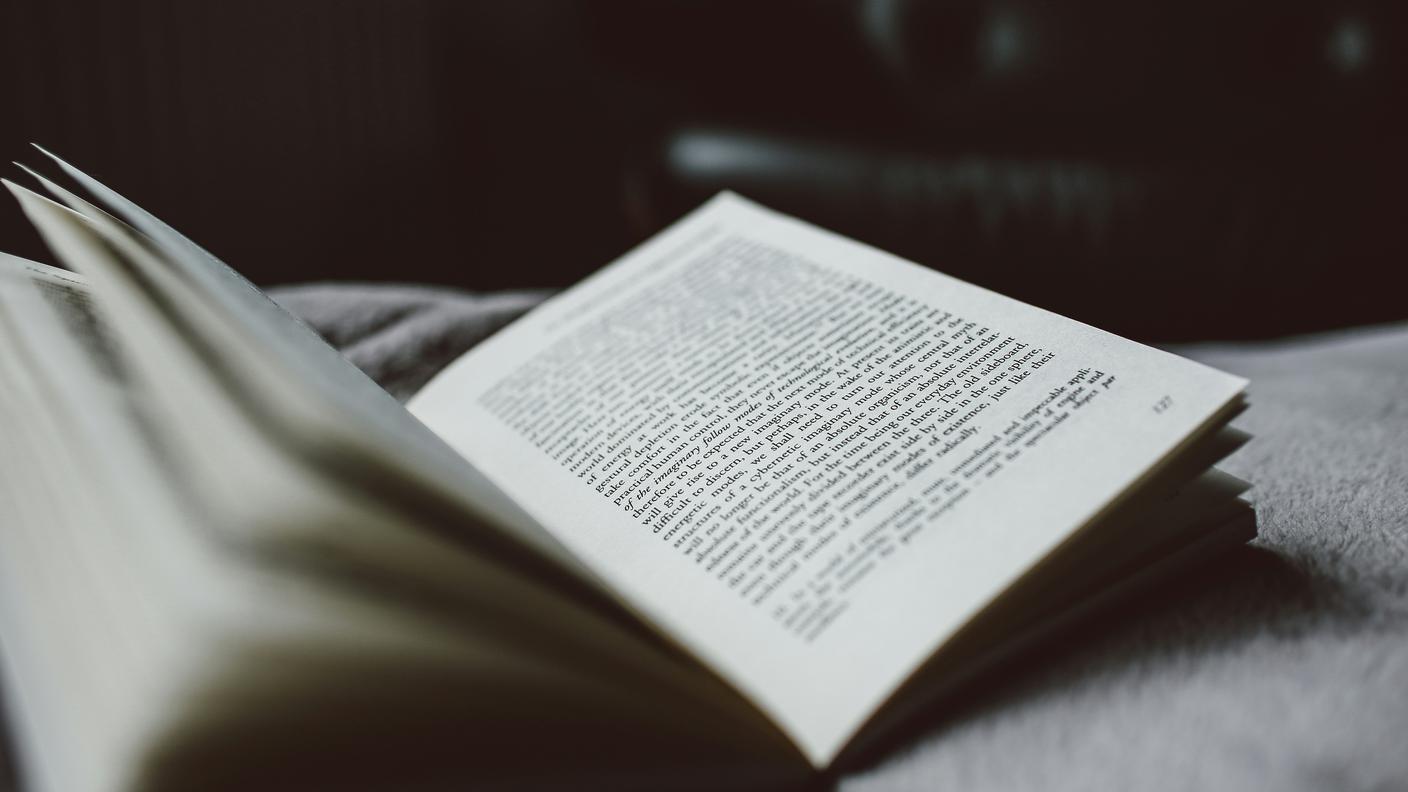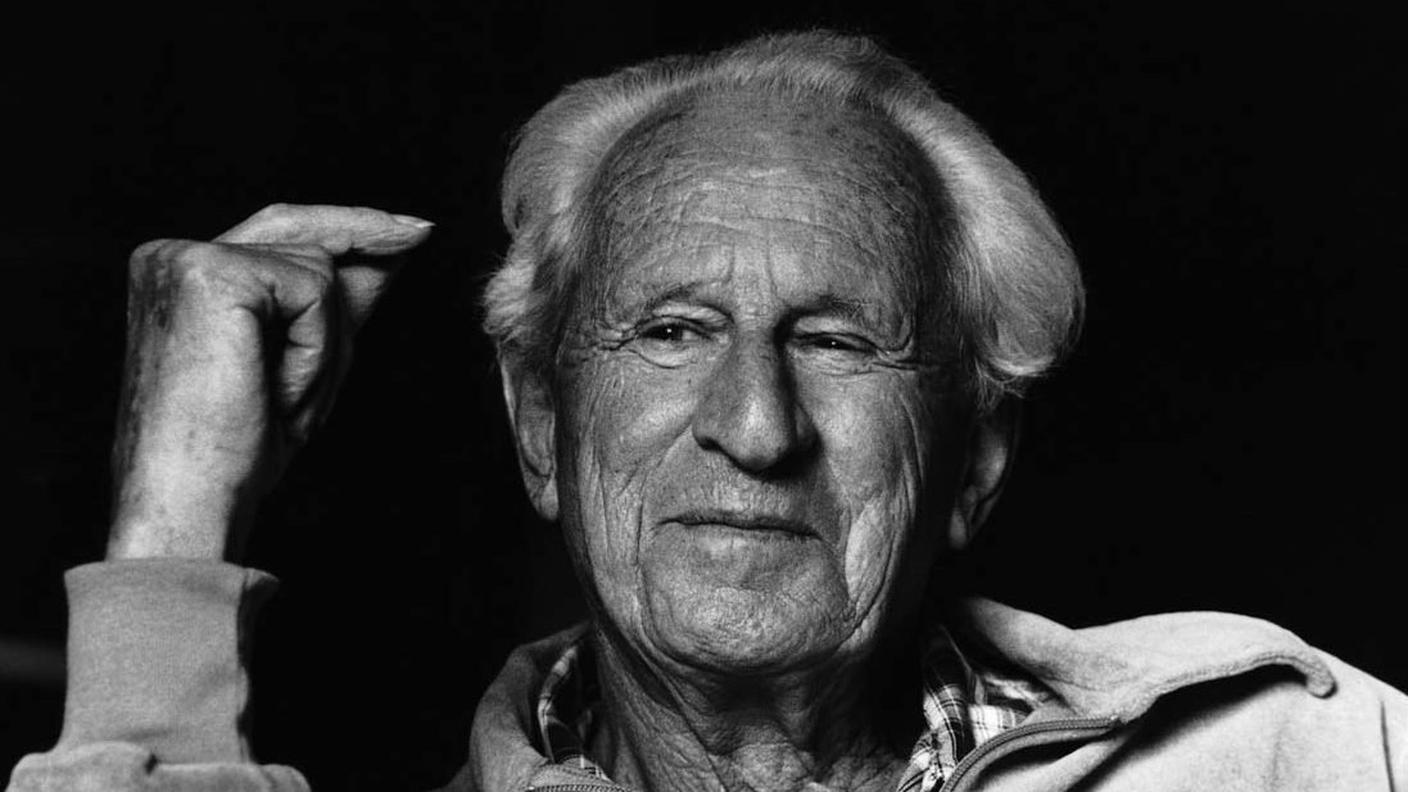Siamo nell’era dell’antropocene, era in cui l’umanità sta alterando gli ecosistemi a causa di un comportamento espropriativo e distruttivo rispetto al resto della natura di cui fa parte. Questo comportamento mette a rischio non solo il sistema, ma la stessa vivibilità dell’essere umano. Per evitare l’autodistruzione risulta inderogabile fissare delle regole che salvaguardino la riproducibilità delle risorse, evitando l’abuso e l’estinzione degli elementi.
Il problema sta nel trovare una base legale cui fare riferimento. Il principio suggerito da alcuni risiede nel costituire una Carta planetaria che si fondi sul riconoscimento di un’alleanza fra uomo e natura, la cui alterazione determina la gravità della colpa. Potremmo trovarci ad un punto di svolta, anche da un punto di vista giuridico, ma non si vedono segnali mondiali che muovano nelle direzione suggerita.
La proposta è certo ardita, perché significa superare i sovranismi nazionali in un’epoca in cui ancora vivono e imperversano. La chiamata a fissare delle regole per smettere di estrarre sempre più risorse dalla terra senza preoccuparci della loro riproducibilità, è una chiamata che ciascuno tende a declinare secondo le proprie specificità territoriali, e non secondo una coscienza planetaria e un’ottica di solidarietà internazionale.
La necessità di un nuovo costituzionalismo che tenga conto di interessi collettivi è inderogabile. La salvaguardia di beni fondamentali (come l’acqua potabile, l’aria, il clima, i ghiacciai e il patrimonio forestale) impone che essi vadano sottratti a logiche di mercato e vengano vincolati, resi intangibili con l’introduzione di garanzie planetarie. Utopia? Forse, ma c’è chi ci sta lavorando. Già Wilson (uno dei più importanti biologi e naturalisti del mondo, professore emerito di Biologia alla Harvard University e vincitore di due Pulitzer, aveva proposto un patto che salvaguardasse « metà della terra », individuando in questo patto la conditio sine qua non per affrontare la crisi ecologica e la vivibilità per gli esseri umani.
Per arrivare a una carta planetaria condivisa dagli Stati sovrani occorrerà forse non proporla come una forma di legislazione sovranazionale, difficilmente sussumibile, bensì come un semplice decalogo di limiti e vincoli, imposti a tutti a garanzia della convivenza plurale, dove l’eterogeneità dei popoli si declina trasversalmente, in un confronto reciproco, che non neghi le identità ma le faccia dialogare nella complessità e nella interazione fra le parti. E la logica del « noi » che deve precedere quella dell’io, in modo che l’evoluzione sia garantita. È una logica che le forme vegetali e animali conoscono molto bene (in nome della salvaguardia della specie), ma che l’uomo, nella sua superiorità razionale, fatica a introiettare.
Gli squilibri ecologici attuali sono insostenibili. La alterazione è storia antica e è basata sull’estrazione. Estrazione che nell’ultimo periodo ha subito un’accelerazione esponenziale e distruttiva. L’urgenza di cambiare approccio è impellente. Se non una costituzione planetaria, perlomeno un decalogo diventa inderogabile. La sua stesura dovrà contemplare non solo gli squilibri ecologici ed estrattivi, ma anche le dinamiche produttive (soprattutto quelle inutili) ed il mercato. Ed ecco allora il decalogo, che non si pretende esaustivo ma indicativo di una via:
Evitare le catastrofi ecologiche
Ridurre l’inquinamento (zero carbonio)
Ridurre la produzione, soprattutto di elementi inutili (in primis, verrebbe da dire, le armi)
Riequilibrare lo sviluppo mondiale
Evitare le deforestazioni
Gestire in modo solidale il patrimonio dell’acqua
Evitare la sovraproduzione di cibo
Diminuire gli allevamenti e le colture intensive
Salvaguardare la biodiversità
Equità nella distribuzione delle risorse