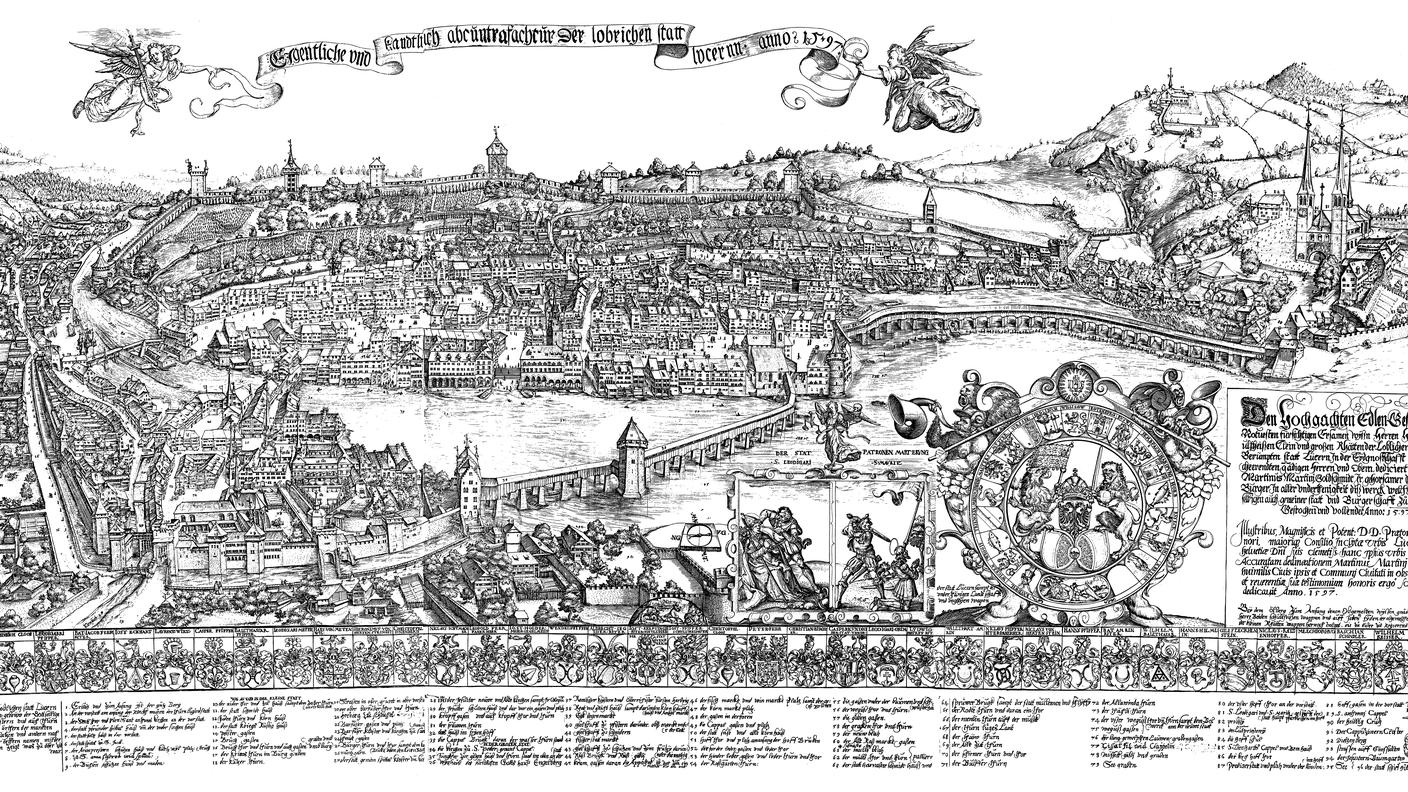Jena è la città da cui il Romanticismo sembra partire, l’epicentro intellettuale e culturale della Germania dei primi decenni del 1800. Da Jena passano e soggiornano Fichte, poi i fratelli Schlegel, le loro mogli, Schelling, Novalis e naturalmente Hegel. Il Romanticismo è stato un movimento europeo complesso e variegato, di cui oggi abbiamo una percezione spesso parziale o edulcorata. Se tentiamo allora di andare alle radici concettuali o filosofiche del romanticismo, potremmo dire, semplificando ed esagerando forse anche un po’, che probabilmente non ci sarebbe stato il romanticismo senza il romanticismo tedesco e che allo stesso modo non ci sarebbe stato il romanticismo tedesco senza la città di Jena. Ebbene, su Jena abbiamo interpellato uno dei più grandi critici del Romanticismo tedesco, Peter Neumann. Peter Neumann è filosofo tra i redattori del feuilleton del settimanale tedesco Die Zeit, autore di alcune raccolte poetiche e di diversi saggi, fra cui appunto Jena 1800, La Repubblica degli spiriti liberi, tradotto in italiano da Rossana Lista per Einaudi.
Cominciamo dal quadro generale. Peter Neumann Che cosa ha di particolare Jena negli anni intorno al 1800? Lei in una delle prime pagine del libro, la descrive come cito Epicentro intellettuale e culturale della Germania.
Ed è vero. Intorno al 1800, Jena era il centro intellettuale e culturale forse non solo della Germania, ma di tutta l’Europa. Bisogna immaginare che i romantici di Jena entrarono in scena quando l’Europa stava vivendo un periodo di grandi sconvolgimenti ed era a un punto di svolta. C’era la guerra, c’era la rivoluzione in Francia. E come c’era la rivoluzione in Francia – una rivoluzione politica – c’era anche una rivoluzione filosofica. iniziata a Königsberg, l’odierna Kaliningrad, dove Kant iniziò la cosiddetta “rivoluzione copernicana”. Così come Copernico aveva cambiato il modo in cui noi esseri umani guardiamo il mondo, anche Kant lo aveva cambiato. Nessuno sapeva esattamente cosa avesse detto Kant e nessuno era sicuro di quanto si potesse, o dovesse, interpretarlo. Ma Jena intorno al 1800 fu, per così dire, il primo luogo in cui sono arrivate, sono state discusse e poi sviluppate ulteriormente queste idee kantiane di libertà, autodeterminazione e, in una certa misura, di rifiuto delle vecchie dimostrazioni metafisiche di Dio. Credo che il modo migliore per riassumere questo periodo sia riprendere una citazione dall’Amleto di Shakespeare, il famoso “the Time ist Out of Joint”, il tempo è scardinato. Questa è esattamente la situazione a Jena intorno al 1800.
E non c’è città, però senza persone. Le chiedo quindi subito quali sono i personaggi, o meglio i protagonisti, diciamo così, di quella fantastica, ancorché relativamente breve, convergenza? E poi in che modo hanno influenzato la cultura tedesca e il pensiero filosofico e non solo, per carità, della Germania?
In realtà erano tutti presenti, all’epoca, ed è il bello di questa costellazione, ancora oggi affascinante: ci sono Goethe e Schiller, i fratelli Humboldt, Johann Gottlieb Fichte, il filosofo Hegel, e naturalmente abbiamo i romantici, gli stessi primi romantici, i fratelli Friedrich e August Wilhelm Schlegel, le loro mogli Caroline Schlegel e Dorothea Veit... Questa folla di persone si riunisce e si interroga. Conosciamo tutti la risposta di Kant alla domanda “cos’è l’Illuminismo?” Kant disse: “è avere il coraggio di servirsi della tua propria intelligenza”. E allora, in un certo senso, il romanticismo non è un contro-illuminismo, ma un movimento che illumina l’Illuminismo su sé stesso, sui suoi punti ciechi, sui suoi lati nascosti e invisibili. In altre parole, l’Illuminismo ha bisogno di una controparte, di qualcuno che lo porti alla ragione, e Kant aveva risvegliato la ragione dal suo sonno dogmatico e aveva invitato le persone a intraprendere il cammino per uscire dal loro stato di ignoranza autoinflitta. I romantici sono i primi ad aprirsi a questo impulso e vogliono metterlo in pratica una “comunità politica”, per così dire. Ragionare, per i romantici, non significa solo calcolare e pensare freddamente: significa anche bellezza, arte, pensiero libero ed estetico. È questo che ci rende persone veramente libere.
Il sottotitolo del suo libro Jena 1800. Lo trovo più che significativo La Repubblica degli spiriti liberi. Le chiedo comunque perché ha scelto questi termini e soprattutto questo binomio Spiriti liberi?
Questo è ciò che veniva richiesto intorno al 1800. Lo spirito deve essere libero, cioè senza limiti, deve estendersi a tutti i settori. Non c’è nessun campo della realtà che i romantici non abbiano coltivato intellettualmente. In altre parole, sappiamo che Novalis che ha lavorato nell’industria mineraria. Sappiamo che Goethe che si è occupato anche di botanica, anatomia e meteorologia. Sappiamo che fratelli Schlegel che hanno lavorato anche nel campo della traduzione e della teoria letteraria. Tutti ambiti che non devono essere lasciati fuori da ciò che si intende per “attività intellettuale”. E poi c’è il famoso “Frammento 116” di “Athenäum”, un “protomanifesto” romantico – diciamo così – in cui Friedrich Schlegel dice che la poesia romantica è una poesia universale progressiva, il che significa che dovrebbe comprendere tutto, e dovrebbe aiutarci a capire il mondo, a fare progressi, a emanciparci. E così ci si riunisce e si filosofeggia nella Leutra-gasse 5 a Jena, dove appunto i romantici vivono insieme in una sorta di appartamento condiviso.
Dicevamo, non c’è città senza uomini, senza intellettuali in questo caso, e non ci sono intellettuali senza luoghi dove scambiarsi le idee. Allora le chiedo anche cosa ha rappresentato per quel periodo la rivista Athenäum dei già citati fratelli August Wilhelm e Friedrich Schlegel. Eccessivo dire che si tratta un po’ anche qui, del Manifesto delle idee o delle teorie degli intellettuali di Jena. E poi che tipo di contenuti presentava questa rivista?
Sì, be’, ho appena parlato del “Frammento 116” di Athenäum, di questa poesia universale progressiva. È quello che succede su Athenäum. Che è un giornale, una rivista dei primi romantici, di cui escono sei numeri tra il 1798 e il 1800; ed è in realtà la rivista centrale, dove le idee più importanti vengono comunicate e diffuse. È il luogo del dibattito, l’agorà del romanticismo. I famosi “Inni alla notte” di Novalis, ad esempio, appaiono nell’ultimo numero . Si tratta di una rivista non molto lunga, ma molto densa. Del resto, vale anche la pena ricordare come più in generale la fondazione di riviste fosse molto popolare nel periodo intorno al 1800, perché c’era un pubblico borghese che stava emergendo. Jürgen Habermas ha in seguito descritto questa convergenza come il cambiamento strutturale della sfera pubblica, intorno al 1800. E la cultura borghese emergente aveva naturalmente bisogno di organi di pubblicazione per informarsi su di sé. In un certo senso, è così che si è emancipata dalla vita di corte e dal sistema di governo assolutista; e le riviste come Athenäum erano ovviamente centrali. E molto, molto importanti.
Jena 1800: la repubblica degli spiriti liberi
Alphaville 15.01.2024, 12:05
Contenuto audio
Peter Neumann, lei come riassumere le idee fondanti del romanticismo da un punto di vista filosofico, tenendo presente che poi le diverse discipline artistiche e la diversità culturale europea hanno prodotto evoluzioni anche diversissime fra loro.
Curiosamente, esiste il pregiudizio contro il romanticismo come di un movimento intellettuale libero e un po’ sbiadito, o semplicemente passionale. In altre parole, il pregiudizio suggerirebbe che il romanticismo si sia semplicemente innamorato di sé stesso, in una celebrazione sconfinata della soggettività, piuttosto inconsistente quando si tratta di Stato, società, coesistenza sociale. Ma è, appunto, un pregiudizio. Hegel pone il mondo al di sopra del romanticismo, ma anche più tardi, nel XX secolo, Carl Schmitt, György Lukács e il movimento del ’68 mostreranno un pregiudizio tenace nei confronti del romanticismo. Penso sia sbagliato associare sempre il romanticismo alla soggettività, pur conoscendo il detto di Novalis, per cui ovunque andiamo, torniamo sempre a casa. Non credo che sia sempre e solo la strada verso casa, verso l’interiorità e verso la propria soggettività: credo che il romanticismo sia un confronto con la fragile realtà del mondo intorno al 1800. In altre parole, credo che il romanticismo sia un movimento che comprende sé stesso e il mondo, un movimento in cui s’intrecciano la comprensione della natura e dello spirito, la sensualità, il pensiero, il sentimento. I Romantici ci mostrano che esiste un altro lato dell’essere umano: non solo quello che pensa, ma anche quello che sente e si emoziona. E penso che questo sia molto, molto importante per comprendere le persone in tutta la loro diversità e in tutte le loro sfaccettature.
Peter Neuman lei ha fra l’altro studiato anche a Jena che cosa è diventata Jena dopo quegli anni d’oro e quell’eredità unica ma forse anche scomoda.
L’idealismo tedesco o il romanticismo tedesco, in cui mi sono specializzato per il mio libro, è in realtà un’invenzione della storiografia nazionale del XIX secolo. Bisogna essere onesti. Dopo l’arrivo delle truppe napoleoniche e la sconfitta della Prussia, tutto quello che era accaduto a Jena è stato integrato molto rapidamente in una “storiografia nazionale”: Kant, Goethe, Schiller, Hegel, i fratelli Schlegel furono stilizzati come grandi personalità nazionali. È noto, per esempio, che i soldati tedeschi parteciparono alla prima guerra mondiale con Hölderlin nei loro zaini. Sono questioni da tenere d’occhio quando si ha a che fare con questa tradizione con questa eredità storica complessa. E al tempo stesso, al di là delle strumentalizzazioni dei romantici o dei classici tedeschi, c’è pure un incredibile potenziale per riscoprirli, ossia per riscoprirli come la prima generazione del modernismo ad avere sviluppato un’attenzione per l’ambiguità della realtà. Per l’oscurità e l’inconscio. Dovunque si guardi, ci sono sempre cambiamenti, rotture, crisi esistenziali. Nulla può essere dato per scontato, e questo è un motivo per cui vale la pena riscoprire questi primi romantici, questi romantici di Jena, perché sono davvero al passo coi tempi e portano avanti l’idea che il mondo sia in realtà in uno stato di rivoluzione permanente. Credo che questo sia un sentimento oggi a noi molto familiare.