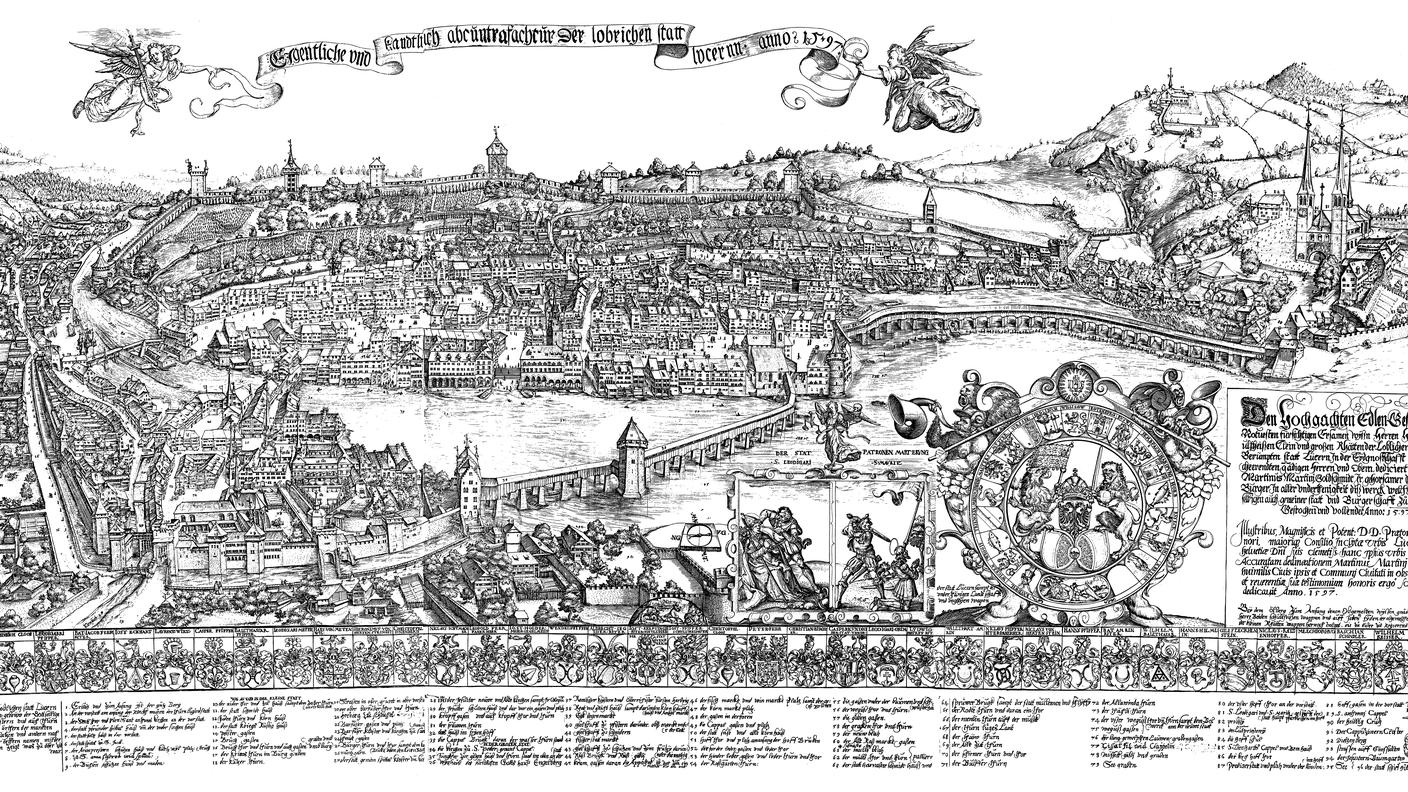Figli miei, tirati per la giacca da tutte le nazioni, ragazzi non ancora dimenticati dal Fascio ma dai nomi già germanizzati dall’apparato militare dell’Impero.
Sono tante le «belle pagine», addirittura le «belle frasi», che costellano il racconto Come cavalli che dormono in piedi di Paolo Rumiz, un memoriale che riesce a essere romanzesco senza pretendersi un romanzo. E leggendolo mi accorgo che pur non essendo uno storico ritrovo nella sua «passione solitaria» per la Storia le ragioni più intime della mia idea di letteratura: disarticolare la Storia dalla versione imposta dai vincitori, recuperare l’uomo alla sua essenza e alla sua verità, a prescindere da come la Storia, cioè la Storia dei vincitori, l’abbia voluto stigmatizzare, oltrepassare l’orizzonte dell’ufficialità per raggiungere nell’intimo l’umano.
Ma per venire al merito del libro: a quale frangente della Storia in particolare Rumiz fa riferimento? A quella che fin dalle date viene troppo spesso chiamata la Guerra del ’15-’18, dimenticando che le sue scaturigini sono viceversa già agli albori dell’estate del 1914, soprattutto per quanti, nella Venezia-Giulia, fiera provincia dell’Impero austro-ungarico, dovettero scontare di essere prima e durante e dopo dalla parte «sbagliata» della Storia, quella imperiale prima e quella italiana dopo. «I miei italiani “in divisa sbagliata”, di cui per quasi un secolo non si è potuto parlare».
Un destino funesto, che Rumiz non salva dall’oblio solo in nome di un amore regionalistico, ma perché nel riandare alla caduta dell’Impero asburgico riconosce in essa la scaturigine di tutte le future sciagure: dall’avvento del fascismo all’abbrutimento dei costumi italici, dai beceri sovranismi al qualunquismo degli italiani. E perché quel momento particolare del Novecento è ipostasi di un’Europa nata nel segno di fervori nazionalistici che hanno tradotto l’idea di Europa in qualcosa di infinitamente meno nobile di quanto era nelle premesse prebelliche dei fasti e delle glorie mitteleuropee. Un’idea che si può condividere o respingere: ma che certo vale una riflessione su quanto di unificante e pacificante animò il grande periodo degli imperi.
«La guerra moderna si accanisce proprio sui mondi plurali e bastardi, allergici alle identità monolitiche. Non capisce che la pace è finita per sempre nel ’14, con la fine degli imperi, e che da allora la Terra trema ancora, sulle stesse linee di faglia».
Ma Rumiz non è nemmeno solo questo «speleologo del passato», dell’abominio della Storia quando decide per l’oblio ideologico di interi popoli. Né può essere annoverato fra quanti presumono sola legittima opera di storiografia interrogare il silenzio degli sconfitti. La sua analisi, le sue dettagliatissime ricognizioni, mirano in primo luogo a riportarci al tema millenario dell’ingiustizia ovvero della sconfitta come torto.
Il suo risentimento è dunque un vero e proprio appello alla dignità e al recupero dell’uomo dalle miserie del potere. E dalla penna che li rievoca – e quella di Rumiz è una penna particolarmente felice – sgorga l’imperativo dell’ascolto e dell’abbraccio dei vinti e dei dimenticati.
L’epica del libro non è naturalmente un’epica personale: è quella dei suoi personaggi, dei fantasmi umani riesumati alla memoria. E se quello di Rumiz è infine soprattutto un doloroso viaggio nei luoghi della dimenticanza – Galizia in primis – è nondimeno anche un viaggio autentico e appassionato di uno scrittore che non sceglie un argomento, non si presta a caso a questo o quel capriccio narrativo, ma vi appartiene aderendovi con tutto se stesso. Uno scrittore posseduto nella misura in cui imprescindibile è il suo sdegno di abitante del presente non meno che della memoria.
Si pensa al Danubio di Magris e anche al suo Non luogo a procedere? Certamente, ma poco importa. La cifra di Rumiz è nel confermare che Trieste continua a gridare, malgrado l’italocentrismo di Roma, la sua trasversalità e dignità oltre ogni imposizione di Stato e di ideologia. E forse proprio Trieste è l’ipostasi di tutti i dimenticati.