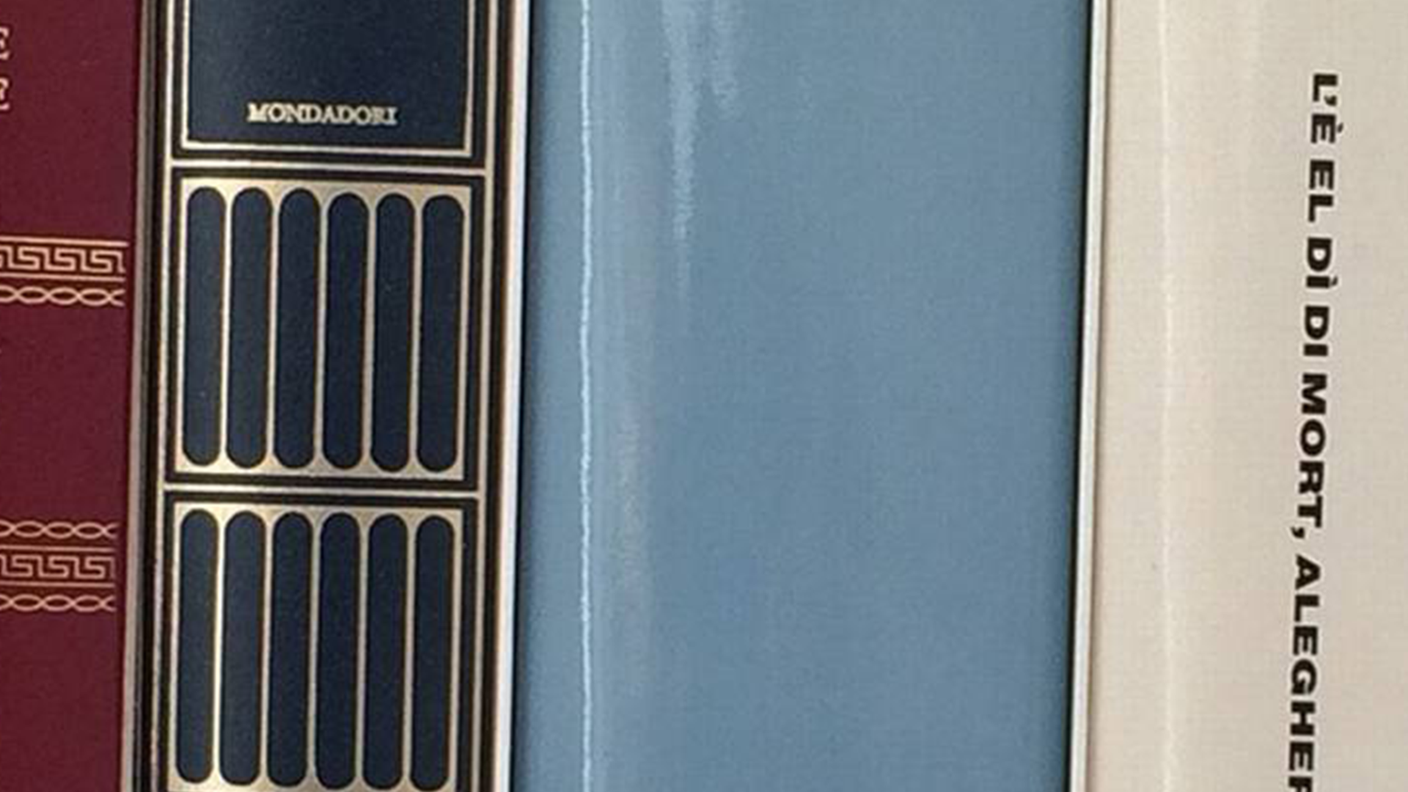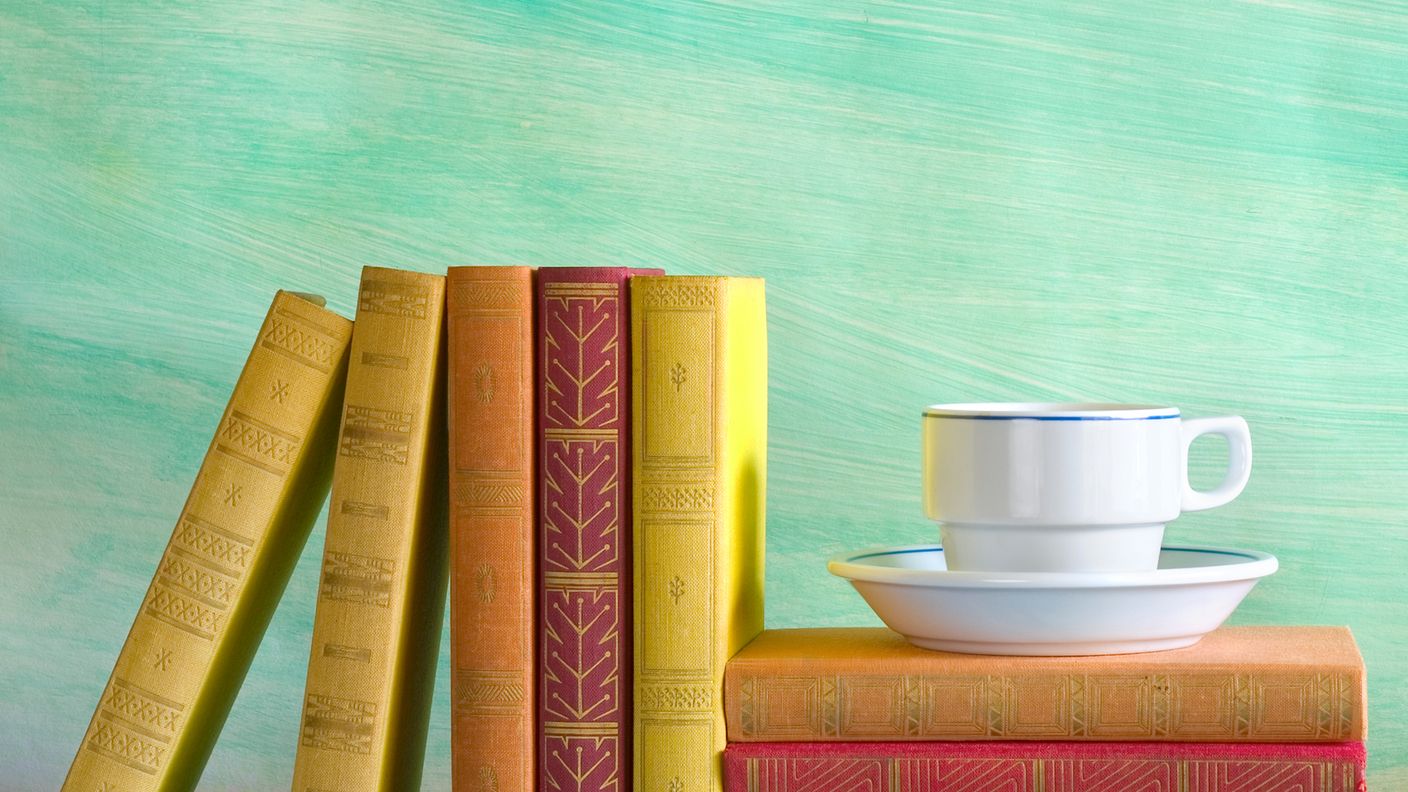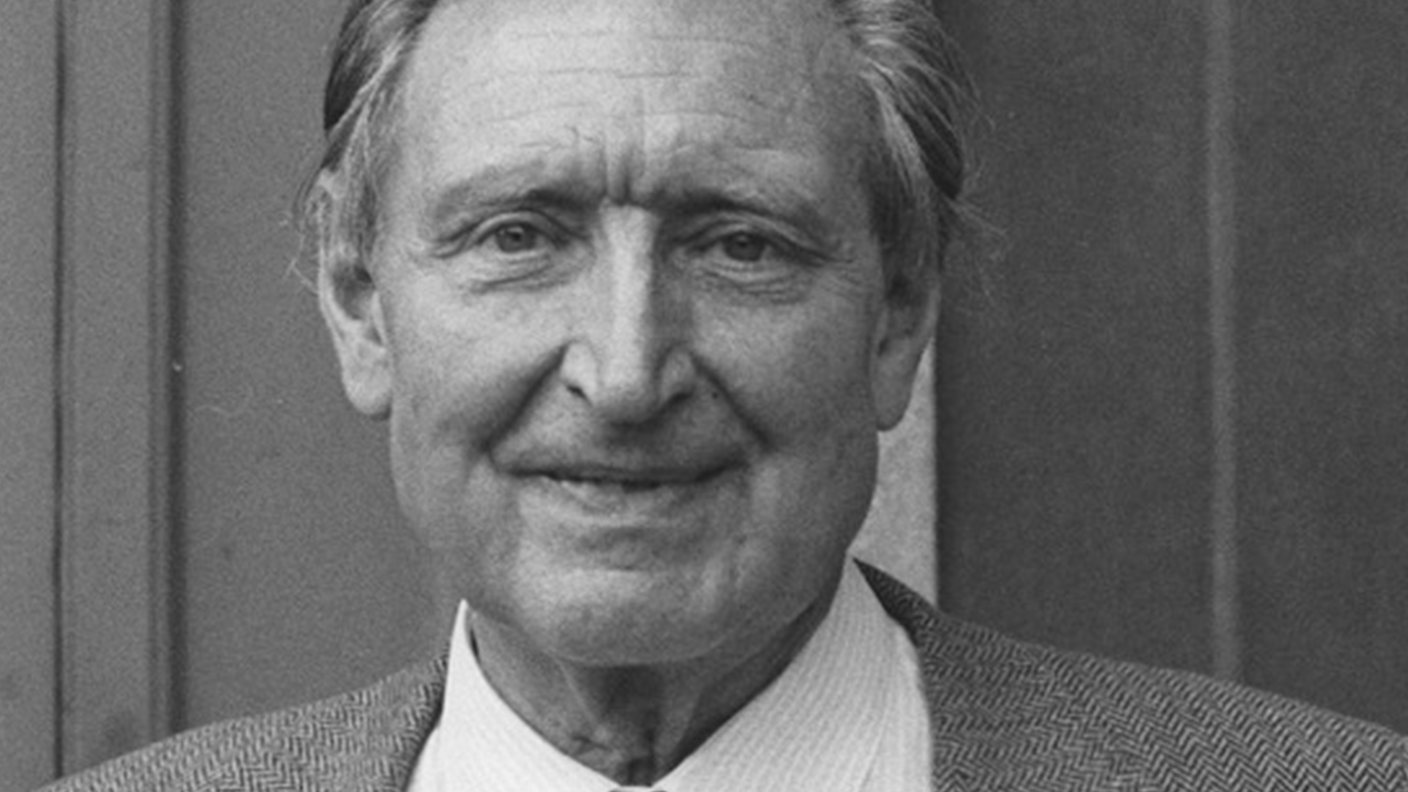“La marea si era alzata, […] l’unica cosa da fare era star fermi all’ancora e aspettare che la marea cambiasse. Il tratto finale del Tamigi si stendeva di fronte a noi come l’inizio di un’interminabile via navigabile.”
Ciao, sono Marta Pizzagalli e quello che vi ho letto è l’inizio di Cuore di tenebra, romanzo di Joseph Conrad. La storia inizia con una nave che attende sul Tamigi l’abbassarsi della marea; è allora che, nell’attesa notturna, il marinaio Marlow inizia a raccontare del suo viaggio avvenuto su un’altra imbarcazione e su un altro fiume, un viaggio compiuto per conto di una compagnia che commerciava avorio. Il romanzo si apre allora come un racconto di fiabe: qui non è però una nonna che racconta ai nipoti, ma un marinaio che narra ai compagni la sua avventura avvenuta nel cuore dell’Africa; narra delle popolazioni indigene incontrate e degli europei lì stabilitisi. Il libro viene prima pubblicato a puntate su rivista, nel 1899, poi edito in volume nel 1902. Io l’ho letto nella traduzione italiana di Flaminio Di Biagi, edito da Newton Compton. Conrad fu uno scrittore polacco naturalizzato inglese, prima di dedicarsi alla scrittura fu marinaio e viaggiò per mare fino all’Africa; viaggio da cui proviene l’ispirazione biografica del libro stesso. Lo scrittore viene talvolta affiancato a James Joyce per l’uso del cosiddetto “stream of consciousness”, il “flusso di coscienza” che conduce la narrazione da un punto di vista introspettivo.
In Cuore di tenebra, di Joseph Conrad, il narratore racconta alla prima persona e questo risalta immediatamente come un tratto peculiare: Marlow si mostra essere, infatti, un narratore non solo accurato, ma anche profondamente riflessivo.
Marlow racconta del suo viaggio nel cuore dell’Africa, con il compito di trovare e riportare indietro un certo Kurtz, uomo misterioso e di grande successo nel mercato dell’avorio locale, che viene venerato come una divinità dalla popolazione indigena, ma ora gravemente malato. “La sua era una tenebra impenetrabile”, così ne parla Marlow. Il tema del colonialismo è ben presente nella narrazione (e fortemente dibattuto dalla critica), ma non penso in realtà che sia il tema centrale del libro. La questione della prossimità del male al cuore dell’uomo mi sembra, infatti, il tema più urgente che Conrad comunica e Marlow testimonia.
Nel raccontare, il narratore rielabora e commenta ciò che vede, usando accostamenti di parole, aggettivi e similitudini molto forti e connotativi: afferma per esempio che “la silente regione selvaggia […] mi colpiva come qualcosa di possente e invincibile, come il male o la verità”. Lo stile di Conrad è affascinante e quasi dolorosamente introspettivo. Il “suo” Marlow non si limita infatti alla semplice registrazione dei fatti, come avviene più spesso nelle fiabe, ma li commenta e vi reagisce emotivamente. Il narratore ci comunica di continuo i suoi turbamenti davanti all’oscurità del cuore umano, che la profondità e la solitudine della foresta primigenia fa emergere con violenza.
Una delle cose che mi ha più colpita è il fatto che, nel mostrare il lato abominevole e disperato dell’umano, il narratore non lo giudica come un dato esterno. Anzi: egli ne soffre, soffre sulla propria pelle ciò che vede, perché lo riconosce dormiente anche in sé stesso. Questa mi sembra una questione non solo eternamente attuale, ma anche quasi presagio delle tragedie che poi, di fatto, sono seguite nel Novecento. In Marlow si percepisce il timore nei confronti dell’oscurità che incontra, non perché essa sia inopportuna, ma perché gli è interna, presente anche nel fondo dell’intimo.
Scopri la serie
https://www.rsi.ch/s/703926