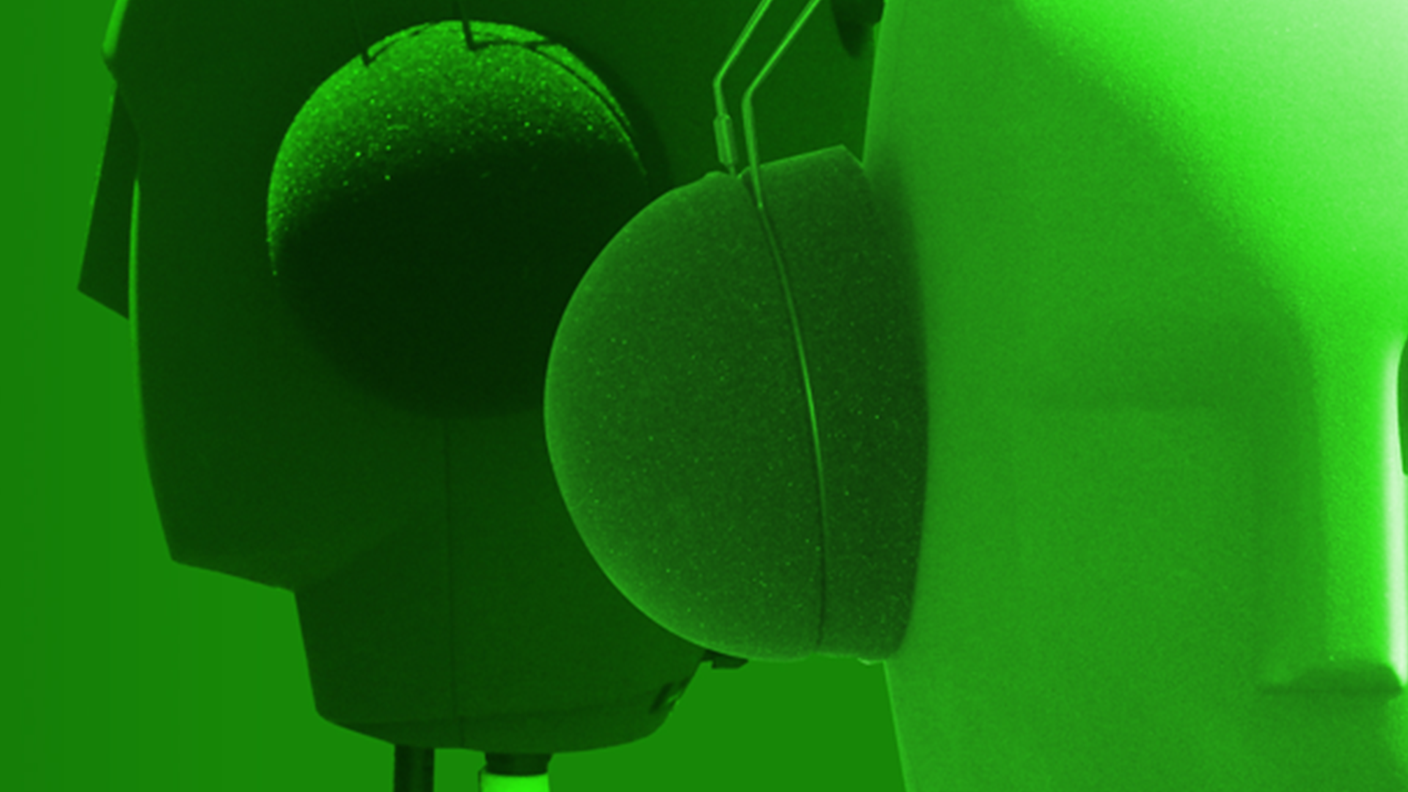Che cos’è la grammatica quando la si prende sul serio? E che nesso c’è tra la grammatica e la mente? Gli errori fanno progredire o regredire la grammatica?
Mi chiamo Giuliana Jane Santoro, sono una dottoranda in linguistica italiana all’università di Basilea e vorrei presentarvi “La grammatica presa sul serio. Com’è nata, come funziona e come cambia”, l’ultima fatica di Raffaele Simone, esimio linguista e professore emerito dell’università Roma Tre, editore Laterza.
Il libro mira a fare piazza pulita di dicerie e falsi miti in circolazione sulla grammatica, mettendo in evidenza come essa sia il punto d’arrivo di Homo sapiens che cerca un modo per esprimere quello che ha in mente.
Lungi dall’essere un insieme di prescrizioni minute e tediose, come spesso si pensa, la grammatica si rivela un territorio d’indagine affascinante, che dice molte cose sulle lingue ma anche sulla natura degli esseri umani. “La storia delle lingue è la storia della mente umana” sosteneva già Leopardi nel XIX secolo.
Ma come funziona la grammatica? Quando una persona parla o scrive applica una grammatica, cioè regole, meccanismi e principi di cui non ha alcuna coscienza esplicita. Nel farlo in modo corretto viene aiutata da quello che i linguisti dell’Ottocento hanno chiamato Sprachgefühl, il senso della lingua, vale a dire la percezione immediata di quello che la lingua può e non può fare, che suggerisce quello che è corretto e quello che non lo è.
ll libro “La grammatica presa sul serio” ci accompagna in un viaggio avventuroso tra le lingue, svelando somiglianze sorprendenti e sfuggenti al primo sguardo. I famigerati verbi separabili del tedesco o i phrasal verbs dell’inglese, cioè quei verbi costituiti da un verbo e da una particella che ha un po’ il compito di rifinire il significato del verbo (per es. give up, live up, ecc.), abbondano anche in italiano. Pensiamo a verbi come andare fuori, andare via, buttare giù, portare su, ecc.: sono i cosiddetti verbi sintagmatici, di cui nessuna lingua romanza – lo sapevate? - è ricca come l’italiano.
L’italiano non smette mai di sbalordire appena lo si analizza più da vicino: pensiamo per esempio alle parole alterate (diminutivi, accrescitivi, dispregiativi, ecc.) che si trovano soprattutto tra nomi e aggettivi e con le quali l’italiano ha un rapporto speciale. In inglese queste forme sopravvivono solo in poche voci cristallizzate, come booklet (libretto) o doggie (cagnetto). La stessa cosa accade in francese con filette (ragazzina), altrimenti il problema si risolve con l’aggiunta di aggettivi; in italiano invece le forme alterate sono molto produttive e hanno una grammatica del tutto irregolare. I nomi alterati si applicano ad alcune categorie e ad altre no senza un motivo visibile. Per es. si può dire che il ragazzo è biondino ma non è simpatichino, la casa è bellina ma non è vicinetta. Inoltre, molti alterati non indicano solo dimensione (come manina e palazzone) ma hanno una forza espressiva, pragmatica, cioè hanno a che fare con l’intenzione espressa da chi comunica il messaggio. Se ci viene chiesto di mettere una “firmetta” sotto un documento – fa notare l’autore Raffaele Simone - il diminutivo non significa che la firma debba essere piccola, ma che non richiede un grosso sforzo, dunque che il gesto che ci viene chiesto è poco impegnativo.
La lingua può essere anche pericolosa, visto che alcuni reati sono costituiti solo da quello che si dice, come nel caso della calunnia e della diffamazione. Forse per questo la grammatica di molte lingue prevede delle risorse per evidenziare se chi parla conosce direttamente ciò di cui parla oppure lo ha saputo in altro modo. A seconda che quell’informazione sia conosciuta direttamente o no, cambia anche la responsabilità di chi parla verso quello che dice. L’italiano e le lingue sorelle per esempio usano mezzi lessicali per segnalare che si sta parlando di cose non sicure, per es. che io sappia, dicono che, sento dire che, oppure impiegano un condizionale “Maria sarebbe a Berna”. Altre lingue invece usano mezzi solo grammaticali: è il caso del tucano, lingua dell’Amazzonia nord-occidentale, che usa un suffisso diverso del verbo a seconda che l’informazione riportata derivi da un’osservazione visiva, da una non visiva, da una mera inferenza, da una supposizione sulla base del buon senso, dal racconto di qualcun altro.
Insomma, ci sono almeno tre buoni motivi per leggere “La grammatica presa sul serio. Com’è nata, come funziona e come cambia.”: per sapere di più sulla lingua che parliamo ogni giorno, dunque per conoscere meglio quello che diciamo e perché lo diciamo, ma anche per capire meglio la nostra mente e dunque, in ultima istanza, noi stessi. Va da sé che il libro vi farà innamorare proprio di lei, della grammatica, di questa silenziosa, timida ma geniale direttrice d’orchestra al servizio della mente umana.
Scopri la serie
https://www.rsi.ch/s/703926