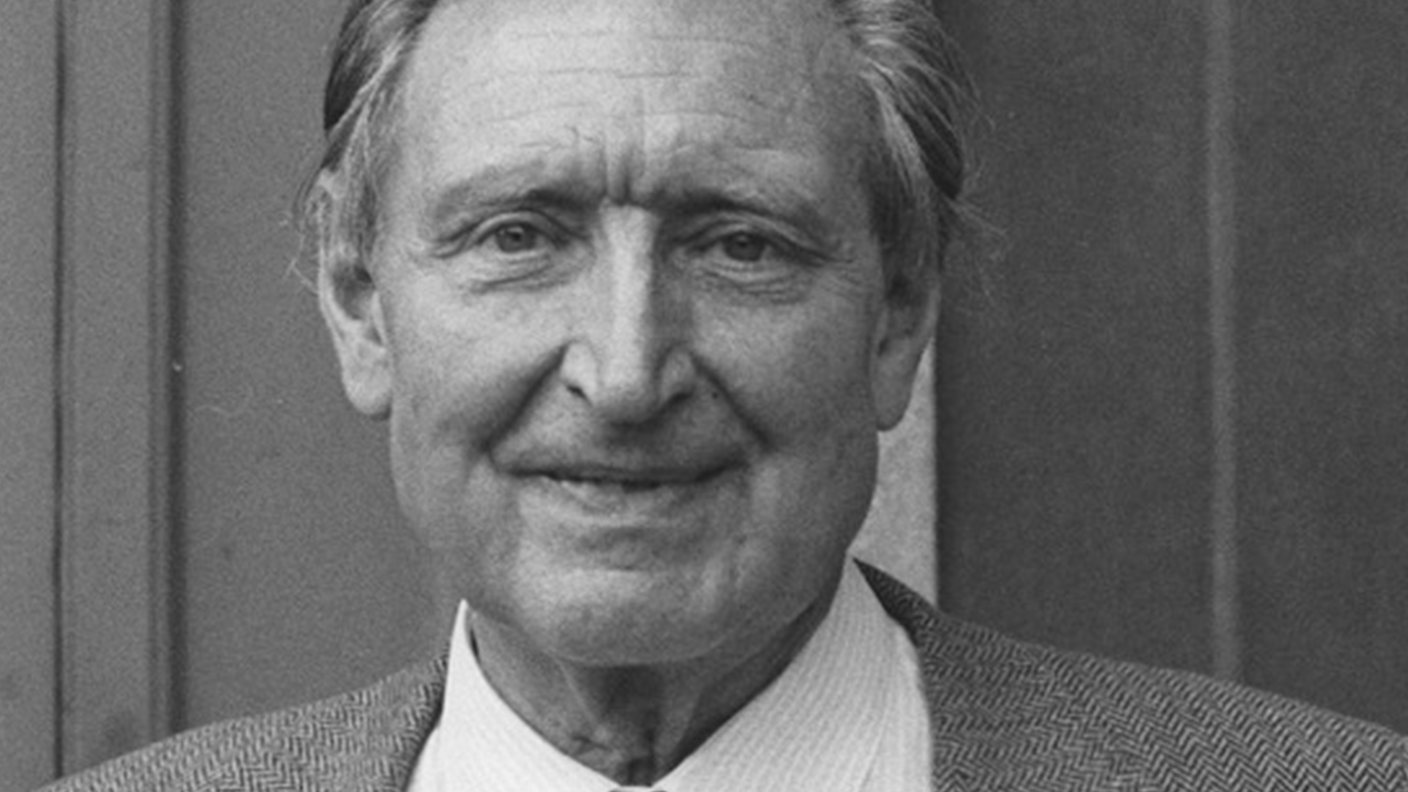Ciao, mi chiamo Nicolekenya Del Curto e sono una studentessa di lingua, letteratura e civiltà italiana all’USI di Lugano. Oggi vorrei parlarvi di un romanzo che, a distanza di anni dalla prima lettura, rimane una presenza viva nella mia esperienza di lettrice: Memoriale di Paolo Volponi, pubblicato per la prima volta nel 1962. Si tratta di un romanzo appartenente alla «letteratura industriale» italiana, un genere letterario nato alla fine degli anni ’50 che, attraverso le parole dei suoi autori, racconta la rapida trasformazione dell’Italia da paese rurale a nazione industriale, con tutti gli effetti che questo mutamento ha provocato anche sul piano antropologico. In effetti, se da un lato l’ascesa dell’industria ha permesso il pieno sviluppo della nazione, dall’altro lato ha causato anche un’importante problematica, inizialmente poco considerata: quella dell’alienazione dell’uomo – in particolare dell’operaio di fabbrica –, il suo estraniarsi al mondo lavorativo e, con il passare del tempo, alla vita stessa. Volponi, che per alcuni anni lavorò al fianco di Adriano Olivetti nella sua fabbrica a Ivrea, lo aveva intuito: ascoltando le confessioni di un dipendente a proposito dei «suoi mali», pare che l’autore abbia tratto ispirazione per il proprio romanzo. I malesseri – fisici e psichici – del dipendente della Olivetti sono gli stessi che il lettore ritroverà nel protagonista del romanzo, Albino Saluggia.
Siamo in Italia, negli anni Cinquanta del Novecento. Un considerevole flusso migratorio si sposta da Sud a Nord concentrandosi in grandi città come Milano, Torino e Genova, i cui cieli da qualche tempo si sono tinti di grigio e vengono sfiorati dalle alte ciminiere. Quello che era stato un territorio profondamente agricolo viene gradualmente punteggiato da nuovi edifici all’avanguardia, enormi centri produttivi che segnano un cambiamento definitivo non soltanto nell’industria, ma anche nel paesaggio e nello stesso essere umano: le fabbriche. Albino Saluggia è un ex prigioniero di guerra malato di tubercolosi polmonare, che dopo un periodo di disoccupazione viene finalmente assunto in un’anonima industria del Canavese.
Ottimista e volenteroso, Saluggia non sa che, tra i corridoi della «grande industria di X», avrà inizio il suo vero calvario, scandito dal ritmo della catena di montaggio e dalla pressione del lavoro a cottimo. Un ritmo monotono e dilaniante, che invece di guarire i «mali» del protagonista – con i quali il libro si apre – li alimenta, trasformandoli in una vera e propria alienazione – dal proprio lavoro, dalla propria vita.
La lettura lenta, a tratti immobile delle prime pagine, si fa sempre più incalzante man mano che i disagi del protagonista aumentano. Le descrizioni elegiache della campagna lasciano uno spazio sempre maggiore alle dure parole messe in bocca al protagonista per parlare del luogo in cui lavora: una fabbrica «immobile» che da ogni parte «mandava lo stesso rumore, [...] un affanno, un ansimare forte».
Leggendo il più celebre romanzo volponiano ci si immerge davvero in un’esistenza dilaniata dai traumi del passato e le nuove angosce del presente; stati d’animo espressi magistralmente dall’autore con uno stile che pare cogliere tutte le sfumature e gli affanni di un operaio di fabbrica come Saluggia. Ancora oggi vale la pena fermarsi un momento, nella rapidità del nostro quotidiano, ad ascoltare questo «ansimare forte» che vibra tra le pagine di Memoriale – romanzo che, in tutta la sua originalità, ci rivela quale sia il prezzo che il progresso ha richiesto e che, forse, continua a esigere.
Scopri la serie
https://www.rsi.ch/s/703926