Nel 1911, nel primo dei brevi saggi raccolti da Mondadori con il titolo Sulla stupidità e altri scritti, Robert Musil scriveva: “All’arte è lecito non soltanto rappresentare ma anche amare le cose immorali, persino le cose spregevoli”.
In questo assunto si condensa uno dei principali significati di cui l’arte è portatrice: accogliere l’esistente nella sua inseità. Non tanto per rassegnarsi all’indifferenziato – realizzando così una poetica del qualunquismo – ma per proporre l’esistente nella sua esplosiva contraddittorietà: bene e male essendo, come categorie astratte e approssimative, come espressioni selvagge dell’essere, tanto meglio riconoscibili quanto più esposte al loro contrasto. E quindi, necessariamente, alla neutralità dell’arte.
“L’arte è alla ricerca del sapere” scrive Musil. E sarebbe davvero beffardo se questo che è l’orientamento naturale della conoscenza – traversare l’insaputo per illuminarlo a prescindere dal valore – venisse pregiudicato alla fonte dallo stesso strumento che mira al disevalamento del nuovo. Aggiunge a questo proposito Musil: “Rappresentando le cose oscene e morbose attraverso i loro rapporti con le cose spiritualmente e fisicamente sane essa non fa altro che estendere il proprio sapere sulle cose spiritualmente e fisicamente sane”.
Di ciò che la Storia della letteratura – e dell’arte in genere – ha chiamato scandalo, inclinando spesso a definirlo un’effrazione o addirittura un errore, l’arte e la letturatura hanno dunque un bisogno vitale. Poiché “solo in questo modo nuove vie si aprono, saltano le vecchie concatenazioni e la coscienza si apre un varco”.
Il pensiero musiliano sulla liceità, anzi il dovere, dell’arte di confrontarsi e misurarsi con il morboso e lo spregevole non è però soltanto una precoce forma di militanza a favore dello scandalo, di difesa della natura scandalosa che può soggiacere al processo conoscitivo promosso dall’arte. Ma più ampiamente un inno all’arte come strumento di purificazione, vale a dire alla sua capacità di offrirci all’esistente attraverso la sua azione distillatrice. “Sull’oggetto rappresentato si fonda” scrive Musil “e su nient’altro – meno che mai su un gorgheggiante moralismo che ripeta la propria solfa con monotona ‘decenza’ da teatro di corte – l’azione purificatrice dell’arte, che libera automaticamente dalla sensualità. Ciò che nella realtà resta compatto e denso come una goccia bollente qui viene disciolto, scomposto, fuso – beatificato, umanizzato”. Con l’ovvia conseguenza che l’arte non è votata alla consolazione o all’abbellimento ma alla conoscenza: alla conoscenza come conquista, poco importa se a prezzo della morale o del pregiudizio moralista. “L’arte, l’arte che vale, rivela cose che pochi avevano visto. È fatta per le conquiste, non per la pace dello spirito”.
Aristocratica nella misura in cui si avventura ove il mondo non osa avventurarsi, avventurosa nella misura in cui scalza dall’ovvio e dal rassicurante i facili guanciali del conformismo, l’arte è dunque per sua necessità e natura anche un atto di coraggio: non fosse quest’ultimo che la disponibilità a misurarsi in solitudine con la ricerca di un sapere tra le insidie del male. “Anche in fenomeni di fronte ai quali altri rabbrvidiscono l’arte vede infatti dei lati positivi, delle connessioni. Nella maggior parte dei casi nei quali l’arte si scontra con l’opinione pubblica questi lati positivi non vengono riconosciuti”.
Artistocratica, ma democratica. E soprattutto scandalosa, ma morale. Poiché in effetti l’arte conduce, attraverso gli strumenti della normalità, a riconoscere nell’anormalità ciò che universalmente, a livello di demos, si tende a voler evitare: il suo lato comprensibile e la sua indissolubile appartenenza, in forme spesso invisibili, al mondo morale. “In verità non esiste perversione, non esiste immoralità alla quale non corrisponda, per così dire, una sua salute e una sua moralità (...) Ogni perversione può essere rappresentata. E può essere rappresentata con una struttura che usa elementi tratti dalla normalità (...) Ciò che permette di comprendere e di amare, in senso artistico, anche ciò che è immorale e perverso”.
L’arte dunque è uno strumento di conoscenza che, come la scienza, valuta indifferenziatamente il territorio e le cose in cui si immerge per rendere palese – ma soprattutto accettabile – l’occulto e l’inaccettato. “Anche per l’arte va fatto ciò che facciamo per la scienza. Si deve accettare il rischio di effetti secondari indesiderabili, per raggiungere la meta principale”.
Bene, male, moralità, immoralità, normalità, anormalità: le diadi che ci propongono l’esistente nella sua contraddittorietà sono infinite. Ma laddove lo sguardo pusillanime, ovvero non artistico, le annulla votandosi ciecamente alla propria idea di liceità, l’arte osa lo scandalo e dischiude di conseguenza le possibilità del sapere e del superamento.
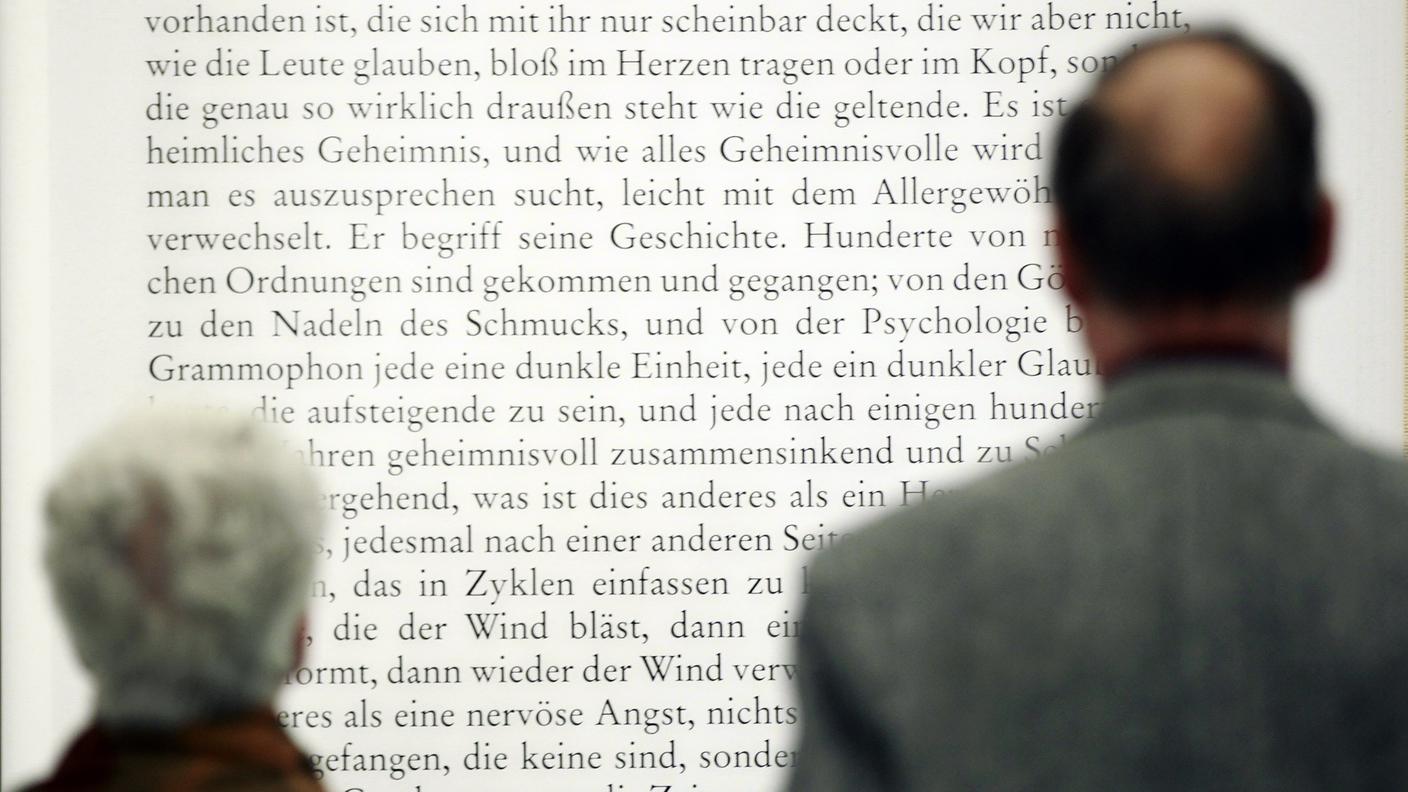
L’Uomo Senza Qualità di Robert Musil
Laser 27.08.2014, 13:45
Contenuto audio



