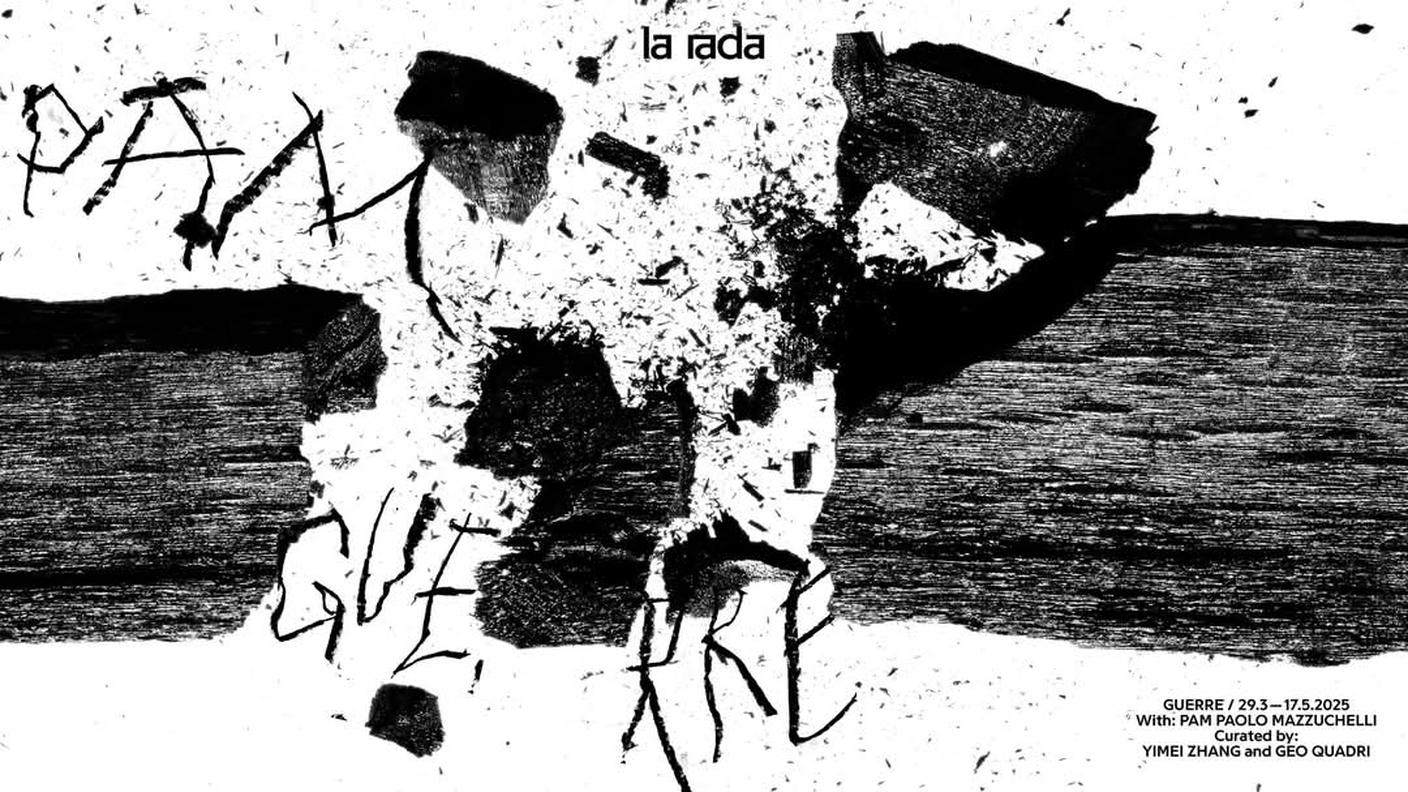La seduzione del colore. Andrea Solario e il Rinascimento tra Italia e Francia è il titolo della mostra su uno degli artisti più originali del Rinascimento lombardo.
A cura di Lavinia Galli e Antonio Mazzotta è al Museo Poldi Pezzoli di Milano, fino al 30 giugno 2025.
Andrea Solario occupa nella scuola lombardo-milanese una posizione affatto particolare e ne è forse in quanto a tecnica, il più eminente pittore. Poiché intorno a lui non v’è tra gli scrittori l’accordo desiderato, sia a me permesso in questa occasione di parlarne più diffusamente… Chi sia stato il suo vero maestro non è ancora saputo… Nessun pittore lombardo nel modellare si avvicina tanto a Lionardo quanto egli stesso; nessuno ha saputo per questo rispetto eseguire delle teste così finite… È visibile l’influenza di Giambellino e più ancora quella di Antonello da Messina…
Giovanni Morelli: Della pittura italiana. Studi storici critici: le gallerie Borghese e Doria Pamphili in Roma. Milano, 1897
Il cognome di Andrea è in realtà Solari; lui si firmava Mediolanensis, in particolare quando viveva in altre città, oppure del gobbo per fare riferimento alla conformazione del fratello Cristoforo, ai tempi più famoso di lui; oppure ancora de Solario, all’ablativo; la tradizione storiografica ondeggia tra Solari e Solario preferendo il secondo, mentre a Milano esiste una importante Via Andrea Solari. Perfino il cognome è oggetto di attribuzioni varianti.
Nato all’interno di una numerosa famiglia ticinese, Andrea Solario è un artista importante e per certi versi misterioso che ha operato in un crogiolo dove la cultura pittorica leonardesca si incrocia con quella belliniana. Nella produzione a cavallo tra i secoli XV e XVI, il suo lavoro spicca per la capacità di resistere, pur appropriandosi dell’esperienza, ai traumi generati dalle violente innovazioni proposte dalla personalità di Leonardo da Vinci e per l’elaborazione di alcuni dei valori che arricchiscono quel periodo storico: possiamo citare la lezione di Antonello da Messina, di Albrecht Dürer e della tradizione nordica, del Perugino e i riferimenti, i richiami, gli scambi e le influenze continuano.

Andrea Solario, Ritratto di uomo, 1495 circa - Tavola, Londra, The National Gallery
Abbiamo pertanto da una parte una relazione stretta con la pittura di Leonardo da Vinci, di una ventina di anni più anziano (Andrea è nato probabilmente intorno al 1470) e giunto a Milano nel 1482; dall’altra, una frequentazione con un Giovanni Bellini ormai più che sessantenne, il cui cromatismo e alcuni aspetti compositivi sono così presenti in alcune delle opere di Solari da generare, nel corso dei secoli, attribuzioni varianti. Alcuni documenti attestano quanto Giovanni Bellini conoscesse Andrea e il fratello Cristoforo Solari, e più opere oggi attribuite ad Andrea sono state ascritte al lavoro di Giovanni Bellini. Per esempio, la Madonna dei garofani, oggi alla Pinacoteca di Brera, fino a metà Ottocento recava la firma apocrifa Iohannes Bellinus; il Ritratto di uomo con garofano, oggi alla National Gallery di Londra, nel 1820 veniva descritto come Ritratto di un anziano di Giovanni Bellino. Piuttosto vicina al lavoro di Bellini è la Madonna con il Bambino tra san Giuseppe e san Simeone del 1495, prima sua opera nota e conservata oggi alla Pinacoteca di Brera.

Andrea Solario, Ritratto di giovane, 1490-1494 circa - Tavola, Milano, Pinacoteca di Brera
Il mistero di Andrea inizia con il primo periodo della sua vita. Milanese, documentata la sua presenza nel 1488 a Milano, membro di una famiglia di artisti originari di Carona, al di sopra del lago di Lugano, non sappiamo come visse gli anni prima del soggiorno veneziano che è documentato a partire dalla metà degli anni novanta del Quattrocento, né sappiamo se e come iniziò a formare la propria professionalità a Milano. È un mistero che si riflette sulla lettura delle opere ed è significativo il Ritratto di giovane conservato oggi presso la pinacoteca di Brera che, attribuito nel corso della storia a Cesare da Sesto e connotato da elementi che potrebbero essere della mano di Antonello da Messina e di Leonardo da Vinci, è stato trasferito nella seconda metà del secolo XIX alla mano di Andrea Solario, restando viva la discussione tra chi lo ritiene opera del periodo veneziano, fortemente influenzata da Antonello da Messina, chi lo ritiene frutto della maturità di Andrea, eseguito a Milano dopo il ritorno da Venezia, quando all’influenza di Antonello si aggiunge quella di Leonardo e chi invece, soprattutto ai giorni nostri, propone di datarlo al periodo 1490-1494, come scrive Federico Maria Giani in occasione della mostra dedicata ad Andrea Solario dal museo Poldi Pezzoli di Milano.
Il Ritratto di Brera rischia piuttosto di essere uno dei più antichi pezzi del catalogo di Solario: non ci sono ostacoli, infatti, a calarlo nel contesto della migliore ritrattistica leonardesca dei primissimi anni Novanta del Quattrocento, addirittura a monte del soggiorno veneziano
Federico Maria Giani
Il mistero e l’incertezza comunque perdurano se, a fronte di ciò che abbiamo appena riportato, a pagina 25 dello stesso volume Antonio Mazzotta scrive: «Rimane qualche difficoltà nell’accordare la Madonna dei garofani, che ha un sapore metallico nei panneggi ancora alla Bernardino Butinone, con il Ritratto di giovane di Brera, più fuso nell’atmosfera e nel colore, che quindi non è inverosimile pensare sia stato eseguito qualche tempo dopo: sarà l’esposizione in mostra a chiarire qualche dubbio».

Andrea Solario, Testa di San Giovanni Battista, 1507 - Tavola (tela incorporata nella preparazione), Parigi, Museo del Louvre, Département des Peintures
È una delle componenti della ricchezza dell’arte (non solo di quella antica): sempre, nelle opere, possiamo leggere e individuare contenuti, influenze, infiorescenze di grafemi stilistici ed espressivi che ci riconducono a intenzioni presunte e a relazioni artistiche che ci appaiono e che interagiscono anche contraddicendosi. Di fronte al manufatto, anche nel caso di Andrea Solario, ammiriamo l’efficacia e le qualità espressive, le scelte nella organizzazione della rappresentazione, a proposito dei personaggi e delle altre componenti come i panneggi o i paesaggi; la qualità tecnica nella figurazione delle mani, del loro gioco, dei volti e poi il classicismo dei corpi, per esempio nei nudi e così via. A quel punto inizia la lettura dell’opera che trascende gli aspetti della fruizione immediata e si propone a noi come una scrittura storica, pregna di indicazioni sui contesti ai quali essa può essere riferita.

Andrea Solario. La seduzione del colore
Alphaville 03.04.2025, 11:30
Contenuto audio