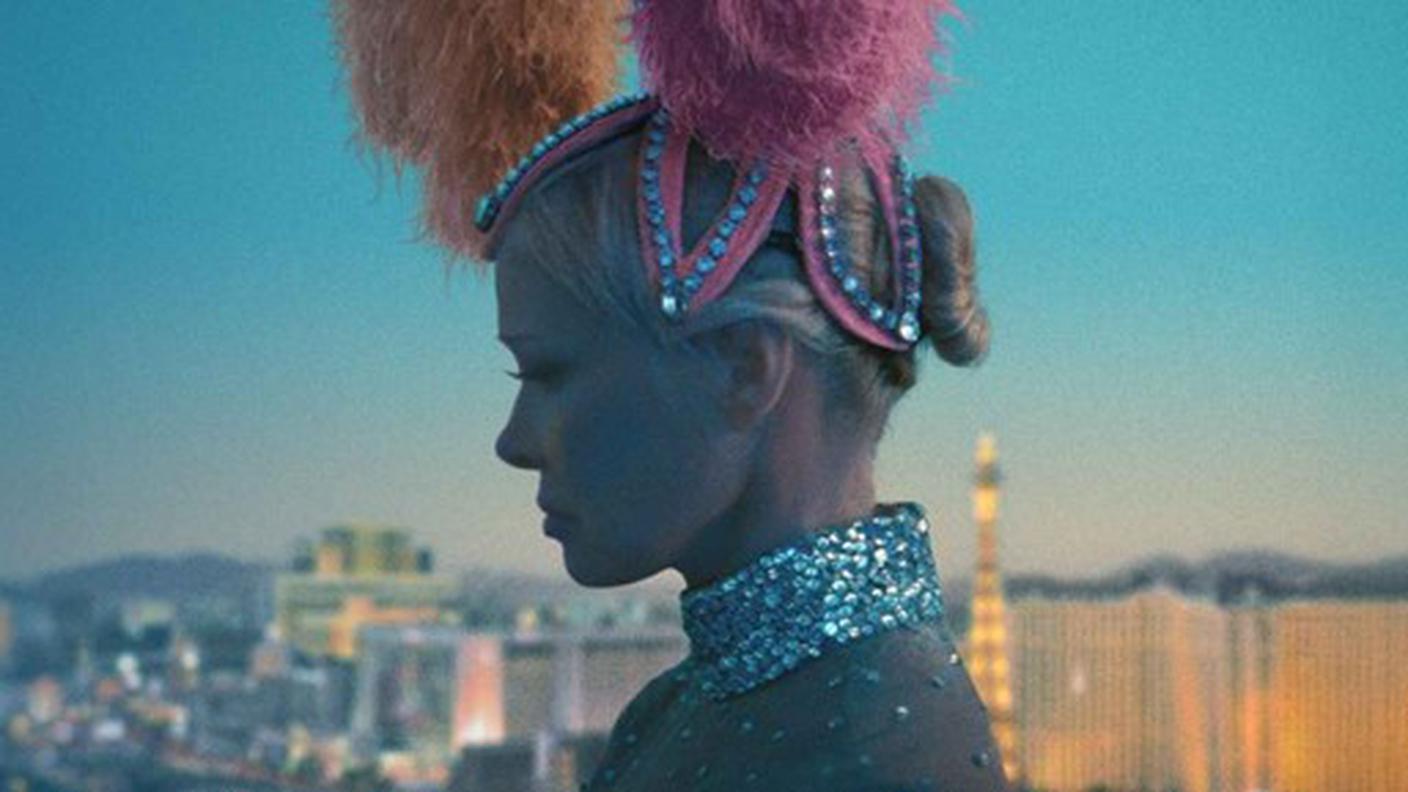Può essere delicatissimo un film sulla guerra?
Può essere delicatissimo un film sul nazismo?
Evidentemente sì, se delicato è lo sguardo che ci si posa.
È questo il caso de Le Assaggiatrici, una perla destinata a far parte dell’arsenale cinematografico di chiunque sia affamato di storie sulla Seconda Guerra Mondiale, da pochi giorni al cinema.
Un dono e una liberazione al contempo, per la fonte primaria della vicenda: come esplicitato dai titoli di coda, dobbiamo il racconto a Margot Wölk. Tacque per tutta la vita. Infine, a 95 anni, nel 2012, quando un giornalista del Berliner Zeitung le fece visita, lei parlò. E raccontò di aver fatto parte del gruppo di 15 giovani tedesche costrette per più di due anni ad assaggiare i pasti di Hitler affinché quest’ultimo avesse la certezza che non fossero avvelenati.
A dare una degna veste narrativa alla sua liberazione è stata la splendida penna di Rosella Postorino, con Le Assaggiatrici (Feltrinelli, 2018). Ora, grazie a questa staffetta letteraria e infine cinematografica, Le Assaggiatrici è al cinema.
La scelta del punto di vista della protagonista permette uno sguardo inedito, obliquo e drittissimo al contempo, sul nazismo.
La simbologia del cibo è fondamentale. Nel racconto originario, Margot Wölk era molto esplicita: «Il cibo era buono, perfino molto buono. Ma non potevo godermelo (…). Mi ci è voluto molto tempo per tornare a godere del cibo, ma ce l’ho fatta, non è stato facile ma credo di aver finalmente sconfitto le mie paure».
Avere paura di nutrirsi, della fonte primaria di vita. È una delle tante cicatrici, e forse la più simbolica, che lavorare senza consenso per un dittatore possa causare. Si mangia per vivere, eppure nella sua storia si è mangiato per evitare a qualcuno di morire. Il proprio corpo come corpo dello Stato, il corpo dello Stato identificato col corpo di un uomo comune che si è creduto Dio. Persone come strumenti.
Un altro tema fondamentale è la paranoia del capo. Adolf Hitler, per e a causa del quale troppe persone sono morte, fu così vile da strumentalizzare delle ragazze per risparmiarsi la stessa fine.
“Giovani e sane donne tedesche per un compito così importante”: sopravvivere oppure no, obbligate a mettere la vita di un uomo che non vedranno mai di persona al di sopra delle loro.
I caratteri delle protagoniste escono fuori sotto stress: c’è chi, pragmatica, beve molta acqua per minimizzare gli effetti di eventuali veleni; chi, cinica in superficie, asserisce che comunque le probabilità di morire in tempi di guerra sono alte lo stesso; c’è Lena, vitalissima ed emotiva all’eccesso, che prima ride e poi si dispera; c’è Rosa, che resta composta anche se una lacrima si fa largo sul suo viso, che resta umana e può essere una spalla per le altre, le più forti, le più deboli. C’è, infine, quella che viene definita “invasata dal Führer”. La tedesca come lui voleva che fossero le tedesche: ossessionate dal culto della sua personalità almeno quanto lo fosse lui. Questi uomini che vedono spie e nemici ovunque lo fanno perché è il loro modo di agire e parlare che li circonda di spie, ma spie a loro favore. Quanto al nemico, è nazista la categoria di Carl Schmitt, quella del “nemico politico”. Il filosofo scriveva di rivoluzione conservatrice: ma la vera rivoluzione è rovesciare questa categoria, poiché da proiezione nasce. Più semplicemente, il nemico politico è chi identifica nemici politici ovunque; in questo caso, il nazismo.
Poiché il cibo è al centro, la storia affronta anche la famosa questione di Hitler vegetariano. E che non beveva, e che non fumava. Se ne sottolinea il carattere ipocrita, l’importanza della mancata perdita di controllo, e soprattutto di facciata. La finta rettitudine del capo violento.
Parlando di coscienza, qui c’è la storia (di sesso più che d’amore) tra la protagonista e uno delle SS. Il rischio era che si romanticizzasse qualcosa di pericoloso, ma grazie alla scrittrice prima, al regista (l’italo-ticinese Silvio Soldini) poi, non succede mai. Anche qui c’è una ferma delicatezza. Lui - come e più di tanti soldati, anche quelli che non si sono macchiati di crimini di guerra - ha una evidente sindrome post-traumatica da stress, e problemi di sonno. Fa un incubo, si sveglia di colpo. Si apre con la protagonista e le racconta cosa è stato costretto a fare nei campi di concentramento, quanto sia stato vicino alla pazzia. Lei non lo perdona. Lui non ha gli strumenti per elaborare, né per prendersi la responsabilità di quello che ha fatto. L’SS è di fatto irredimibile. Lei lo lascia. E lui mostra il suo vero volto: dal più classico degli insulti da uomo che non accetta un rifiuto (“puttana”) al ricatto sessuale. C’è una categoria psicologica, quella del “punitore altruista”, a cui l’SS appartiene, come si comprende sul finale; questo non lo rende migliore, lo rende invece adattissimo a essere un uomo di Hitler. E un personaggio interessante da raccontare.
Nella storia vera di Margot Wölk non ci fu una storia d’amore con un uomo appartenente alle SS, ma uno stupro. E stupri di guerra anche da parte dei Sovietici, così violenti che le impedirono, in seguito, di avere figli.
Il fatto che il punto di vista di chi racconta la storia sia nettamente antifascista non la rende ciecamente ideologica; non fa sì, cioè, che si tratti di un film a tesi. Mette invece di fronte alle tantissime contraddizioni dell’animo umano. Se l’uomo che uccide la tua amica mette in salvo te, cosa fai? Di sicuro, i conti con il sangue sulle tue stesse mani. Ma anche col concetto, mai e poi mai scontato, di sopravvivenza.
Al cinema!
Tra le righe 27.03.2025, 14:00
Contenuto audio