«Sono in vacanza, ho una famiglia a Grimacco, domani è Natale, almeno mi pare che sia Natale perché ho perso il conto dei giorni, gli altri preparano l’albero o il presepio, vanno a prendere i regali nei negozi aperti fino a tardi, e io invece sono qui, alle undici di notte, con un mare di appunti, di fogli, di quaderni, inseguito da una furia, preso da una febbre che non guarisce, che forse non mi passerà mai». A parlare è Giacomo Cojaniz, personaggio dimenticato di un romanzo poco fortunato e che vale la pena di leggere perché… dà i nervi. “Figlio” dello scrittore friulano Carlo Sgorlon, scomparso la mattina del 25 dicembre 2009, Cojaniz è – per sua stessa ammissione – un nevrastenico, un dissociato, uno schizofrenico. E bisogna tener davvero ben saldi i nervi per non chiudere il libro in cui sono raccontate, con dovizia di dettagli, le sue (e le nostre) manie: la sua insopportabile indolenza travestita di azione lo porta sistematicamente a rimandare al domani quel che potrebbe fare oggi, aggrappandosi a scuse ridicole; lascia perennemente le cose a metà e si nega alla vita con la scusa di non aver tempo, quando in realtà è un vero “professionista” in tal senso. Insomma, è un procrastinatore seriale, che proprio non si ha voglia di conoscere, specie in questo periodo, deputato ai buoni propositi per il nuovo anno, che non manchiamo di rimandare con i più fantastiosi pretesti. Ci vuole dunque una certa dose di coraggio e di pazienza per leggere La poltrona (1968): una piccola perla della vasta produzione letteraria di Carlo Sgorlon, definita da Carmelo Aliberti come un «Vangelo laico dei “Miserabili” moderni», in cui racconta le nevrosi dell’uomo d’oggi, disperso in una Babele moderna.
«Oggi incomincio, adesso, subito», esordisce il mitomane, per poi subito ritrattare: «forse dovrei rimandare di due o tre settimane almeno». Giacomo Cojaniz è un professore di Udine, aspirante scrittore, maestro nell’accampare scuse. Con la biro rossa non ne esce niente di buono, meglio cercare la stilografica in tutta casa, per poi andare in cartoleria che, di lunedì, è chiusa. È chiaro: “oggi” «non è il gran giorno, bisogna aspettare ancora». Il quaderno a righe non è adatto per una grande opera, gli dà «un fastidio irresistibile, come un prurito che non si riesce a sopportare», la sedia è scomoda, ma lavorare a letto non è congeniale: «le coperte mi pesano, senza coperte ho un freddo da crepare. Non so dove tenere le gambe, non riesco mai a trovare la posizione giusta». Da lì l’idea geniale: non sarebbe tutto più semplice se scrivesse al caldo e su una poltrona? E così scrivacchia, va in soffitta, monta un pezzo della seduta, ridiscende, butta giù qualche riga, accende la stufa, fa una pausa, e il ciclo continua, all’infinito. Sgorlon, per farci saltare i nervi, racconta con meticolosità maniacale la giornata tipo del “nostro” nevrotico:
«Adesso sono pronto. […] Svito la penna, metto il cappuccio dall’altra parte, provo il pennino sulla pagina di un quaderno. Scrive male. […] Tiro fuori il pennino, lo lavo ben bene. […] Ricarico la penna d’inchiostro, la provo di nuovo, […] mi rificco a letto. […] Vedo un pezzo di pane sul tavolino […] e mi metto a sgranocchiarlo. […] Vado avanti finalmente. […] Sento un prurito nell’orecchio. […] Ficco la penna in bocca e la tengo lì come uno dei miei alunni in panne durante il compito di italiano. […] Posso concedermi una piccola vacanza a questo punto perché in fondo ho cominciato, qualcosa di buono ho combinato».
Giacomo Cojaniz è un essere irrisolto: per lui «non c’è niente di semplice, tutto è infinitamente complicato»; «tutto diventa una tragedia» perché non sa prendere la vita con leggerezza. «Il mio guaio», ammette, «è di dar peso a tutto, di dilatare le cose, di vederle sempre in uno specchio deformante». «Ho sempre il morso della coscienza del tempo che perdo», ci confida, eppure questa ossessione lo porta a sprecarne a dismisura, come se fosse un «miliardario del tempo», come lui stesso infine ci dirà. «Non posso non lavorare, ho paura del non lavoro, ho paura del vuoto, […] per me il non fare è come il non essere. Se voglio essere, se voglio avere la sensazione di esistere, devo far qualcosa, devo correre dove la campana mi chiama, anche se correndo non arrivo in nessun posto», leggiamo ancora nel suo romanzo. Non La poltrona, bensì La torre di Babele, il libro che Cojaniz vorrebbe scrivere e che Sgorlon ci vuol far credere che non porterà mai a termine.
Non è infatti La poltrona «una colossale tragedia dello spirito, di tutta la civiltà moderna, del
regnum hominis»? Il suo vero autore, Giacomo Cojaniz, ne è la vittima e il carnefice (di se stesso). «Ho paura di disperdermi, di ficcarmi in un labirinto, non so dove metter le mani perché è una babilonia spaventosa, un’infinità di ripetizioni, un ammasso manicomiale senza prima né dopo», dice a proposito dei suoi appunti sparsi e confusi, tanto quanto i suoi pensieri e la sua vita. «Tutti corrono come matti, non si sognano neanche di rallentare», nota in una sua rara uscita, e aggiunge: «è una vera babilonia, mi sento male ogni volta che ci sono in mezzo». Lui, preda di «una vera babilonia di mali», che cura a suon di tranquillanti e caffè doppi, non ne riesce a rintracciare l’origine. È una «faccenda enorme, labirintica» in cui si è perso; una «strada troppo lunga e piena di trabocchetti e di sabbie mobili».
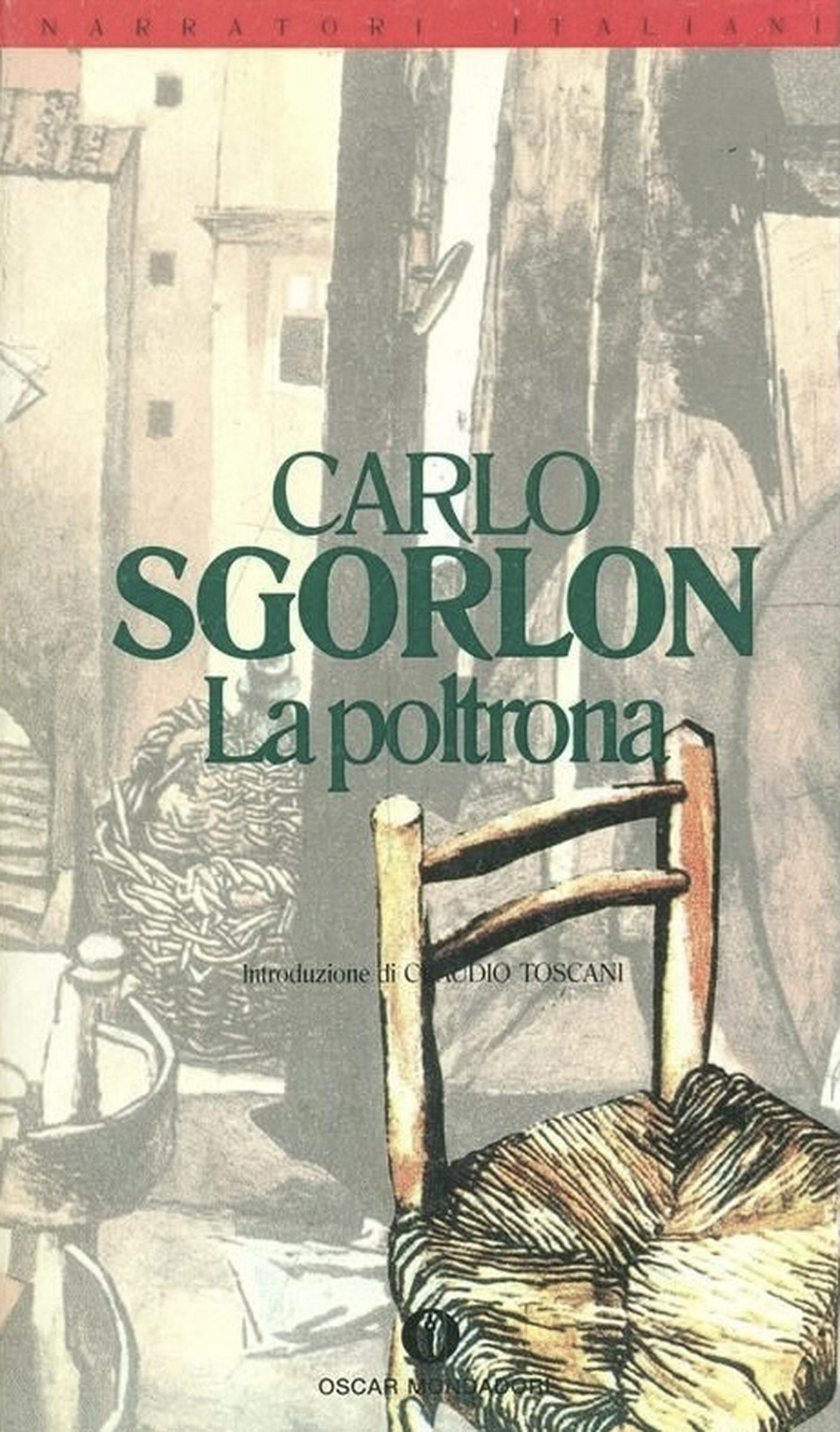
Dopo pagine e pagine in cui ci sorbiamo le sue manie, che puntualmente giustifica – «non mi spavento per un tìc, tutti ne hanno», «inutile che mi domandi perché, non c’è risposta per queste cose», leggiamo in principio – Sgorlon/Cojaniz ci sorprende con una originale riflessione sull’io e sul nostro rapporto con gli altri:
«Il conosci te stesso andava bene una volta, ma oggi tutto è spaventosamente complicato, nel fondo dell’uomo non c’è più la verità, ma solo cose che spaventano. Forse c’è solo il caos, l’arbitrio assoluto, un cesto di bisce che si agitano, una manciata di vermi che si aggrovigliano nel fango puzzolente della materia organica, e da questo fango vien su l’io, il fiore della coscienza, che però ha radici laggiù, nel fondo della cisterna. Allora mi domando cos’è questo io che […] c’è e dopo non c’è […] che è uno eppure nasce dall’organizzazione misteriosa di qualche trilione di cellule, che nasce dalle cellule ma non è loro, non si confonde con loro, anzi può essere in pieno divorzio con loro, come nel mio caso, che l’io vuole disperatamente una cosa e quei bastardi trilioni di cellule fanno i guastatori. […] Cos’è questo io, per la miseria? Dov’è la sua unità se è sempre indeciso, sempre spaccato come fango nel sole, se non sa mai quello che vuole, se non si conosce, se non sa comandarsi e scegliere la sua strada. In fondo io non so niente di niente di me. So che mi chiamo Giacomo Cojaniz, che ho quarantadue anni, che insegno nell’avviamento di San Giovanni e via di questo passo, ma di più non so, non so veramente chi sono perché tutto è spaventosamente buio e complicato».
Siamo alle battute finali del romanzo, ed è solo qui che il lettore viene a conoscenza del nome del protagonista. Per conoscersi davvero, Cojaniz deve vedersi attraverso gli occhi dell’altro: Sandro, un ragazzino che si diverte a mimare le sue buffe e tragiche abitudini. «Io non mi conosco ma lui sì. Non è un ragazzino, ha un occhio diabolico per vedere in profondità», nota il “nostro” nevrotico; «è colui che vede la realtà nascosta, colui che rivela agli altri la loro vera natura», aggiunge, sottolineando pure che «solo nella parodia è sepolta la verità». Presa coscienza della propria miserabile esistenza, Cojaniz ha un incubo in cui aleggia lo «scheletro di una poltrona non finita» e il rumore di un «enorme orologio», sempre più forte. Tic, tac, tic, tac… come finirà il romanzo? Se non sarà nella corsia di un ospedale, stretto in una camicia di forza, salterà giù dal letto, metterà due legni nella stufa, e si rimetterà al lavoro… E noi, allo scoccare della mezzanotte, riusciremo a dominare «quelle bastarde di cellule [che] si ribellano, agiscono sempre per conto loro, [e] non obbediscono»? A liberarci dalla «matassa di paure» che incatenano Cojaniz, e in primis dalla paura di perder tempo? O almeno, di tanto in tanto, riusciremo almeno a dirci: «Pazzo che sono, cosa m’importa della poltrona?».

I buoni propositi di inizio anno
Telegiornale 08.01.2023, 21:00






