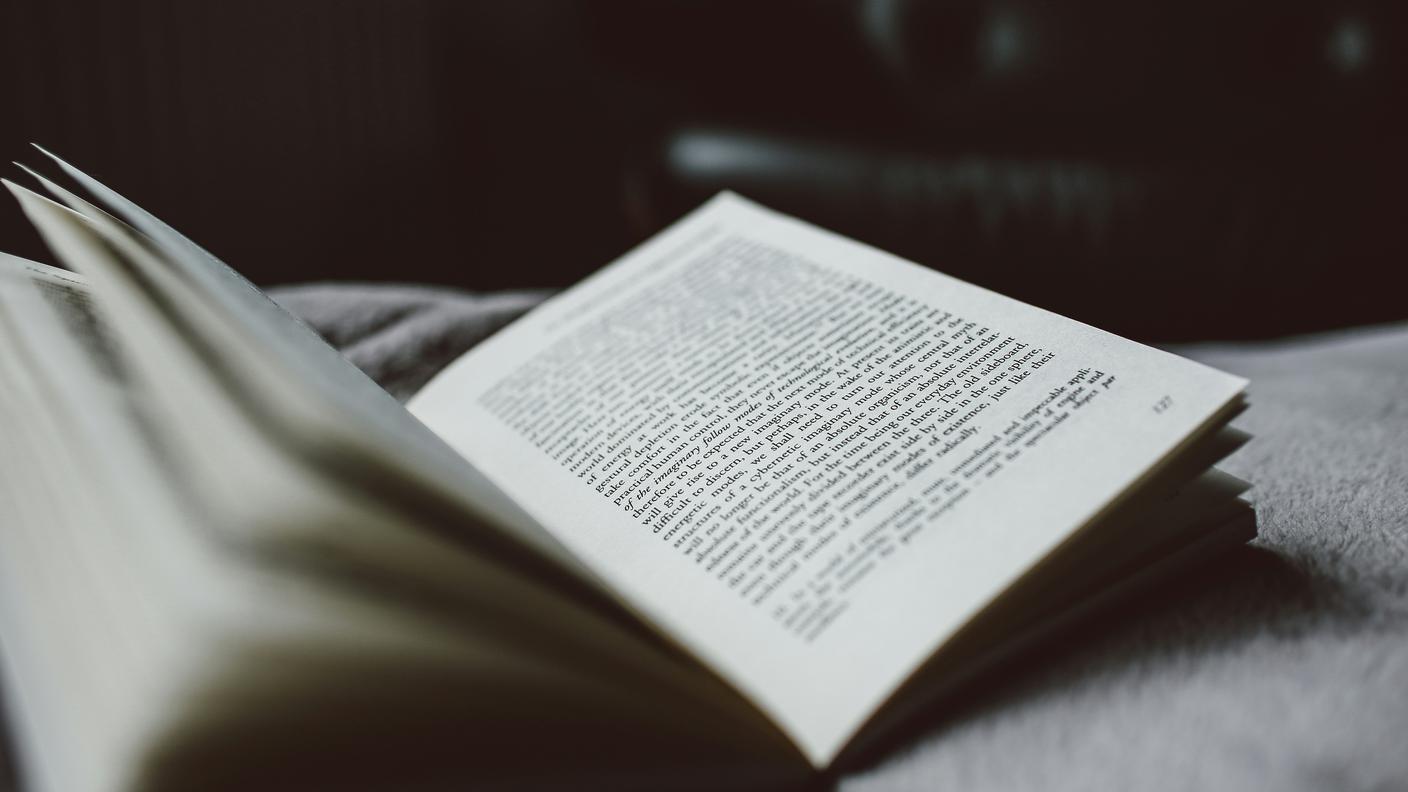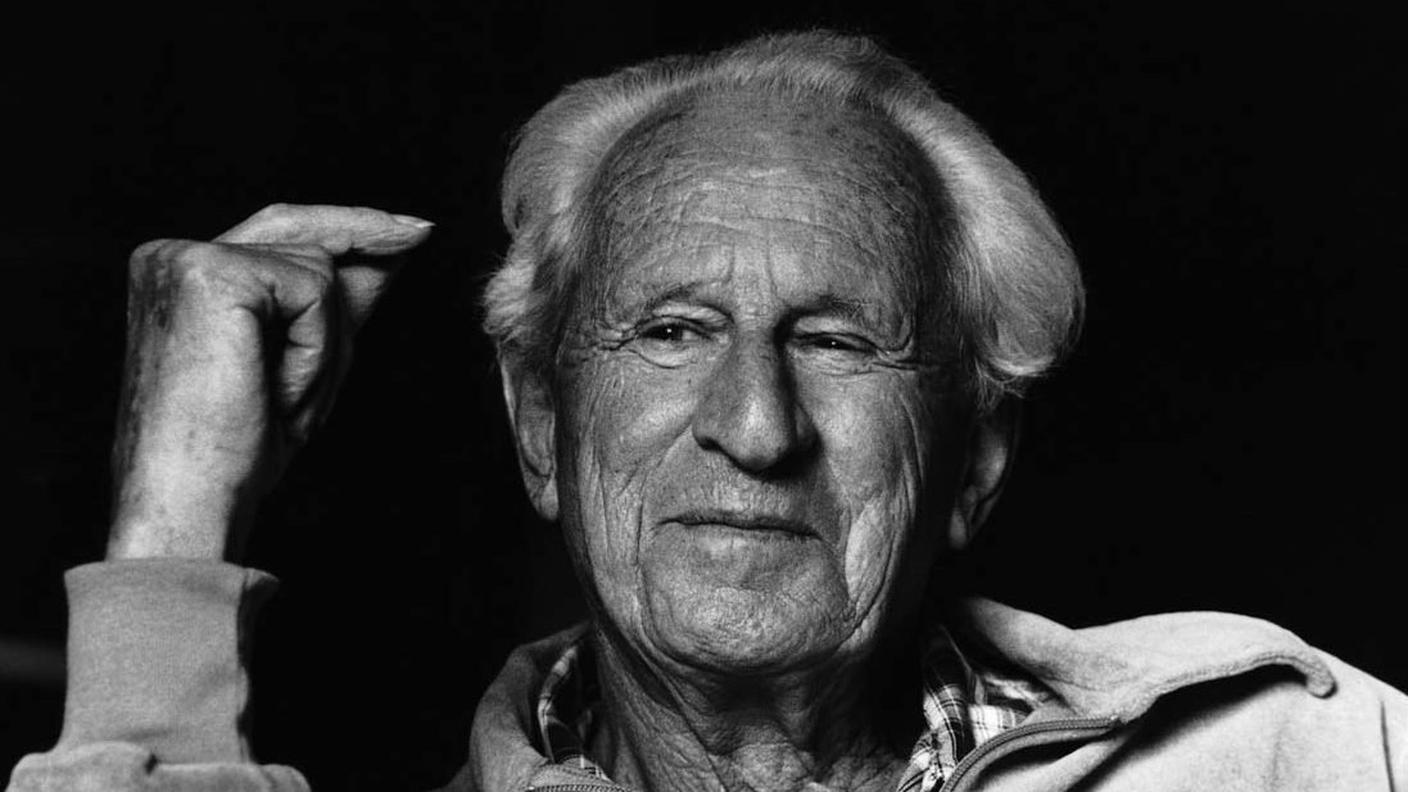2023 Odissea nello spazio di internet. Sono invasivi e invadenti, si replicano, si moltiplicano, onnipresenti sui social e sulle nostre chat, sanno essere sorprendenti, surreali, geniali e sono la forma metacomunicativa più semplicemente complessa che sia mai arrivata nelle autostrade ipertestuali del web. Iperbole più che dovuta quando si parla di… Meme, dal greco mimene, imitazione, che oggi, restando perlomeno a questo punto della nostra disamina sul generico, rappresentano tutto ciò che ha un altissimo potenziale di viralità, replica e diffusione nel mondo online.
Diamoci un perimetro spazio/temporale. Primi anni 2000, anni di forum e blog, di chat e siti ancora lontani dall’infinito universo autoreferenziale in cui i social hanno trasformato internet. Il canale privilegiato è il mit(olog)ico 4Chan, sito imageboard dedicato alla condivisione di contenuti. Una community che il Guardian in quegli anni descriveva come “pazza, giovanile... brillante, ridicola ed allarmante”. Giovani erano gli utenti anonimi, brillante perché la creatività imperava in maniera libera e anarchica, ridicola per la comicità spontanea, surreale, irrefrenabile e compulsiva dei suoi frequentatori, allarmante perché potenzialmente senza controllo e strabordante. Per chi non bazzicasse la storia “dell’internet” è proprio da 4Chan che vide la luce il prodromo di quel che diventerà poi il famigerato gruppo degli Anonymous. Ma 4Chan, è bene puntualizzarlo, è stato anche al centro di diverse polemiche per i contenuti troppo spinti.
Il web 2.0 incombe in tutta la sua dirompenza e l’avvento dei social, che fino a lì si era espresso con piattaforme come MySpace e Netlog, vedeva affacciarsi all’orizzonte (siamo nel 2004) il primissimo Facebook, fenomeno universitario americano ancora alle prese con la ricerca di un’identità ben definita. A fare da contraltare alla sempre maggiore voglia delle persone di mostrarsi e uscire dall’anonimato che aveva contraddistinto soprattutto le chat in quel periodo storico di internet, c’erano community come Reddit e 4Chan in cui gli utenti erano soprattutto content creator ante litteram, spazi in cui l’idea romantica di democratizzazione del sapere e di anarchia del web erano il motore principale.
L’incontro/scontro nel gigantesco, ma infine piccolissimo, mondo dell’online era inevitabile. Le piattaforme social che via via si strutturavano e prendevano forma, il lancio di Youtube e la sempre maggiore consapevolezza di poter trovare nel web un ottimo strumento di espressione personale fu il detonatore principale per l’esplosione del fenomeno meme. È nel 2009 che il ricercatore americano Patrick Davison definisce i meme come “un pezzo di cultura la cui influenza cresce diffondendosi online”. Cresce esponenzialmente diremmo noi oggi. Dovessimo dare una faccia ai meme di quel periodo sarebbe sicuramente la leggendaria trollface o l’altrettanto famigerato Pepe the Frog.
Per comprendere meglio di cosa stiamo parlando è, forse, utile passare in rassegna anche un po’ di grammatica di questo linguaggio. Un meme si compone di tre elementi fondamentali: una base (una foto o un video che ne sono il cuore virale), una punchline (una frase, perlopiù comica/ironica/satirica) e una didascalia (che contestualizza la relazione base/punchline).
I meme sono una macchina semiotica potentissima e, direbbe Umberto Eco, necessitano di strategie di lettura precise per poter essere (in parte o del tutto) compresi. Chi lo vede deve attingere a diverse informazioni per riconoscerne, prima di tutto, la base e i suoi molteplici riferimenti: è un film? Di che scena si tratta? È un’immagine comune diventata virale? È un’illustrazione? È una campagna pubblicitaria? È uno slogan politico?. E come si è “spostato” dal suo contesto naturale per diventare qualcosa di diverso nel web? Cosa è diventato? Cosa fa ridere di quella base? A cosa possiamo collegarla? Qual è il suo valore universale?
Poi arriva la punchline, la battuta comica che è nella sua essenza stessa un testo che si attacca al vissuto delle persone, alla cultura generale, ad un periodo storico e così via. A questo punto il primo “sforzo” del lettore è quello di comprendere il legame tra l’utilizzo della base e la sua punchline in un circolo virtuosamente (ma spesso viziosamente) infinito di associazioni e interpretazioni. Il meme così è quasi decodificato.
Ma si può andare oltre. Base e punchline seppur connesse e legate nel dare un significato al meme (il significato che vuole, anzi che vorrebbe il suo autore), vivono e possono essere lette separatamente, dando il via ad altre possibili combinazioni con altre basi di meme e altre punchline in un processo di replicabilità e trasformazione potenzialmente infinito.
Semiotica dei meme
Un ottimo saggio di Alessandro Lolli, “La guerra dei meme, fenomenologia di uno scherzo infinito”, propone anche una categorizzazione interessante. Ci sono i meme “normie” o “pre ironic” (base più testo), ci sono i meme autoportanti (in cui la base fa già tutto da sè), ci sono i meta meme (quelli in cui la base diventa motivo stesso della punchline), ci sono i meme involontari (immagini che diventano ironiche loro e malgrado e sulla cui diffusione vengono creati dei meme ironic o dei “semplici” fotomontaggi) e poi negli ultimi anni si sono diffuse delle vere e proprie degenerazioni (i cosiddetti dank memes) dove la stessa base diventa quasi irriconoscibile, distorta, deformata e “dissacrata" dagli utenti, perdendo qualsiasi tipo di significato convenzionale e diventando comicità nell’atto stesso di distruzione del meme.
Una struttura incredibilmente pluridimensionale in cui il creatore stesso sparisce per natura. Non è possibile risalire all’autore originale di un meme, semplicemente perché non esiste. Il meme è di tutti e di nessuno, vive un’esistenza propria, incontrollabile, indipendentemente dalla sua origine. E riesce a raccontare in maniera dissacrante il mondo e l’attualità in maniera immediatamente riconoscibile. Non è un caso che i meme, da diversi sociologi, siano considerati oggi una fonte primaria attraverso cui veniamo a conoscenza di notizie e fatti che accadono nel mondo. Che sia un bene o un male, sarebbe sicuramente un discorso che meriterebbe un ulteriore approfondimento.
Ma nella loro semplicità i meme mettono in atto codici, linguaggi e “enciclopedie”, per tornare a un termine caro a Umberto Eco, che permettono via via di leggere e conoscere la realtà, ma anche di aggiungere stratificazioni semantiche, di trasformare la cultura alta e quella pop e di interpretare il mondo attraverso processi (meta)comunicativi potenzialmente infiniti.