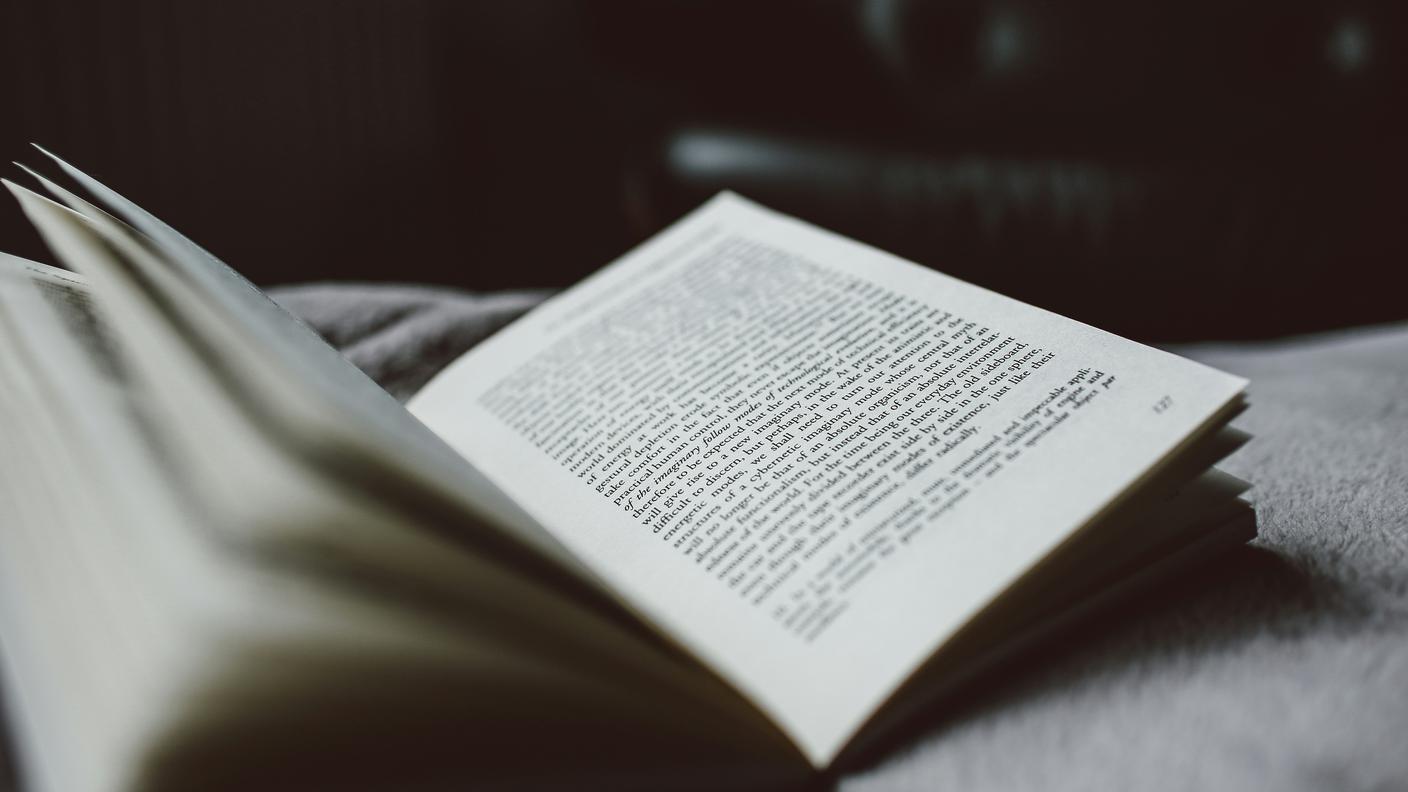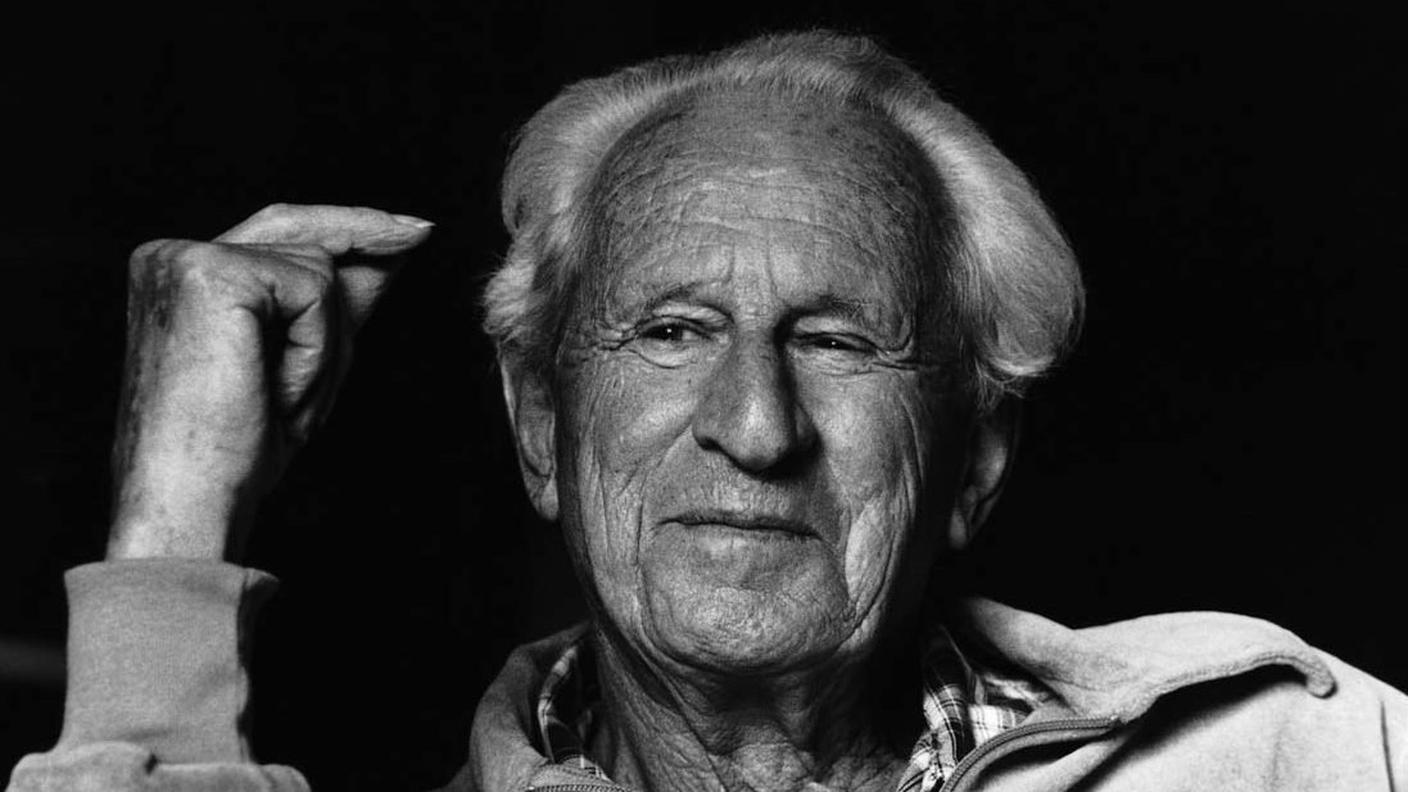Affrontiamo il tema dei giovani, dell’adolescenza e del disagio giovanile, perché oggi se ne parla spesso, soprattutto dopo la pandemia. Gli interventi per affrontare questo disagio sembrano deboli. Infatti, sebbene l’Europa sia una regione dove il benessere sociale tra i più sviluppati, la popolazione più giovane continua ad essere minacciata da povertà e disagio psichico. Secondo i dati dell’UNICEF, oltre 11 milioni di bambini e ragazzi residenti nell’Unione Europea soffrono di disturbi psichici, in particolare tra i giovani, nella fascia di età compresa tra i 15 ed i 19 anni, circa l’8% soffre di ansia e il 4% di depressione.
Dopo gli incidenti stradali, il suicidio, tra l’altro, è la seconda causa di morte. La salute mentale dei minori, oltre a comprendere condizioni diagnosticabili come depressione e ansia, viene influenzata anche da aspetti più ampi come la vita quotidiana, le relazioni sociali e la percezione della propria felicità. Come si individuano le nuove strade per sostenere gli adolescenti nella propria crescita? Ad Alphaville, su Rete Due, si sono espressi sul tema Loredana Cirillo, docente, psicologa e psicoterapeuta presso il centro milanese Minotauro e Daniele Novara, pedagogista, formatore e fondatore del Centro Psicopedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti (CPP).
«Possiamo dire che il “dolore muto” degli adolescenti sia in parte necessario perché conduce alla crescita personale? In parte sicuramente, perché l’adolescenza rappresenta fisiologicamente una metamorfosi che comporta proprio un abbandono del sé infantile per indossare il nuovo sé adolescenziale. Però, se parliamo di sofferenza e di quel male, delle quote di malessere che rivelano anche sottostimando le le statistiche, è un dolore legato al fatto che gli adolescenti vivono in una condizione sociale, familiare, relazionale, direi contraddittoria. Da un lato è una generazione ascoltata, ricoperta di disponibilità, di oggetti, di risorse, ma dall’altro lato sono ragazzi che faticano a mettere in campo la loro voce e le loro emozioni più autentiche, in particolare il dolore, la rabbia, la tristezza. Si fatica ad oggi ad ascoltarli socialmente non soltanto ovviamente nella relazione genitori figli».
Loredana Cirillo, docente, psicologa e psicoterapeuta
La contrapposizione del mondo dei giovani e quello degli adulti c’è sempre stata? Il fatto, cioè, che i giovani naturalmente si sentano no di rivendicare il loro futuro. Oggi ci troviamo di fronte ad una situazione più complessa e più preoccupante rispetto alla stessa situazione del passato o, in realtà, i problemi sono gli stessi che ci sono sempre stati e li stiamo soltanto ingigantendo perché se ne parla di più?
«Bisogna capire come va avanti questa partita sull’intelligenza artificiale e sulle tecnologie digitali, perché se effettivamente va nella direzione che vogliono le multinazionali digitali, c’è il rischio che una generazione ne faccia davvero le spese e finisca in un isolamento che provoca non solo dolore, ma disturbi mentali da tutti i punti di vista. Noi ci stiamo battendo come pedagogisti, perché vengano messi dei limiti, vengano regolati questi strumenti, per cui fino a 14 anni gli smartphone non dovrebbero essere a disposizione dei ragazzi e delle ragazze. E, come ha fatto l’Australia, bloccare i social, regolamentarli fino ai 16 anni, pena sanzioni economiche durissime nei confronti delle piattaforme che consentono tutto ciò. Non si può permettere che un adolescente o un pre-adolescente passi oltre 7 ore al giorno davanti ai dispositivi elettronici. Questa è una partita e una battaglia che dobbiamo combattere se vogliamo salvare le nuove generazioni. Altrimenti se prende piede l’intelligenza artificiale, allora non è che ne facciamo le spese noi cinquantenni, ma ne faranno le spese i ragazzi e le ragazze».
Daniele Novara, pedagogista, formatore
Secondo Loredana Cirillo, tuttavia, «il problema non è solo degli adolescenti, poiché la questione si pone prima di tutto per gli adulti», che offrono «un modello di identificazione che vive connesso ventiquattro ore al giorno, in una società in cui il mondo reale e il mondo virtuale sono strettamente interconnessi». Seppur le dinamiche adolescenziali siano in qualche modo universali, permane il fatto che la cornice sociale in cui avviene l’adolescenza sia oggi profondamente mutata. Perciò, se «gli adulti trasmettono il messaggio per cui i valori preminenti sono la popolarità e la visibilità, occorre lavorare su questa concezione che responsabilizza in primis gli adulti rispetto agli adolescenti, che rappresentano l’ultimo anello della catena di montaggio societaria». Il discorso deve dunque «chiamare in causa la responsabilità adulta, il tema delle emozioni e dell’autenticità», questi sono «i temi su cui è importante porre attenzione, di cui è importante parlare a scuola e muovere azioni psicologiche, educative e sociali» in questo senso.
In Svizzera la Pro Juventute ha svolto uno studio sui casi di malessere giovanile, in cui è emerso che a vivere il disagio maggiore sono le ragazze, che si affidano a forme di psicoterapia più frequentemente. È un dato che possiamo considerare attendibile? Esiste una vera e propria differenza di genere su questo tema?
«Questo paradossalmente smentisce i dati della Pro Juventute. I maschi in questo momento sono in crisi in tutto il mondo occidentale, basti guardare i dati scolastici. Chi si sta laureando sono le ragazze, non sono i ragazzi. Chi ha subisce le etichette neuro-diagnostiche a scuola nell’85% dei casi, in Italia, sono i maschi. Non le femmine. Il disagio è prevalentemente dentro un genere che in questo momento è in crisi, specialmente nell’incapacità di chiedere aiuto anche sul piano psicologico e psicoterapeutico. Per cui se il dato viene registrato negli studi di psicoterapia è un equivoco, perché chi si fa aiutare vuol dire che si è messo in discussione e che il primo passo l’ha già compiuto».
Daniele Novara, pedagogista, formatore
«Io ricordo che abbiamo dei numeri che non avevamo mai avuto di ragazzi che tentano il suicidio. Sicuramente le ragazze accedono maggiormente agli sportelli d’aiuto perché è nel genere femminile da sempre, anche se oggi parlare di genere femminile e maschile sempre una particolarità che spetta a noi della vecchia generazione , e comunque tendenzialmente le ragazze hanno un’attitudine alla parola quindi ad esprimere verbalmente il loro disagio, molto più incidente dei ragazzi. Detto questo, il maschile sicuramente soffre di una crisi epocale, a fronte anche di uno sviluppo di autonomie e competenze del femminile che li vede senza ruolo fondamentalmente. Detto ciò, mi preme soprattutto sottolineare un aspetto. Oggi uno dei problemi principali che incontriamo è legato al fatto che gli adolescenti faticano a confrontarsi e confidarsi proprio per quel discorso delle proprie emozioni negative, delle proprie esperienze dolorose che, come dicono loro, “se ne parlo a qualcuno rischio di apparire pesante, rischio di trovare una risposta negativa e quindi di sentirmi ancora più solo”. Infatti, sentirsi soli in mezzo agli altri è uno dei vissuti più ricorrenti oggi nei ragazzi che incontriamo».
Loredana Cirillo, docente, psicologa e psicoterapeuta
Adolescenza inquieta
Alphaville 12.02.2025, 12:35
Contenuto audio