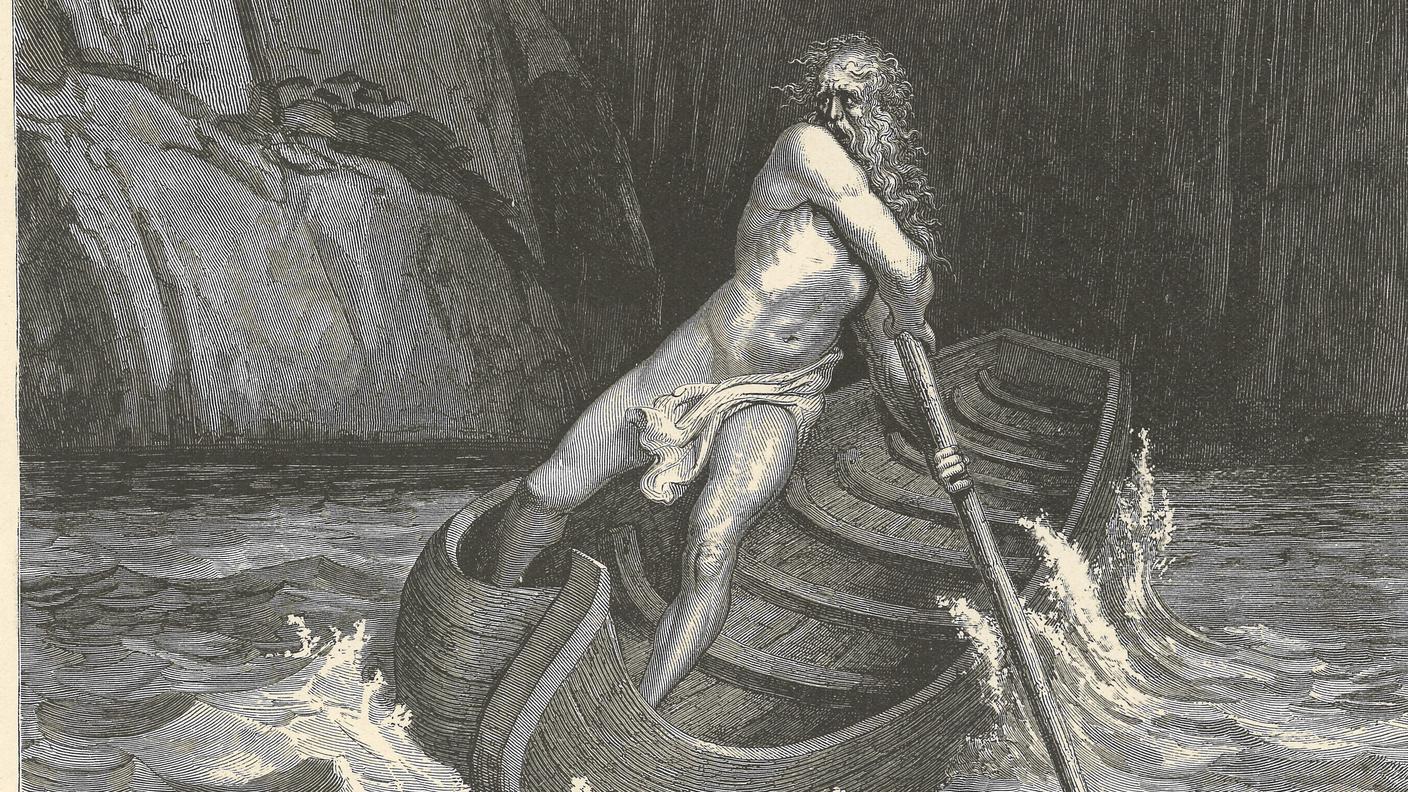«We the People» – noi, il popolo. È con queste parole che si apre la Costituzione degli Stati Uniti, evocando un’idea di coesione nazionale e appartenenza condivisa. Eppure, sin dalle origini, quella formula solenne ha convissuto con esclusioni sistemiche, fratture razziali, diseguaglianze di genere, conflitti religiosi e discriminazioni culturali. La democrazia americana, come afferma la storica Raffaella Baritono, non è mai stata un blocco compatto e armonioso, ma un campo di tensioni, un’arena in cui si è giocata – e si gioca tuttora – la definizione stessa dell’identità nazionale.
Il titolo dell’intervento, I ‘margini’ della democrazia americana tra eredità storica e sfide del presente, rinvia a un doppio movimento: da un lato, le promesse emancipatorie inscritte nel discorso democratico; dall’altro, le fratture che lo attraversano e lo limitano. Una dialettica che accompagna la storia degli Stati Uniti almeno dalla prima inaugurazione di Thomas Jefferson nel 1801, fino ai giorni nostri.

Thomas Jefferson
Blu come un'arancia 25.10.2016, 09:15
Contenuto audio
L’espansione democratica negli Stati Uniti si è costruita su una contraddizione strutturale: ogni passo avanti verso l’inclusione è stato accompagnato da nuove linee di esclusione. La cittadinanza, mai davvero universale, si è definita attraverso soglie mobili fondate su etnia, razza, genere, religione. La democrazia americana non è mai stata una linea ascendente, ma un campo di forze in tensione. Istituzionalmente solida, ha vissuto fratture profonde sul piano della rappresentanza e della partecipazione. Si è trattato di un processo conflittuale, capace di espandersi e di ritrarsi, di includere e respingere, spesso nello stesso tempo. Dal suffragio negato alle donne e alle minoranze, alla segregazione imposta dopo l’abolizione della schiavitù; dalla stagione delle Jim Crow Laws alla criminalizzazione del dissenso durante la guerra fredda, ogni apertura ha prodotto reazioni. Oggi, quelle fratture sembrano più vive che mai.
La voce degli schiavi (2./5)
Alphaville 08.04.2025, 12:05
Contenuto audio
Nel mirino delle contestazioni più accese ci sono proprio quei programmi – DEI: Diversity, Equity, Inclusion – che mirano a garantire rappresentanza alle minoranze. In molti Stati, soprattutto del Sud, si assiste a un’offensiva politica e legislativa che mira a smantellare queste politiche, dipinte come ideologia divisiva o “discriminazione al contrario”.
A dare forza a questa visione contribuisce la retorica presidenziale. Nel suo discorso inaugurale del 2017, Donald Trump parlò di American carnage, evocando un’America devastata da criminalità, immigrazione, declino morale. È un’immagine cupa, che contrappone un popolo “puro” a élite corrotte e nemici interni. Otto anni dopo, nel discorso al Congresso del 2025, Trump torna a usare gli stessi registri: la nazione è minacciata dall’interno, la democrazia deve difendersi dai “nemici del popolo” – un’espressione usata per designare, tra gli altri, giornalisti, attivisti, migranti, giudici. La narrazione democratica si trasforma così in una strategia identitaria, escludente, costruita sull’opposizione tra “noi” e “loro”.
Questa deriva retorica si inserisce in un movimento culturale più ampio, che da decenni cerca di ridefinire la democrazia non come inclusione delle differenze, ma come ritorno all’ordine e alla stabilità. In questa prospettiva, ogni rivendicazione di riconoscimento – razziale, di genere, religiosa – viene riletta come minaccia all’universalismo astratto della cittadinanza.
A questa tensione si somma quella, ormai strutturale, tra Presidenza e Congresso. Dalla Guerra del Vietnam a oggi, i due rami del potere federale si contendono la legittimità del comando, soprattutto in politica estera. La figura presidenziale si è rafforzata nei momenti di crisi, mentre il Congresso, sempre più frammentato, alterna slanci e paralisi. La democrazia americana si conferma così un sistema in cui il conflitto istituzionale è parte integrante del funzionamento, ma anche del rischio. Emblematico, in questo senso, il caso della celebre fotografia della Napalm Girl, che contribuì a scuotere l’opinione pubblica durante la guerra del Vietnam e a spingere il Congresso verso l’approvazione del War Powers Act nel 1973: una reazione simbolica e istituzionale all’eccessiva autonomia dell’esecutivo in materia militare.

The Terror of War, di Nick Ut (1972).
Lungi dall’aver raggiunto la sua forma compiuta, la democrazia, negli Stati Uniti come altrove, è segnata oggi da fratture, crisi, reinvenzioni. In questo senso, parlare di margini in relazione alla parabola democratica, non significa solo denunciare ciò che manca, ma interrogare criticamente ciò che è stato incluso – e a quali condizioni.
In un’epoca segnata dal ritorno di pulsioni autoritarie e dalla crisi del discorso pubblico, il compito della storia è quello di restituire complessità alle parole e memoria ai diritti. La democrazia, ricorda Raffaella Baritono, non è un bene da conservare, ma una pratica da esercitare. Non un monumento alla stabilità, ma un terreno vivo, fragile, di lotta, dove la democrazia si rivela per ciò che è: una promessa esposta al rischio, un confronto incessante tra chi chiede voce e chi costruisce silenzio, tra chi reclama appartenenza e chi disegna i confini dell’esclusione.