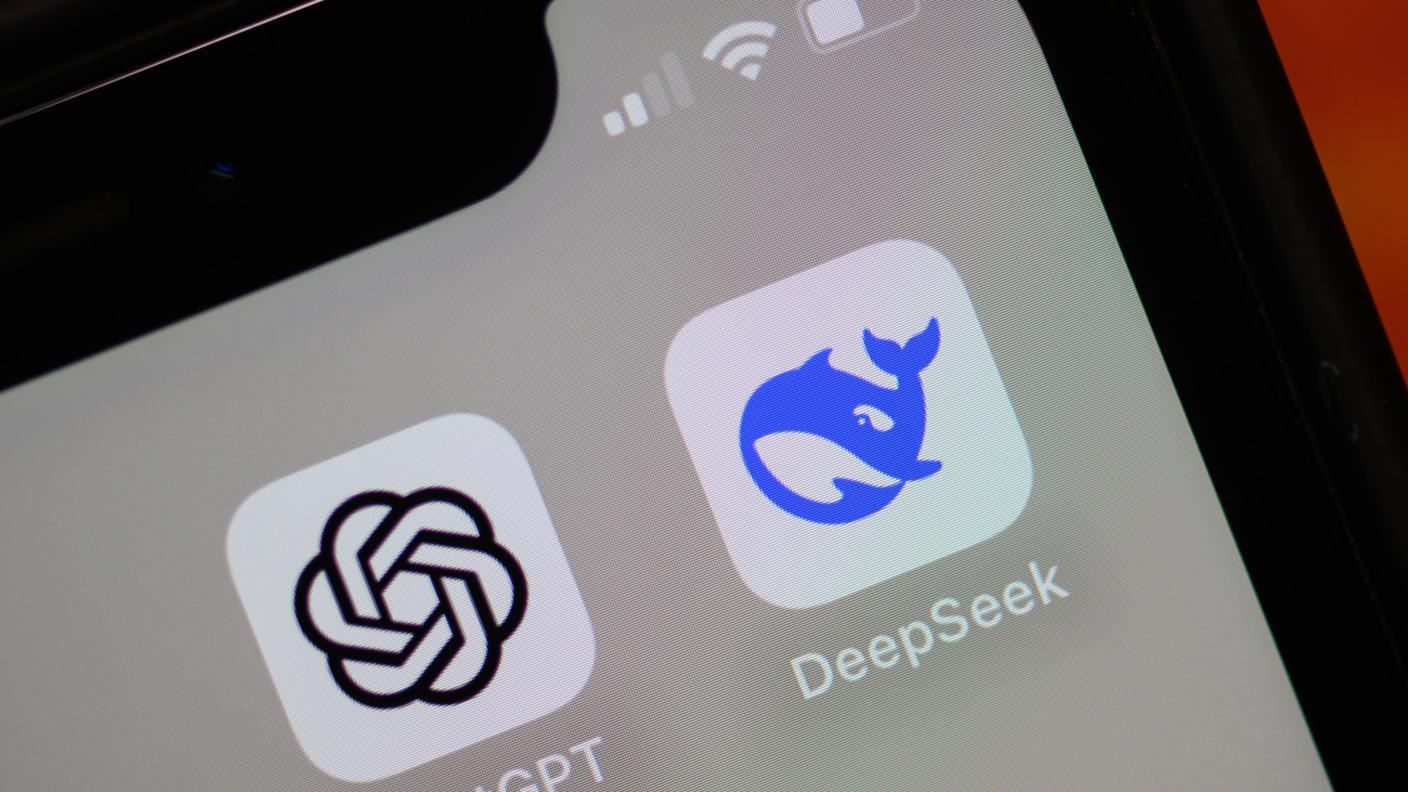Dal giorno del suo insediamento a gennaio 2025, il presidente americano Donald Trump e la sua squadra hanno tagliato fondi per miliardi di dollari alle università e alle agenzie scientifiche statunitensi.
Anche se in molti casi le misure intraprese sono bloccate nei tribunali, in altri i licenziamenti di massa sono già in atto, specie nelle agenzie che si occupano di ambiente: alla National oceanic and atmospheric administration (Noaa), uno degli organismi dedicati alla lotta ai cambiamenti climatici più importanti al mondo, 1’300 persone hanno già perso il posto di lavoro, un numero pari al 10% dell’organico.
Misure che stanno spingendo il personale accademico a correre ai ripari, ripensando le proprie prospettive di carriera. A rivelarlo, è un recente sondaggio pubblicato dalla prestigiosa rivista Nature, che ha chiesto ai propri lettori se questi cambiamenti li stessero portando a considerare di abbandonare gli Stati Uniti.
Dei 1’650 partecipanti al sondaggio, circa i tre quarti dichiarano di valutare un trasferimento. Un censimento che, pur non garantendo una rappresentatività dell’insieme della comunità scientifica, è indicatore di una preoccupazione diffusa fra ricercatori e ricercatrici statunitensi. In particolare, Europa e Canada appaiono in cima alla lista delle destinazioni più ambite, mentre a dimostrare una più ferma volontà di espatriare sono i ricercatori a inizio carriera.
Il sondaggio realizzato da Nature: "Sei un ricercatore statunitense e stai considerando di abbandonare il paese in seguito ai tagli alla scienza voluti dall'amministrazione Trump?"
In effetti, “a corto termine, saranno i giovani ricercatori, studenti e dottorandi, a subire le conseguenze maggiori degli tagli: una cospicua parte dei fondi viene utilizzata per i loro salari”, ci conferma un fisico di origini ticinesi, oggi professore in una nota università statunitense, che per tutelarsi preferisce mantenere l’anonimato.
In questo stato di incertezza, ci spiega, molte università hanno ridotto, se non congelato, le assunzioni. Ci sono poi casi di “ricercatori esteri che hanno deciso di non raggiungere istituti americani. Un paio di colleghi del MIT (Massachusetts Institute of Technology) hanno “perso” ottimi candidati postdoc, e non solo stranieri: ci sono americani che preferiscono trasferirsi in Cina per proseguire la loro carriera. Una professoressa a Yale – aggiunge il ticinese - ha perso i fondi che aveva ricevuto per la sua ricerca e si è trasferita all’Università di Toronto”.
E alla domanda: “pensa di abbandonare gli Stati Uniti prossimamente?”, la risposta del professore è interlocutoria: “Ad oggi no, ma è comunque un’opzione che potrei valutare ad un certo punto”.
L’allerta di Science: la fuga è già in atto
A sostegno dell’ipotesi di un’imminente fuga di massa, c’è un’altra prestigiosa rivista scientifica: in un editoriale apparso nelle scorse ore su Science, si legge che l’esodo di ricercatori verso l’Europa è già iniziato. Fra le destinazioni menzionate c’è la Germania, dove la Max Planck Society ha visto aumentare le domande da parte di ricercatori provenienti dagli Stati Uniti e si sta attrezzando per accoglierli.
L’articolo, co-curato da Stefan Raff-Heinen, professore presso l’Istituto di management delle tecnologie digitali della BFH di Berna, menziona anche il Politecnico federale di Zurigo, che “trarrà probabilmente vantaggio dallo spostamento di talenti di alto livello dagli Stati Uniti”.
Da noi interpellato, l’ateneo sulla Limmat non si sbilancia per ora con delle cifre: “al momento non è possibile osservare una chiara tendenza di crescita delle domande”. Diverso il discorso all’EPFL, dove già da alcune settimane si riporta un aumento delle domande d’impiego provenienti dagli Stati Uniti. Da Politecnico di Losanna ci confermano che “le candidature spontanee sono in continuo aumento, sia in termini di quantità, sia di qualità”.
Ma “se questo esodo avrà delle ripercussioni sul nostro territorio e sugli equilibri globali della ricerca scientifica, è ancora presto per dirlo”, puntualizza Swissuniversities, organizzazione mantello delle università svizzere.
Stati Uniti: la scure sui finanziamenti alle università
Alphaville 26.03.2025, 12:35
Contenuto audio
Stati Uniti, verso un ruolo marginale nel panorama scientifico globale?
Per comprendere quali rischi comporta l’operazione di riduzione dei costi per la ricerca condotta dal presidente USA Donald Trump e dal miliardario Elon Musk, in particolare nel settore tecnologico, è utile tornare sulle parole dell’editoriale di Science: “i tagli al sostegno federale per la deep tech – si legge – minacciano il motore imprenditoriale alla fonte: i laboratori universitari. Senza un sostegno federale duraturo, il Paese rischia di perdere il suo vantaggio tecnologico, minacciando la competitività economica e la sicurezza nazionale”.
Nell’articolo si mette inoltre in evidenza come il predominio degli Stati Uniti in ambito tecnologico si sia costruito investendo nel lungo periodo nei settori più svariati, come quello dei semiconduttori, della tecnologia aerospaziale o dei vaccini a mRna.
Secondo gli autori, è a rischio la figura di scienziati-imprenditori: quei ricercatori cioè che, grazie ad attrezzature e tempi di incubazione che solo un sostegno federale può garantire, sono in grado di trasformare le scoperte scientifiche in start up e applicazioni nel mondo reale. L’innovazione, motore dell’economia, rischia così di essere soffocata. E i ricercatori fuggono verso Paesi con un più forte sostegno pubblico alla ricerca.

I tagli di Trump preoccupano le università svizzere
Telegiornale 18.03.2025, 20:00
L’onda lunga dei tagli minaccia l’Europa
Se da una parte l’Europa, e quindi la Svizzera, potrà trarre vantaggio da questa crisi offrendo un ambiente più stabile ai ricercatori, dall’altra occorrerà capire in che modo la soppressione dei fondi porterà a ripercussioni globali.
L’EPFL di Losanna ha accordi con Washington per un valore di 1,2 milioni di franchi annui. L’ETH di Zurigo, nell’ultimo decennio, ha ottenuto 2,5 milioni di franchi svizzeri all’anno: attualmente, sono 14 i progetti finanziati in questo modo. E altri contributi finiscono nelle casse delle restanti università d’Oltralpe.
Proprio il Politecnico federale di Zurigo lo scorso 16 marzo 2025, riporta la NZZ am Sonntag, ha ricevuto un questionario dalle autorità statunitensi, intenzionate a sondare in che misura tematiche come clima, diversità, uguaglianza e inclusione riguardano i progetti finanziati.
https://rsi.cue.rsi.ch/info/svizzera/%E2%80%9CI-questionari-di-Trump-La-scienza-non-%C3%A8-un-partito-politico%E2%80%9D--2682944.html
Questionario che l’ateneo, ha anticipato radio SRF, ha rispedito in bianco al mittente, affermando che «le domande poste non erano in alcuna misura pertinenti al progetto di ricerca in questione e che una simile richiesta di informazioni non rientra nelle pratiche standard». Non è chiaro quale tipo di conseguenze potrà avere sui finanziamenti una tale decisione.
Una rete globale di scambio a rischio
La ricerca scientifica è di natura un ecosistema globale fatto di scambi e collaborazioni. Ecco perché “le restrizioni nei finanziamenti, il controllo legislativo e le interferenze istituzionali compromettono gli sforzi accademici non solo negli Stati Uniti, ma in tutto il mondo”, si legge in una dichiarazione dell’Alleanza delle università europee (Allea), sottoscritta anche dall’Accademia svizzera delle scienze. “La restrizione della condivisione di dati transatlantici mette a rischio la ricerca da entrambe le sponde dell’Atlantico, compromettendo decenni di collaborazione che hanno portato a scoperte rivoluzionarie”.
In questo ecosistema globale, non è raro che personale svizzero venga sostenuto puntualmente da fondi americani. È il caso di Gino Caspari, ricercatore svizzero attivo presso l’Università di Berna e il Max Planck Institute in Germania, che si è visto azzerarare i fondi di un progetto di ricerca dedicato alla disinformazione sui social media, interamente finanziato dal Dipartimento di Stato americano. “Per questo motivo, il progetto è stato abbandonato”, spiega sui social media.
Da noi raggiunto, il ricercatore, che su Instagram si rivolge a oltre 120’000 follower in qualità di divulgatore scientifico, ci parla anche di un rientro di cervelli verso l’Europa, e aggiunge: “la competitività del nostro continente aumenterà notevolmente. È importante coltivare un ambiente che ci permetta di attrarre i giovani ricercatori eccellenti a lungo termine”. Una mezza vittoria, in un panorama globale scientifico sempre più incerto e frammentato.
Fonti: