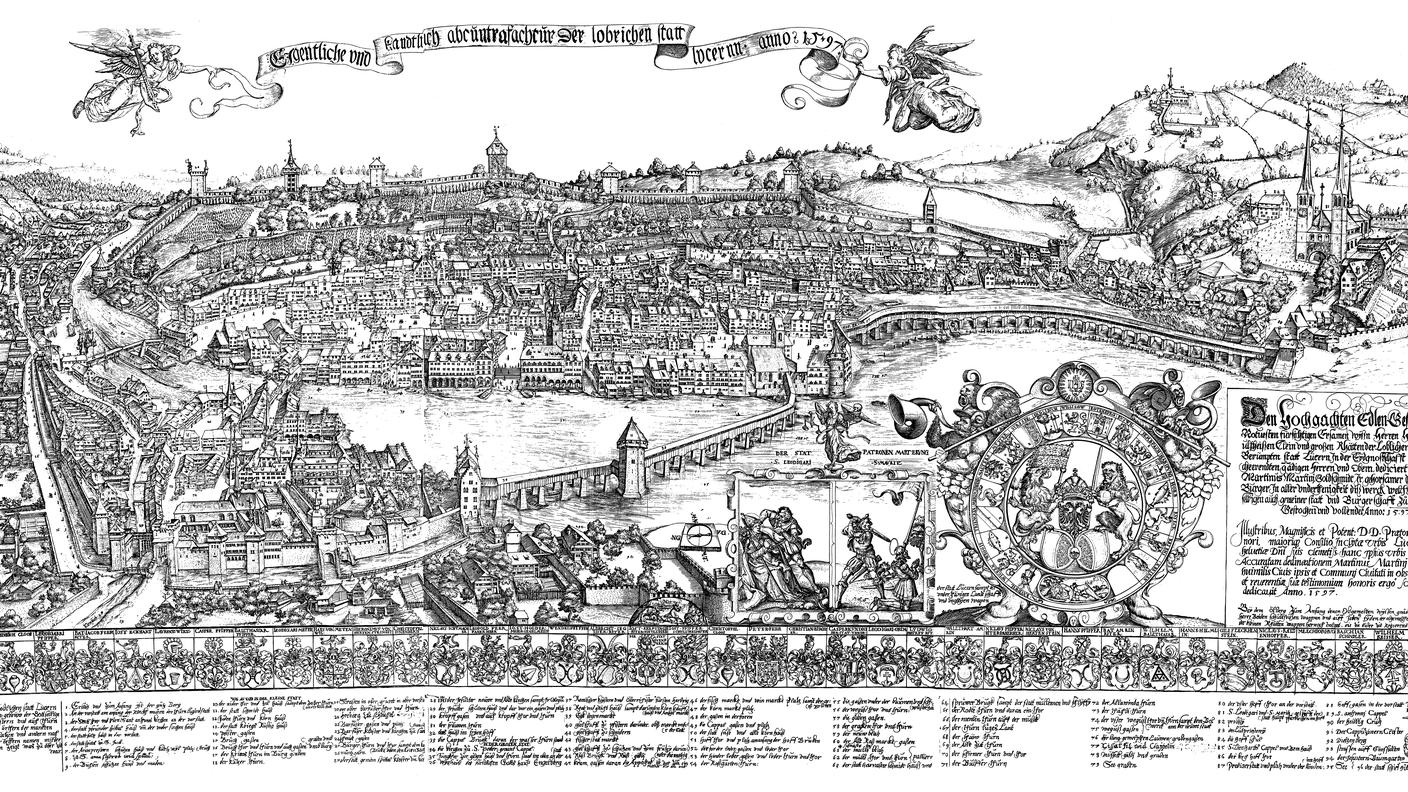C’è un nesso robusto, quasi immediato, che lega la marginalità alla follia. Uomini e donne che vagano per le città trascinando gelosamente i loro poveri averi ora proferendo parole incomprensibili ai più, ora apostrofando i passanti, ora inveendo contro il prossimo; è un’immagine condivisa che sintetizza questo nesso. Un’immagine nota, costruita su più margini. Marginalità sociali, economiche, a cui si uniscono quelle di genere, di colore della pelle, di salute mentale per l’appunto.
I margini sono stati edificati nel corso del tempo e a noi storiche e storici spetta il compito di decostruirli per spiegarne i significati, le poste in gioco, i cambiamenti culturali sottesi. Il percorso che vorrei proporre riguarda sì certo la costruzione del margine rispetto alla follia, ma anche i suoi molteplici rovesciamenti e i tanti attraversamenti: quale tipo di resistenza hanno suscitato nel tempo i numerosi muri edificati contro i soggetti etichettati come matti? Stare dentro le linee e i confini della marginalità ha significato certamente essere esclusi, ma a tale esclusione non sempre ha corrisposto una totale reificazione, un annullamento dell’attività creatrice e dell’espressione di sé.
Follia, l'altra verità - 1990
RSI Speciali 16.03.2016, 11:40
Un sapere e un sistema di valori che pongono come prioritari la razionalità del lavoro ed un ordine sociale strutturato in classi sociali e su ruoli di genere ben definiti, collocano le paure, i sentimenti religiosi intensi, le fantasie più disparate nell’area dell’irragionevolezza e dell’incomprensibile. L’imprevisto non è auspicabile e destabilizza. Non è certo un caso che sarà proprio dal seno della cultura illuminista che sboccerà il moderno sistema di “governo della follia”, affidato ad un nuovo corpo professionale – gli alienisti, poi chiamati psichiatri –, correlato ad un sistema di controllo del territorio che coinvolge prepotentemente soprattutto le forze di sicurezza. Una nuova gestione si fa strada ed è legittimata da un sapere intento a classificare e normare comportamenti percepiti come bizzarri, sempre meno tollerati e con un nuovo spazio di intervento terapeutico ben definito: il manicomio.

Anime di Cartapesta. Il Presepe del manicomio di Cogoleto (2007).
La realizzazione di questo progetto è un capitolo complesso della storia contemporanea, ma è quello che ha visto in un primo momento riempire le antiche strutture ospedaliere e di assistenza di soggetti ritenuti matti (Michel Foucault per Parigi ha chiamato questo processo «grande internamento»), pensati curabili attraverso la segregazione e l’intervento del direttore/padre che assemblava tutti i poteri all’interno di queste nuove istituzioni. Non solo. Il medico direttore avrebbe dovuto persino maneggiare le menti dei poveri internati smarriti. Le macro-trasformazioni sociali ed economiche del XIX secolo per un altro verso – crescita delle città, diffusione dei sistemi industriali, trasformazioni dell’aggregato familiare – fanno lievitare le domande di assistenza e allora i manicomi si gonfiano a dismisura; progressivamente cresce il loro numero, ma adesso sono preferibilmente edificati ai margini delle città, dove è più facile godere di parchi, di un’aria più salubre e – soprattutto - essere meno in vista. Eppure, talune famiglie, se possono e compatibilmente con i loro bisogni anche economici, resistono al progetto di medicalizzazione della follia perché considerano una diminutio trattenere il proprio congiunto e, soprattutto nei paesi mediterranei, la propria congiunta in una istituzione di pubblica assistenza. L’internamento equivale ad una resa per la famiglia, corrisponde alla evidente incapacità di saper controllare tutti i suoi membri.
https://rsi.cue.rsi.ch/cultura/societa/La-lezione-di-Basaglia--2087322.html
Ciò che colpisce di più, però, sono le parole e le espressioni delle e dei ricoverati. Scrivono per attraversare i muri di cinta - i margini fisici -, ma non soltanto per raggiungere un altrove che giustamente identificano con la libertà; certo che la richiesta più diffusa è quella di fuggire dal manicomio, ma c’è anche una posta in gioco ben più complessa: parlano dei loro desideri, della loro sofferenza, dei loro dolori psichici, che investono una fisicità e una corporeità non più previste dalla psichiatria sempre più orientata ai dati organici. Gli internati si interrogano sul senso delle loro azioni e della loro vita, esprimono conflitti interiori e sociali, punti di vista sul mondo e sulla politica. Insomma, cercano una interlocuzione, una relazione su temi che i nuovi canoni di comunicazione sociale non contemplano e spingono ai margini. Il paradosso è che, senza negare la sofferenza, segregati entro un margine insormontabile, gli internati esprimono irriverenza, irridono il potere costituito, si pensano come mostri, con corpi grotteschi e pertanto liberi di poter dire tutto. I matti continuano ad andare al cuore dei temi esistenziali, ma i loro argomenti non stanno più in un quadro epistemico condiviso; in sostanza nessuno ha voglia di ascoltarli e forse neppur la capacità di farlo. Come accade oggi nei confronti di chi attraversa le nostre città con i propri poveri averi.
Dossier: Echi di storia
Contenuto audio
Recup, comunità di periferia (1./5)
Alphaville 07.04.2025, 12:05
La voce degli schiavi (2./5)
Alphaville 08.04.2025, 12:05
“Storie che non fanno la storia” (3./5)
Alphaville 09.04.2025, 12:05
Voci recluse. Testimonianze di minori internati in Ticino (4./5)
Alphaville 10.04.2025, 12:05
Per carità: tra assistenza e disciplina (5./5)
Alphaville 11.04.2025, 12:05