Una pittrice eccellente che seppe imporre il proprio talento in un ambiente prettamente maschile; una donna coraggiosa, che ebbe la forza di affrontare lo scandalo, l’umiliazione e la tortura pur di denunciare l’uomo che l’aveva violentata.
Vissuta nella prima metà del Seicento, Artemisia Gentileschi (nata l'8 luglio 1593 a Roma) dopo la morte cadde per lungo tempo nel dimenticatoio, ma oggi viene riconosciuta fra i massimi esponenti del caravaggismo italiano. Fu riscoperta grazie al critico d’arte Roberto Longhi e a sua moglie, la scrittrice Anna Banti, che profondamente colpita dalla sua storia ne prese ispirazione per il romanzo Artemisia (1947). Grazie al successo del libro, nel fermento sociale dei decenni successivi la figura di Artemisia divenne anche un simbolo della lotta per i diritti delle donne.
Il valore delle sue opere – è importante sottolinearlo – va ben oltre la gravità del trauma e delle difficoltà subiti. Se oggi la sua Giuditta che decapita Oloferne è esposta agli Uffizi di Firenze non è tanto per il tormento che ci sta dietro, ma soprattutto per la sua maestria di pennello, per i lunghi studi, per la ricerca di un’originalità espressiva potente. D'altra parte, però, i suoi dipinti portano anche testimonianza bruciante di un personale percorso di rivincita: sono il campo di battaglia in cui questa donna-artista combatté gli uomini che avevano provato ad annientarla. Perché la giustizia che non ottenne nella vita reale, lei, Artemisia, se la conquistò nell’arte.
Artemisia venne violentata quando aveva diciassette anni. I fratelli erano ancora piccoli e la madre era morta precocemente di parto, mentre il padre Orazio, a sua volta pittore, era spesso assente. L’appartamento dei Gentileschi era un via vai di uomini adulti, artisti (fra cui Caravaggio), mercanti e usurai. Orazio, ben conscio del pericolo che correva la ragazza, cercava di tenerla al riparo confinandola nelle sue stanze, e alimentando da lì il suo precoce talento per la pittura. E fu così, chiedendo al suo amico Agostino Tassi di insegnarle la prospettiva, che inconsapevolmente introdusse il mostro in casa.
Le violenze durarono mesi grazie al silenzio complice dei vicini, i quali speravano che gli abusi avrebbero giovato ad Artemisia un matrimonio riparatore “vantaggioso”. Una pratica che – tra l’altro – non è affatto relegata a un passato barbaro e oscurantista ma che è rimasta in vigore in Italia fino al 1981. Per non parlare di alcuni paesi dall’altra parte del Mediterraneo, dove questa norma esiste tutt’ora.
Mi mise una mano con un fazzoletto alla gola et alla bocca acciò non gridassi e le mani quali prima mi teneva con l'altra mano mi le lasciò, havendo esso prima messo tutti doi li ginocchi tra le mie gambe... gli sgraffignai il viso e gli strappai li capelli et avanti che lo mettesse dentro anco gli detti una matta stretta al membro che gli ne levai anco un pezzo di carne...
Artemisia Gentileschi, Atti del processo.
Quando Orazio Gentileschi scoprì i fatti, denunciò Tassi per stupro e lo trascinò a processo. Durante gli interrogatori Artemisia rimase lucida e coerente con le sue accuse, benché sottoposta a umilianti ispezioni ginecologiche e alla tortura della sibilla, che oltre al supplizio rischiava di deformarle i pollici per sempre e non farle mai più tenere in mano un pennello. Agostino Tassi venne condannato a cinque anni di esilio da Roma, ma grazie alle sue conoscenze altolocate non li scontò mai. La reputazione di Artemisia era invece irrimediabilmente rovinata: incorse comunque in un matrimonio riparatore con un debitore del padre e si trasferì a Firenze.

Le Giuditte di Caravaggio (1602, a sinistra) e di Artemisia Gentileschi (1617, a destra) a confronto
Pochi anni dopo dipinse la sua prima Giuditta che decapita Oloferne. L’episodio è tratto dalla Bibbia: il popolo d’Israele è assediato dall’esercito assiro e per salvarlo la bella vedova Giuditta si introduce nella tenda del re nemico Oloferne e, dopo averlo sedotto, lo uccide mozzandogli la testa. Sulla scorta della lezione caravaggesca, Artemisia realizza una scena universalizzante, resa grazie allo sfondo scuro, e illuminata da squarci di luce espressionistici. Importanti sono però le novità.
La serva Abra, che in Caravaggio e nel racconto biblico assisteva passiva, diventa aiutante. Artemisia purtroppo sapeva fin troppo bene quanto può essere forte un uomo: le due donne devono unire le loro forze per riuscire a sopraffare fisicamente il possente Oloferne, colto nel suo ultimo spasimo. Per Caravaggio, inoltre, Giuditta è chiaramente anche un oggetto estetico: è molto giovane, con i capelli biondi come prevede il canone della donna angelicata di ascendenza petrarchesca e la sua bellezza è messa ancora più in risalto dalla bruttezza della vecchia serva. In Artemisia invece Giuditta ha perso ogni traccia di candore, il suo volto è una maschera di fredda determinazione. Lei e Abra non sono né belle né brutte ma contano solo in quanto attanti, in quanto donne che compiono l’uccisione di Oloferne, il quale – concordano i critici – ricorda i tratti di un personaggio reale. Chi, se non Agostino Tassi?
Le protagoniste di Artemisia Gentileschi
Lungo tutta la sua opera si individua il tema costante della rivalsa del genere femminile su quello maschile. La scelta dei soggetti torna ossessivamente su casi storici o biblici di donne forti e inflessibili che uccidono i loro nemici (Giuditta che decapita Oloferne, Giaele che conficca un picchetto nel cranio di Sisara) oppure ammazzano i propri figli per punire il tradimento del marito (Medea) o addirittura sé stesse, pur di non venir soggiogate (Cleopatra che si avvelena con il morso di un serpente per non essere catturata viva da Cesare, Lucrezia che si pugnala al cuore non tollerando la vergogna dello stupro). E quando si concedono sessualmente (Giuditta, Giaele, le figlie di Loth), lo fanno per uno scatto di autodeterminazione: sono le donne, solo le donne, a decidere quale uso fare del proprio corpo.
È qui la forza dei quadri della Gentileschi: nel capovolgimento brusco dei ruoli. Una nuova ideologia vi si sovrappone, che noi moderni leggiamo chiaramente: la rivendicazione femminile
Roland Barthes
Così Artemisia Gentileschi trovò una via per esorcizzare la violenza subita da ragazza e le continue lotte affrontate da adulta: l’invidia del marito Pierantonio Stiattesi, pittore mediocre, le maldicenze della gente che l’accompagnarono per tutta la vita, la fatica per accedere – prima donna della storia – alla prestigiosa Accademia del Disegno fiorentina. Nelle narrazioni vincenti di quelle eroine di altri tempi, in cui spesso affiorano i lineamenti del suo stesso volto, riversò tutta la rabbia, l’energia, la voglia di libertà e indipendenza. Per fortuna lungo il suo cammino trovò anche persone illuminate, come il mecenate Cosimo II de Medici, Galileo Galilei, Michelangelo Buonarroti il giovane e Filippo IV di Spagna, che seppero vedere la sua bravura di pittrice, prima della sua condizione di “donna disonorata”.
Se però Artemisia è Giuditta, è anche Susanna, un’altra protagonista biblica che torna periodicamente nei suoi quadri, sorpresa durante il bagno da due vecchioni che provano ad abusare di lei. Un episodio dove la donna non è vittoriosa ma disarmata e impotente. La versione del 1622 risulta la più drammatica: Susanna cerca di coprirsi il seno nudo con un'espressione di sconfitta, mentre i due uomini si chinano minacciosamente su di lei. Le loro figure formano quasi un unico mostro. L’uno assomiglia di nuovo ad Agostino Tassi e l'altro a Orazio Gentileschi, il padre di Artemisia, che prima la protesse e poi la vendette in sposa a Stiattesi.

Due versioni di 'Susanna e i vecchioni' di Artemisia Gentileschi: del 1622 (a sinistra) e del 1652 (a destra)
L’ultima Susanna e i vecchioni, meno riuscita a livello artistico, risale invece agli ultimi anni di vita. I due vecchi non stanno più sopra ma di fianco, sul medesimo piano, mentre la ragazza non è più nuda ma coperta da una veste candida. Loro provano a minacciarla ma lei alza il braccio, li ferma, apre a sua volta la bocca per parlare o forse per gridare aiuto.
Mi piace immaginare che la resistenza, non truculenta ma ferma, dell’ultima Susanna sia la prova che Artemisia Gentileschi avesse finalmente superato e dimenticato il dolore degli stupri. O, per lo meno, che nella favolosa finzione dell’arte questa figura dalle mille incarnazioni si sia salvata, scampando alle molestie. Poi certo, fuori dell'arte, nella vita vera, le cose vanno diversamente.
Approfondimenti radiofonici
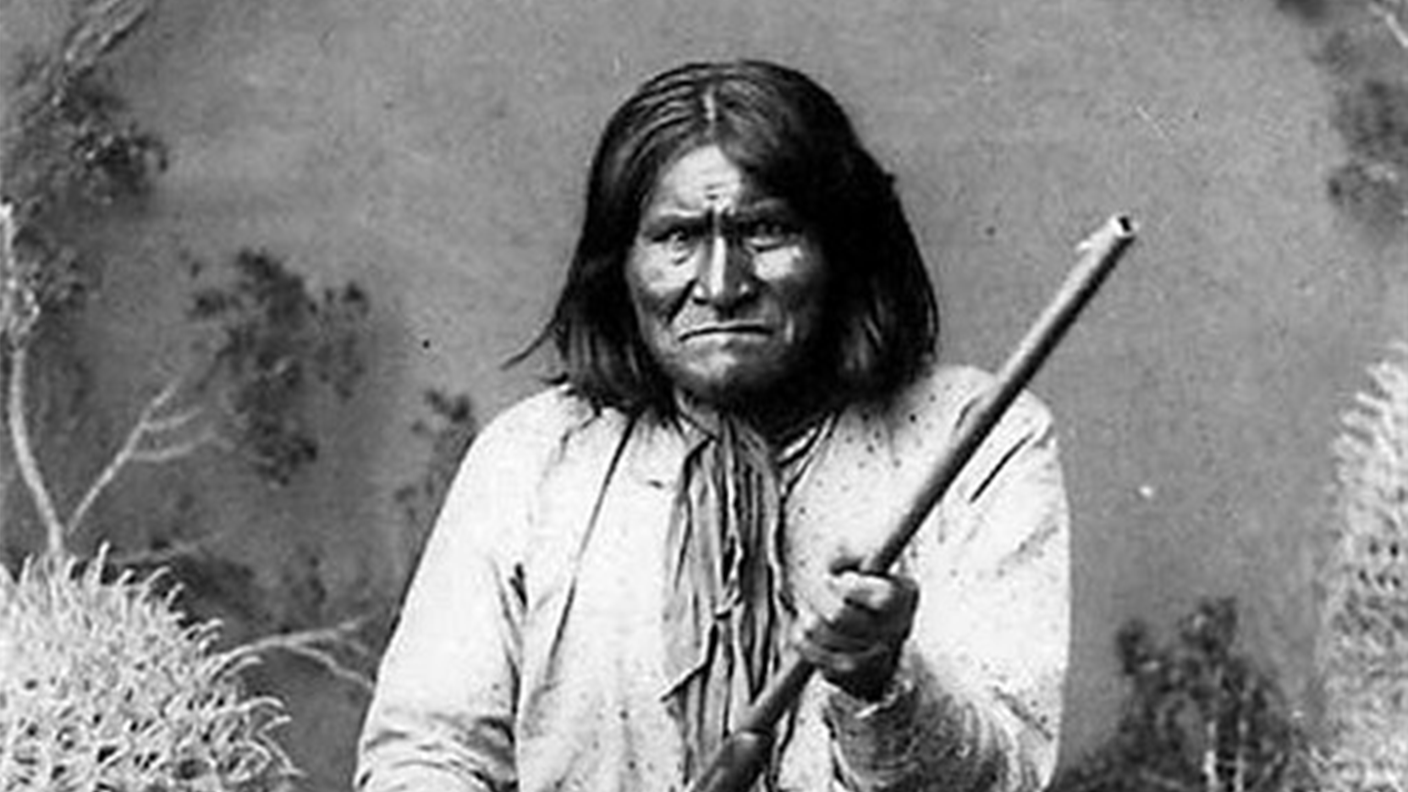
Contenuto audio
Artemisia Gentileschi. Storia di una passione - Geronimo 06.10.2011
Geronimo 06.10.2011, 02:00
Le donne dell'Arte
Millevoci 05.12.2011, 12:10











