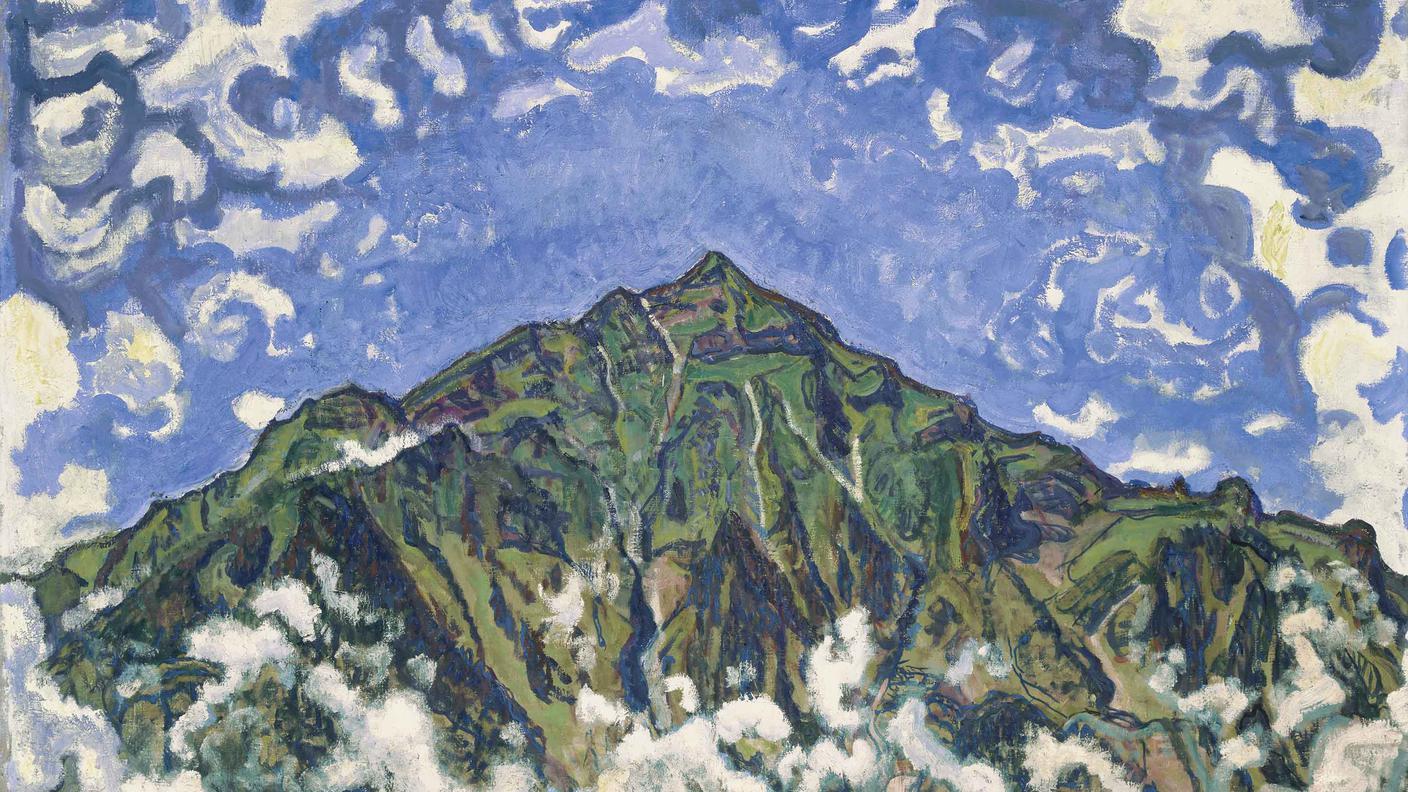Tra i più audaci e innovativi pittori del Rinascimento veneto, Tintoretto tuttora respira e vive tra le chiese e i palazzi della Serenissima attraverso le sue magnifiche opere. Sono oltre trenta i luoghi, soprattutto ecclesiastici, che conservano i suoi dipinti nella loro collocazione originaria, tanto che si potrebbe parlare della stessa città lagunare come di una grande mostra diffusa e permanente del pittore.
Autoritratto, 1546 - 1547
Testimonianze dell’epoca ci dicono che Tintoretto, al secolo Jacopo Robusti, morì a Venezia il 31 maggio 1594 all’età di 75 anni, è ipotizzabile quindi che egli vi sia nato intorno al 1518-1519. Figlio di un tintore di stoffe (da qui il peculiare soprannome), Tintoretto ebbe una lunga e prolifica carriera e fu uno dei figli più cari e devoti che la Serenissima abbia mai avuto.
Artista tra i più rappresentativi della sua epoca, fu anche, per certi versi, fuori dal suo tempo, come osservava il suo contemporaneo Vasari:
Nelle cose della pittura stravagante, capriccioso, presto e risoluto et il più terribile cervello che abbia avuto mai la pittura, come si può vedere in tutte le sue opere e ne’ componimenti delle storie, fantastiche e fatte da lui diversamente e fuori dell’uso degl’altri pittori
.
Differenziarsi dagli altri, fare di più e meglio degli artisti del suo tempo era ciò a cui Tintoretto aspirava costantemente. La sua pittura era frutto di un pensiero moderno, di un fare frenetico, di uno spirito ardito.
Tintoretto
Voci dipinte 30.12.2018, 10:35
Contenuto audio
Mai sono stato così totalmente schiacciato a terra dinanzi a un intelletto umano, quanto oggi davanti a Tintoretto..., scriveva nel 1845 il pittore e critico d’arte britannico John Ruskin in una lettera al padre, dopo aver visitato la Scuola Grande di San Rocco. Quanto alla pittura, penso di non aver saputo che cosa significasse fino a oggi – quello ti delinea la tua [sic] figura con dieci tratti e la colora con altrettanti. Non credo che gli servissero più di dieci minuti per inventare e dipingere una figura intera. Prende il via e accumula schiere su schiere, moltitudini che nessuno riesce a contare – senza mai fermarsi, senza mai ripetersi – nuvole e vortici e fuoco e infinità di terra e mare, per lui niente fa differenza.
Il ciclo di teleri della Scuola Grande di San Rocco è, in effetti, fra i più alti esiti della produzione tintorettiana. Il pittore vi lavorò per più di vent’anni (dal 1564 al 1588 circa), creando oltre sessanta episodi dell’Antico e del Nuovo Testamento. Un lavoro di una complessità e di una unitarietà tali da essere spesso considerato per Venezia al pari di ciò che la Cappella Sistina è per Roma. Ma accanto a questo capolavoro, sono innumerevoli le opere che testimoniano il talento visionario e non convenzionale di Jacopo Robusti: dalla sua prima opera matura, il Miracolo dello schiavo, che lo consacrò sulla scena veneziana, a celebri lavori come Susanna e i Vecchioni e il Ritrovamento del corpo di San Marco, fino al magistrale Paradiso, gigantesca composizione eseguita per la prestigiosa Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale, coronamento della sua carriera.
Miracolo dello schiavo, 1548
Ricca e dinamica, Venezia nel Cinquecento era una delle capitali della cultura rinascimentale e non si poteva certo dire povera di artisti encomiabili. Vi operavano, per esempio, il grande Tiziano, presso il quale il giovane Tintoretto andò a bottega per un breve periodo, e poi Paolo Caliari, detto il Veronese. Eppure, Tintoretto seppe distinguersi da tutti quanti, mostrando un genio personalissimo e incontenibile.
Mi sembrò di essermi spinto all’estremo limite della pittura, che al di là di questo iniziasse un’arte nuova, una poesia ispirata e che Bellini, Veronese, Giorgione e Tiziano, tenendosi l’un l’altro per mano e tendendo ogni fibra del loro genio, non fossero riusciti a raggiungere quel limite, ma avessero lasciato uno spazio visibile in cui il solo Tintoretto signoreggiava. […] Tiziano fu sicuramente un poeta vigoroso, ma Tintoretto, bene, Tintoretto fu quasi un profeta, commentava l’erudito scrittore statunitense Henry James nell’Ottocento.
Già, ma cosa rendeva l’arte di Tintoretto così diversa, sconvolgente, spesso inquieta? Un insieme di elementi: la pennellata sferzante, la volontà di sfidare la tradizione consolidata ricorrendo ad originali soluzioni tecniche e stilistiche, le sperimentazioni iconografiche, la spiccata abilità narrativa, l’utilizzo sapiente dell’intera gamma dei pigmenti disponibili nella Venezia del tempo, e poi la bravura nel destreggiarsi tra i diversi generi, da quelli religiosi ai grandi dipinti di storia, dai temi profani e mitologici fino alla ritrattistica (splendidi gli autoritratti).
Non bisogna poi dimenticare che Tintoretto, oltre a essere un artista ingegnoso, era anche estremamente ambizioso e dotato di un grande intuito per gli affari (offriva prezzi più bassi e accettava tempi di consegna strettissimi), cosa che gli permise di imporsi presto sulla scena veneziana e di ottenere numerose commesse e incarichi pubblici e privati, suscitando così il disappunto dei colleghi, che ne criticavano la rapidità di esecuzione e l’incompiutezza dei lavori. Ma questo a Tintoretto non interessava: il suo fine non era riprodurre la realtà tale e quale, bensì mescolare quotidiano e fantastico, il suo era un estro impaziente tutto spirito, tutto prontezza, come lo definiva il letterato Francesco Sansovino.
Insomma, gli impegni erano così tanti che già alla fine degli anni Settanta del Cinquecento il caparbio pittore veneziano aveva messo in piedi una bottega che funzionava alla stregua di un’azienda a conduzione familiare, avvalendosi dell’aiuto dei figli Marietta, specializzata nei ritratti, e Domenico, che fu il suo migliore assistente e poi successore.
Tutto ciò fa di Jacopo Robusti uno dei più affascinanti protagonisti della pittura rinascimentale. Al suo stile libero, dinamico e carico di energia hanno guardato con ammirazione pittori del calibro di El Greco, Rubens e Velázquez, fino a nomi più recenti come Emilio Vedova che, nato anch’egli a Venezia esattamente 400 anni dopo, si è sempre dichiarato debitore nei suoi confronti. Un modernissimo cinquecentenario: ecco chi è Tintoretto.
Nozze di Bacco e Arianna, 1578