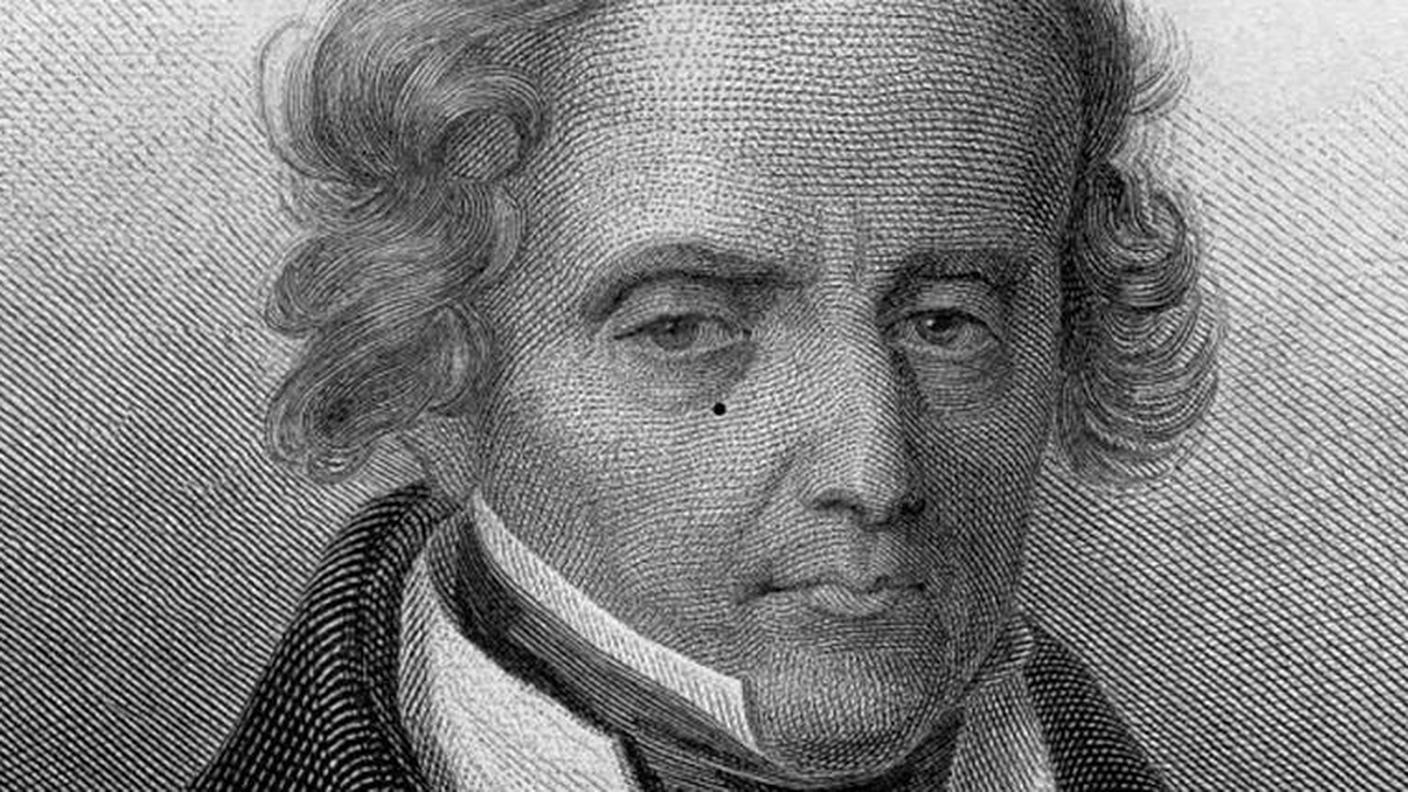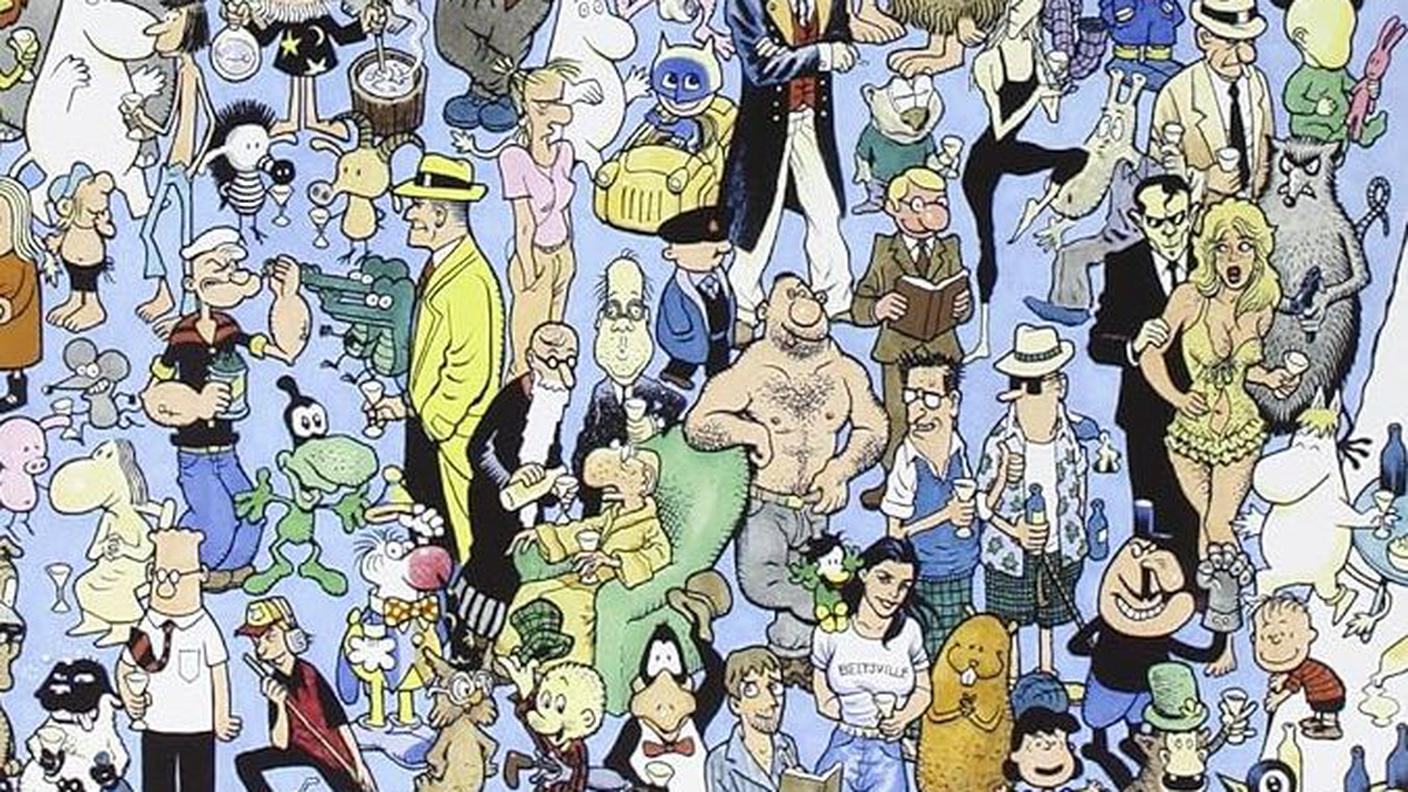Nasce nel 1903 a Taranto, città che abbandona a tredici anni, nel 1918, per avventurarsi tra i dedali e le insidie del mondo. E già questo la dice lunga su un animus, una predisposizione di pensiero e di cuore che probabilmente sono alla radice, ab ovo, la sostanza stessa dell’essere poeta: trarre la parola e il sentimento dalle viscere del mondo.
Imbarcatosi sul Mediterraneo senza altra sapienza delle cose che non sia la sua audace e incosciente volontà di esperirle, raggiunge l’Albania e si improvvisa pastore di armenti: potremmo dire, forzando cristicamente la metafora, pastore di anime, poiché già il suo sguardo è verso l’uomo, il suo enigma e la sua complessità, e probabilmente nulla è altrettanto fecondo, nel riconoscimento dell’umano, quanto aderire al suo mistero dentro il farsi stesso della fatica, del lavoro e dell’elementarità del dovere.
Accudire e portare bestie in questa o quella transumanza, sentirne l’odore, i bisogni, esperire il dolore dell’impegno quotidiano, riconoscersi nella primordialità dell’ossequio alla sussistenza e alla sopravvivenza: ecco a quale sacrificio dovrebbe esporre il poeta una scuola creativa degna di questo nome. Poi le parole, certo, la metrica e la cultura, ma prima di tutto l’ineffabile santità del concime, del sudore e della precarietà.
E dell’eroismo esistenziale, e del demone dell’erranza. Poiché laddove non esiste deambulazione per la terra o lungo le terre del mondo, laddove non si offre viaggio nella lingua che non sia all’origine o per eterogenesi viaggio nella materia, nel tempo e nella Storia, laddove in una parola
non sia sporcata di vita, è fatale che la poesia non risulti se non l’eco di un mondo che non la riguarda, non ci seduce e sostanzialmente finge di essere.
Per cui dall’Albania, sulla scorta di questa etica del nomadismo – che è giocoforza alimento e sangue di ogni poesia rispettabile – l’irrequieto adolescente tarantino si sposta verso l’Italia del nord per aggregarsi alla spedizione fiumana di Gabriele D’Annunzio. E dopo essere rimasto mutilato di una mano – la stessa, arriveremmo a dire, che tanto meglio scrive quanto più viene fisicamente sacrificata sull’altare della poesia – riprende l’erranza e si rimette sulla via del mondo.
E così lo troviamo a Palermo, dove nel 1923 viene impiegato come gabelliere, poi a Parigi, dove conosce Picasso, le avanguardie e le appassionate avversità della vita bohèmienne. E infine a Milano, dove senza più esitazioni entra a far parte del mondo della critica d’arte e della letteratura sposandosi e mettendo su famiglia. Come chi sa, tuttavia, che se la semina è alle spalle è anche perpetuamente nelle incognite del futuro.
Un tempo ancora da fertilizzare, questo futuro senza orizzonti, che sollecita in lui, oltre a molti testi critici sull’arte, quella che per dieci anni diventa la sua attività principale: la stesura di racconti e romanzi. Ma chi li scrive? Forse solo l’Errante, il Fuggitivo, l’Esiliato? O piuttosto il Poeta? Nell’individuare in sé, come risultanti di una vita assurta a semina, i germi della poesia come rispecchiamento dell’essenza e dell’essenziale, nel nostro giramondo si impone infine la consapevolezza che egli narratore non è ma, appunto e a tutto tondo, poeta.
Così, nel 1945, ecco la sua prima importante raccolta di versi:
Il lamento del gabelliere. E di lì in avanti un crescendo di pubblicazioni che cadenza gli anni fino a
Stellacuore del 1974 e oltre. Anni in cui si fa palese il fatto – come rileva Salvatore Ritrovato – che “la poesia non appartiene a una scuola o a una corrente, ma
è”.
E che cos’è allora, per riprendere il nostro titolo, un poeta? Nel panorama editoriale di oggi, si direbbe uno le cui fortuite cogitazioni in versi hanno trovato un improbabile ascolto dentro la minuscola nicchia degli orfani del Novecento. Ma nel quadro di quello che Rilke ci esortava a riconoscere come un impegno che “investe un’intera esistenza”, probabilmente, è in primo luogo e fondamentalmente colui che ha forgiato la parola nella vita.
E il nostro vagabondo, il nostro Raffaele Carrieri – già, è questo il dimenticato nome del formidabile bardo di Taranto – tale opera di “metallurgia dello spirito” l’ha compiuta per tutto il decorso della sua esistenza, arrivando a scrivere, sotto l’influenza di poeti come Scotellaro e Sinisgalli, ma di fatto nel quadro di una lirica internazionale senza epigoni né modelli coartanti, versi della più persuasiva autenticità, la cui eco si è ormai persa nel dimenticatoio ma che qui vorremmo richiamare con una delle sue incantevoli, leggere e profonde, popolari ed elettive composizioni del cuore:
Le notti che mi manca il fiato
Chiamo, chiamo con la mano
Fuori dal lenzuolo
Quei pochi che amo.
Non rispondono:
Sono in un altro sonno,
In un altro vuoto
E non mi riconoscono.