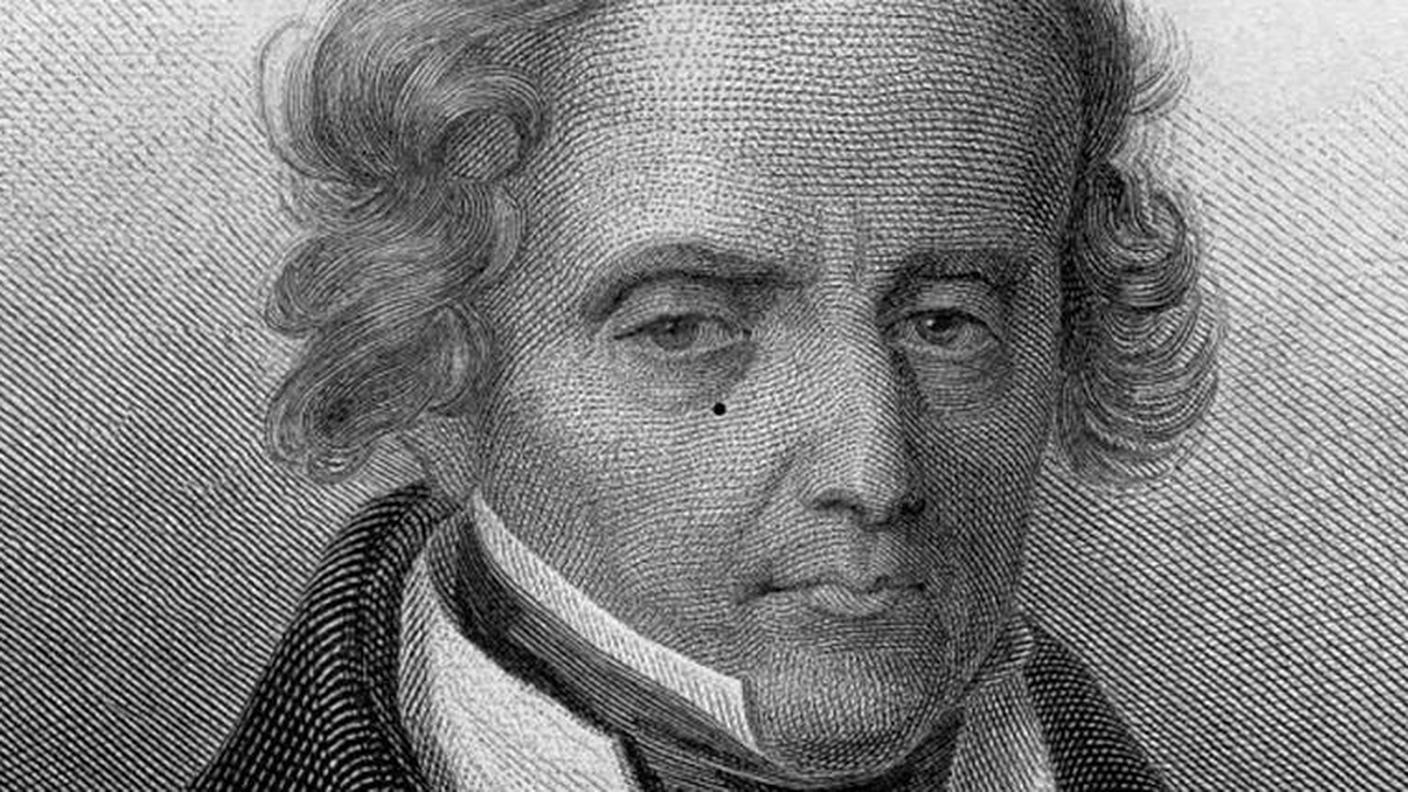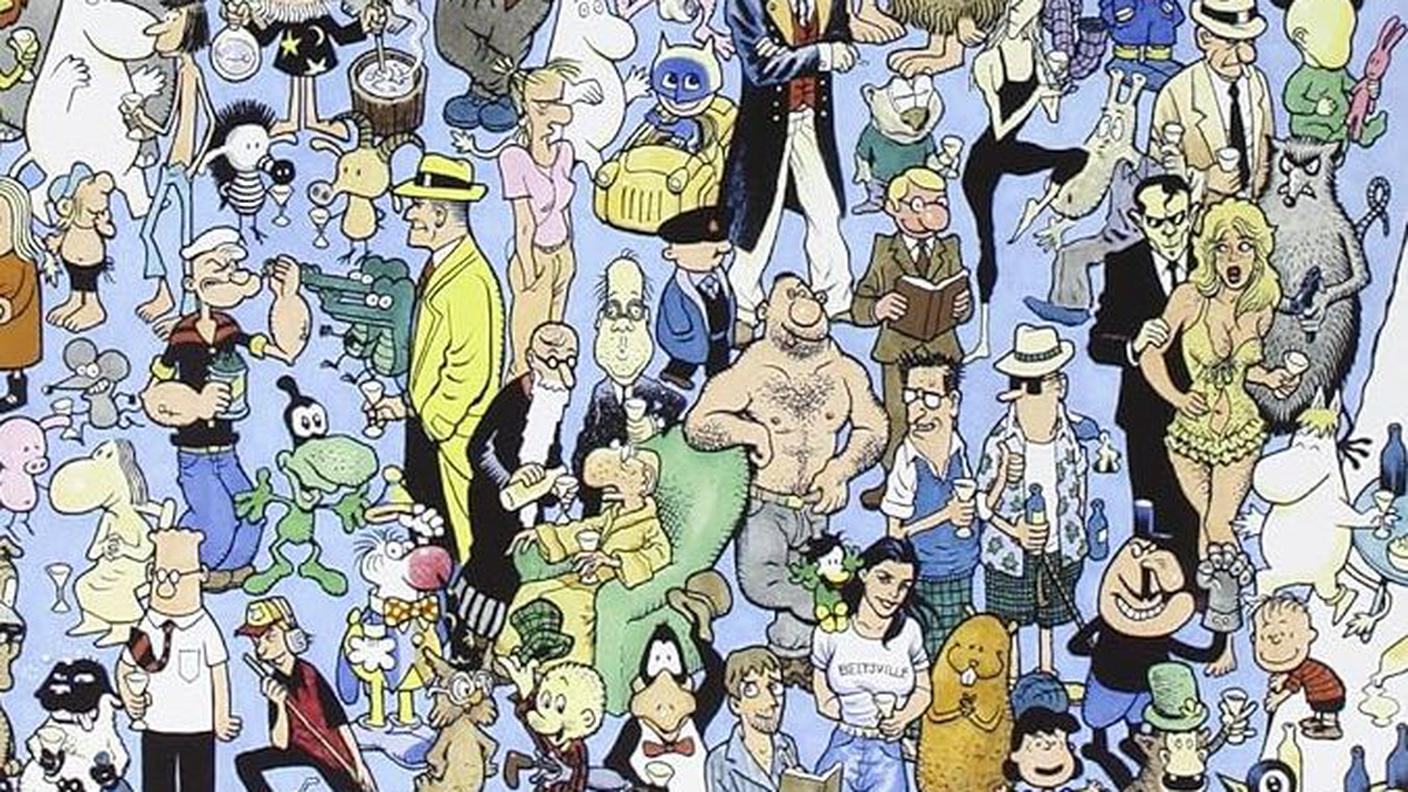Per vedere il “mondo” non è affatto necessario sobbarcarsi la fatica dei viaggi e l’incomodo degli spostamenti, perché la sua “realtà” più autentica è tutta contenuta nella fantasia, nei trasporti emotivi e nell’immaginazione. Lo ha detto un grande scrittore stanziale come Friedrich Dürrenmatt, che aveva eletto a programma di vita e principio poetico la pigrizia (nel senso più nobile del termine), la scelta di un endroit écarté – il Vallon de l’Ermitage, nei pressi di Neuchâtel – e l’osservazione dalla distanza, come ad esempio nello straordinario Ritratto di un pianeta, per citare un esempio tra i tanti.
Friedrich Dürrenmatt, ateo e protestante
Segni dei tempi 22.05.2021, 12:05
Lo stesso Dürrenmatt, a sostegno di questa tesi, era solito ricordare nientemeno che la Divina Commedia, aggiungendo che Dante non era mai stato all’Inferno, eppure lo aveva descritto nei minimi particolari. L’autentico viaggio di scoperta e conoscenza consisterebbe quindi nella stanzialità quale presupposto della reinvenzione/creazione del mondo: un paradosso, senza dubbio, ma ricco di implicazioni. Un altro grande stanziale – e non meno grande scrittore – come Ennio Flaiano, che da parte sua considerava il “tempo perso” quale autentico metronomo dell’esistenza (perché il “tempo perso” libera dal gravame delle illusioni, sospende l’eterna corsa dietro il vento e fa capire che la vita, nella sua più intima essenza, non va da nessuna parte), si era spinto perfino oltre.
Ha scritto infatti in una nota dell’autunno 1958, contenuta nel Diario degli errori: «Dopo ogni viaggio, in cui mi sono illuso di interessarmi di qualcosa, di capire, di arricchirmi, mi accorgo che sono affondato di un altro centimetro nelle sabbie mobili. Non bisogna muoversi». Un altro indubbio paradosso, non meno ricco di implicazioni. Urs Widmer, indimenticato scrittore basilese scomparso nel 2014, diceva invece che si viaggia in contrade anche lontanissime con l’unico scopo di vedere che facce hanno quelli che vivono in quelle contrade e non viaggiano. Il che va perfino oltre il paradosso, ma esprime una sostanziale verità.
Meritano inoltre di essere ricordate alcune considerazioni svolte dal compianto Gianni Celati – che a differenza di Dürrenmatt e Flaiano era uno scrittore che traeva spesso ispirazione dal viaggio (aveva perfino elaborato una personalissima poetica fondata sulla “scrittura in esposizione”) – in un passo particolarmente significativo di Verso la foce, resoconto di lunghe peregrinazioni nella Pianura Padana e sul Delta del Po. Il viaggio nello spazio esterno e nella pura esteriorità, secondo Celati, ha il merito di sgonfiare la bolla dell’io e di emendare molte illusioni, non ultima quella consistente nella pretesa di aver capito qualcosa in generale.
E’ quanto accade, ad esempio, nella zona tra Ferrara e il Delta, quando il viaggiatore si imbatte in località sconosciute e dai nomi stranissimi (Consandolo, Traghetto, Ospedale, Molinella), che gli ispirano la seguente riflessione: «Mi stupisco che questi paesi siano tanto grandi, che ci siano tante case e tante strade e industrie e abitanti. Ma quanti posti del genere ci sono dappertutto, di cui ben pochi hanno sentito parlare. Nomi strani, l’idea di un piccolo stanziamento, e poi sempre luoghi complessi che ci vorrebbero mesi per conoscere un po’. Ogni volta è una sorpresa, scopri di non saper niente di preciso sul mondo esterno. Allora viene anche la voglia di scusarsi con tutti: scusate la nostra presunzione, scusate i nostri discorsi, scusateci di aver creduto che voi siate un pugno di mosche su cui sputare le nostre sentenze. Scusate, scusate, noi siamo inetti e smemorati, e neanche tanto furbi da restare a casa, non muoversi, tacere, fare come gli alberi». In questo caso, il paradosso viene appena sfiorato e si limita (forse) alle conclusioni, ma il passo nel suo insieme esprime una profonda verità sulla quale verrebbe la pena di riflettere nella società della comunicazione, dove troppo spesso si “giudica e manda” senza conoscere, senza sapere, senza nemmeno supporre.

ControLuce - Gianni Celati
RSI ControLuce 26.04.2009, 09:27
Comunque sia, dall’Odissea in poi, ci sono parecchi modi di interpretare il viaggio nella sua dimensione reale e metaforica: quale conferma che la bêtise, la stupidità, è davvero dappertutto e non risparmia nessuno, come sosteneva ad esempio il giovane e già disincantato Flaubert, oppure quale utopica quanto dubitosa ricerca del “noto” nell’“ignoto”, come dicono i celeberrimi versi di una poesia di Baudelaire. Ci sono anche il viaggio nel senso classico, vissuto da Goethe in Italia come “ritrovamento” di quanto si è già “trovato” nella fantasia e nell’immaginazione (la cosiddetta “terza realtà”), oppure nel senso romantico, come continuo ritorno “a casa” (verso il leggendario “fiore azzurro” favoleggiato da Novalis nell’Enrico di Ofterdingen), in un radicamento che in linea di principio potrebbe e dovrebbe essere ovunque.
«Dove andiamo?», si chiedeva infatti il viaggiatore di Novalis. La risposta era sempre la stessa: «Verso casa». E’ precisamente quanto pensava il viaggiatore (reale e immaginario) per eccellenza, Dante Alighieri: soltanto se si ama e reinventa Firenze, la “piccola patria”, ci si può sentire di casa nel vasto mondo come i pesci nel mare. Perché nel viaggio, diceva Carlo Levi, viaggiatore curioso e attentissimo in terre vicine e lontane, è presente «una frattura che è sempre una fuga, un’inconsapevole ricerca, uno scampo, un abbandono». Il movimento nello spazio produrrebbe insomma uno sfalsamento prospettico e un differimento cronologico: forse non viaggia veramente chi viaggia, ma piuttosto coloro che restano e «viaggiano all’indietro nel tempo immobile». Un altro indiscutibile paradosso, perfino più ricco di conseguenze rispetto alle considerazioni svolte da Dürrenmatt e Flaiano.
Quest’ultimo paradosso trova peraltro una giustificazione nel resoconto di un “viaggio” che oggi più che mai, in un’epoca di Overtourism e All inclusive (le «migrazioni stagionali di popoli», secondo le velenose parole del già ricordato Dürrenmatt), ci parla da una vicinissima e per molti versi vibrante lontananza: il Viaggio intorno alla mia stanza (con l’aggiunta della Spedizione notturna intorno alla mia stanza) di Xavier De Maistre. Nato a Chambéry in Savoia (che allora faceva parte del Regno di Sardegna) nel 1763, Xavier De Maistre è morto a San Pietroburgo nel 1852. Militare sabaudo, pittore e scrittore (sono noti anche i Racconti russi, pubblicati nel 1825), era il fratello minore del filosofo e diplomatico Joseph De Maistre. La prima parte del “viaggio”, scritta tra il 1790 e il 1794, venne pubblicata nel 1795, mentre la seconda, iniziata nel 1799 e portata a termine nel 1823, uscì in volume nel 1825.
La prima parte è la più celebre, tanto che spesso viene pubblicata senza l’aggiunta della Spedizione notturna, ma la seconda parte, se mai possibile, è ancora più bella, perché le riflessioni “notturne” del saturnino De Maistre, che ruotano intorno all’essenza del tempo e alla sua percezione, colgono e prefigurano i dubbi e i vuoti di senso che hanno poi trovato piena cittadinanza nella sensibilità novecentesca. Il Viaggio intorno alla mia stanza è un libro quasi leggendario, variamente e vanamente imitato, amatissimo dal “gran bugiardo” Stendhal e in seguito da Hugo, Nietzsche, Proust e molti altri. Tra i lettori d’eccezione, il diritto di primogenitura – se così lo si può definire – spetta tuttavia a Giacomo Leopardi, che aveva individuato nelle pagine del “viaggio mentale” di De Maistre la concreta applicazione del famoso principio teorizzato nello Zibaldone: nulla si sa e tutto si immagina, le proiezioni immaginative sono l’unica fonte della felicità umana. Non deve quindi stupire che la prima traduzione italiana della Spedizione notturna, apparsa nel 1832, sia opera di Paolina, sorella di Giacomo.
Chi più, chi meno, siamo tutti figli della tristezza, del dolore e della sofferenza, come dice una delle più belle e commoventi canzoni di Nick Cave, Sorrow’s Child, del 1990: «La figlia del dolore ti invita ad andare a fondo / e quando pensi quasi / di aver pianto tutte le lacrime che potevi piangere / la figlia del dolore si dispiace non per le cose passate / ma per tutto il passato che deve ancora venire. / E quando ti sembra quasi / che le tue lacrime stiano per finire / la figlia del dolore alza la mano / e poi ti trascina nuovamente a fondo». Perché il viaggio nel “mondo”, o comunque lo si voglia definire, fatto di proustiane intermittenze del cuore, è sempre negazione, sottrazione, tempo che passiamo ma soprattutto tempo che ci passa, ci trasforma e deforma. Il “mondo”, insomma, è “morte”, nelle sue varie forme e declinazioni.
La regola secondo la quale i grandi libri nascono dalla reinvenzione di grandi sofferenze trova conferma anche nel “viaggio mentale” e “immobile” di De Maistre. Nel 1790, infatti, mentre prestava servizio a Torino nell’esercito piemontese, il giovane savoiardo e soldato di carriera Xavier, allora ventisettenne, venne punito perché aveva preso parte a un duello e fu costretto a una permanenza di quarantadue giorni agli arresti domiciliari, in una stanza della fortezza dove alloggiava. I giorni di segregazione corrispondono ai capitoli del “viaggio”, che raccontano la clausura forzata attraverso l’originalissima e spiazzante prospettiva del viaggio mentale e immaginario: lo spazio ristretto della stanza e gli oggetti, anche i più banali, forniscono infatti uno stimolo alla fantasia, che si muove nello spazio e nel tempo e scopre dimensioni impensate.
Ma c’è dell’altro, che rende il viaggio del giovane Xavier ancora più attuale: la tragedia vira in commedia, al punto che è impossibile scindere i due ambiti. Le premesse sono drammatiche (la pena e la detenzione), ma gli esiti sono spesso di una gustosa e penetrante ironia che sfocia infine nell’umorismo e nella satira, soprattutto quando Xavier, con un atteggiamento decisamente canaille, smonta pezzo per pezzo il mito del Grand Tour, allora molto in voga. Sembra quasi che il giovane segregato, alla fine del suo primo “viaggio mentale”, si rivolga direttamente a noi “venuti dopo” e ci dica: «Andarsene, viaggiare, fuggire, ma dove? Non è tutta una grande galera, qui dentro e là fuori?». La domanda trova una risposta nel secondo viaggio immaginario, coi sensi acuiti e resi più vigili dal buio della notte, che trasformano il viaggio stesso in una spedizione vertiginosa – e davvero molto leopardiana – negli abissi del tempo e nella vanità delle cose.
Molto leopardiana, la spedizione notturna di De Maistre, ma anche molto vicina alla descrizione contenuta nel racconto La strana compagnia nella notte di San Silvestro (1800) dello scrittore tedesco Jean Paul (pseudonimo letterario di Johann Paul Richter), al punto che si potrebbe perfino parlare di un’affinità elettiva. L’io narrante del racconto, infatti, allo scoccare della mezzanotte del 31 dicembre 1799, che segna il passaggio da un anno a un altro ma soprattutto da un secolo a un altro, ha una visione e si vede scorrere davanti «tutto ciò per cui l’uomo definisce la vita vana e futile»: «In rapida successione, passarono i secoli a venire, quindi giunsero lunghi millenni che sospingevano un popolo dopo l’altro dalle città alle tombe; le generazioni si susseguivano come rapidi scrosci di pioggia e si gettavano nei sepolcri e laceravano il cielo, attraverso i mondi, dove non si vedeva nessun morente, ma soltanto il morire».
In maniera non molto dissimile, allo scoccare della mezzanotte, riflettendo sul passato e sul futuro, De Maistre si abbandona alle seguenti riflessioni: «Sono due nulla, tra i quali mi trovo in equilibrio come sul filo di una lama. In verità, il tempo mi sembra qualcosa di talmente inconcepibile che sarei tentato di credere che non esista veramente, e che ciò che chiamiamo così non sia altro che un castigo del pensiero». Le generazioni umane gli appaiono come immense onde che si infrangono, l’una dopo l’altra, «sulla riva dell’eternità». Ma non solo, perché nell’animale-uomo si cela da sempre un irredimibile cuore di tenebra: «Le nazioni in massa si sgozzano con slancio, anticipando il termine prefissato dalla natura; i conquistatori, trascinati a loro volta dal rapido vortice del tempo, si divertono a falcidiare migliaia di uomini».
«Oh, Tempo! Divinità terribile! Non è la tua falce crudele a spaventarmi, temo soltanto i tuoi orrendi figli, l’Indifferenza e l’Oblio, che trasformano in una lunga morte tre quarti della nostra esistenza». Lucidissimo e profetico, Xavier De Maestre, attualissimo nella sua inattualità: non è necessario scendere al fondo dell’ignoto per trovare il noto, perché il “mondo” può anche essere in una stanza, dove il noto si può rivelare ignoto, ma anche (e soprattutto) l’ignoto si può rivelare tristemente noto e prevedibile. Ecco perché al povero Xavier – e a noi con lui, due secoli dopo – non resta che ripetere ai “conquistatori”, per l’ennesima volta e con sempre minore convinzione: «Ehi, signori miei, che avete in testa? Non vedete l’ora che avanza? Già si infrange sulla riva… Aspettate ancora un istante e voi, i vostri nemici, io e le margherite, tutto finirà! Ci si potrà mai stupire abbastanza di una simile idiozia?».