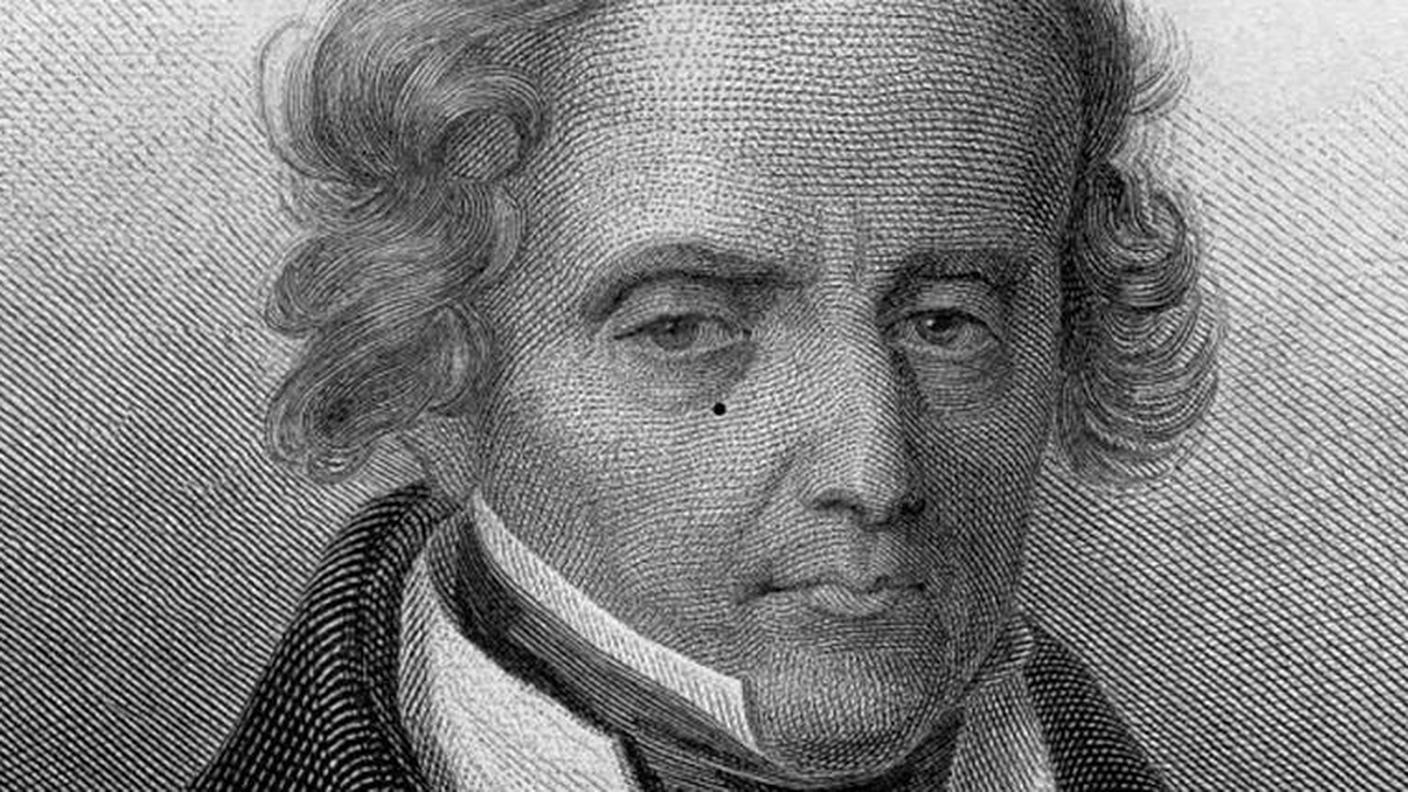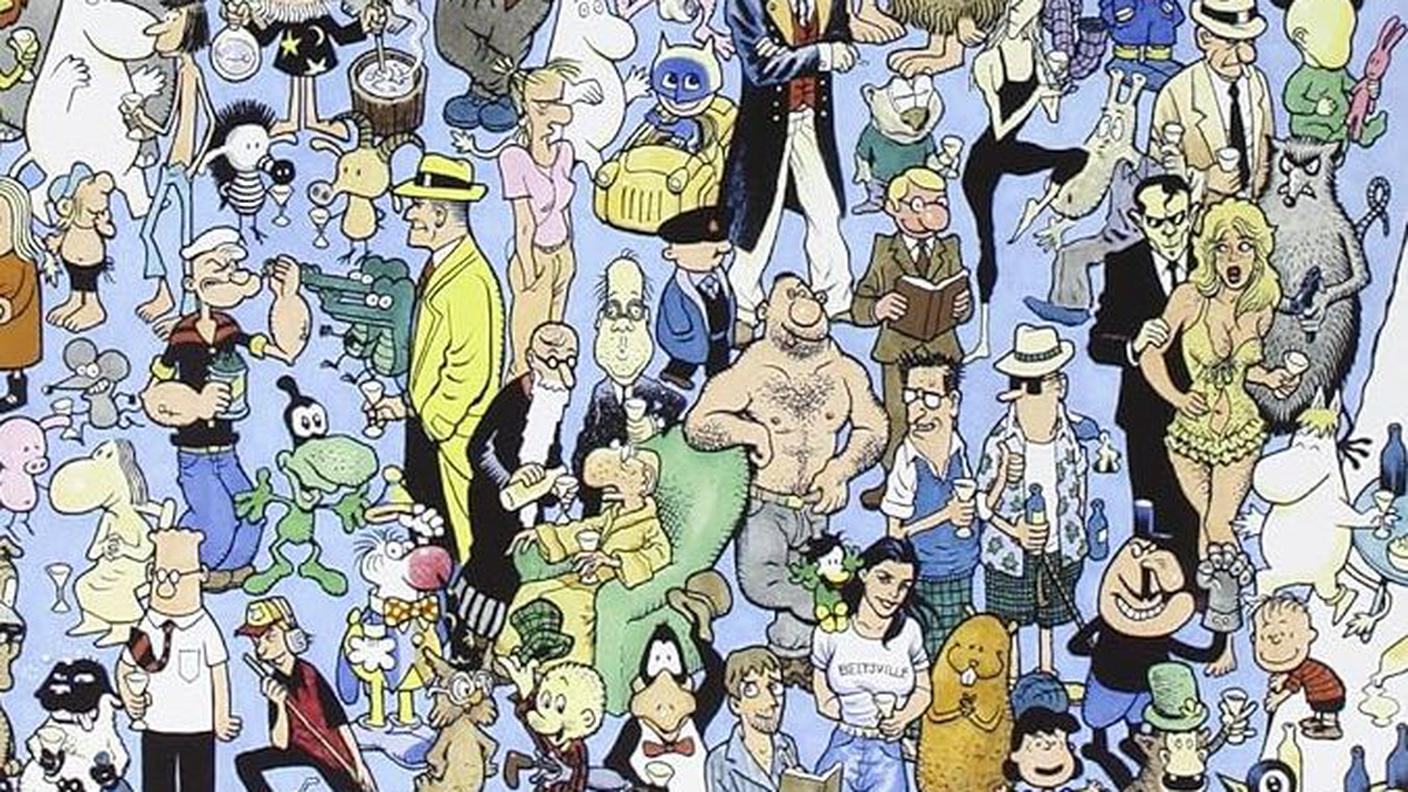Edith Bruck parla con voce tremolante e perentoria, la sua vita ha conosciuto il benessere e la miseria, la morte e la cura, l’emigrazione e il radicamento, il popolo e l’universo degli intellettuali. C’è una grossa fetta del Novecento in questa donna che non cede di fronte all’istinto naturale di dimenticare ciò che urta e provoca dolore, perché raccontare è il solo modo che abbiamo di tenere vive le memorie, di onorare coloro che sono morti senza colpa.
Massimo Recalcati, nel Volume “Il complesso di Telemaco” suggerisce che il maestro è colui che porta testimonianza della passione e del sapere, perché ciò che conta non può essere inculcato, deve essere vivo in chi incarna i valori di cui si fa portatore. È questo ciò che succede quando si ascoltano le parole e quando si osserva la stoica ostinazione di Edith Bruck. La scrittrice di origini ungheresi e da molto tempo italiana ci conduce con i suoi racconti lungo i binari della deportazione nazista, nei campi di concentramento, a stretto contatto con le particelle di bene che resistono alla sistematica e scientifica pianificazione di uno dei mali più roboanti della storia.
Edith Bruck, in questa intervista concessa a Cliché, offre agli ascoltatori buona parte del suo vissuto, in un distillato di parole che si imprime nella memoria. (Tommaso Soldini)
INTERVISTA a Edith Bruck
RSI New Articles 28.03.2023, 11:15
Non è una questione di chiaroscuro, ma molto di più. Perché anche nella notte più buia e disumana si possono intravedere quelle piccole briciole di luce che dal nulla possono tirar fuori una speranza che poi diventa salvezza: un gesto, la domanda di un nome, un regalo inaspettato. Del resto, l’importanza di un sopravvivere è qualcosa che metti a fuoco in quel “subito dopo” in grado di arrivare dopo l’esperienza di un lager. Ma sopravvivere vuol dire soprattutto poter raccontare. Edith Bruck lo dice con quella semplicità che disarma: “perché la carta sopporta tutto”. Ed è partita proprio da lì, dalla capacità di resistenza di un supporto esterno, quella volontà che ancora oggi anima la scrittrice italo-ungherese. Usare le parole per portare testimonianza di tutto quello che ha vissuto. È l’urgenza che incontra la letteratura. Non il diario di una semplice traiettoria individuale, ma qualcosa che si allarga e riguarda tutti perché segna il punto in cui un’intera umanità si è inabissata.
Oggi Edith Bruck ha 92 anni. È entrata in un campo di concentramento a 13. A 14 è fuggita e, fuggendo, è riuscita a condividere un pezzo di pane con dei soldati fascisti dispersi, quelli che fino a poche ore prima potevano essere i suoi carcerieri o gli assassini dei suoi genitori. L’inferno non ha ancora abbassato le fiamme, ma fin da subito recuperare la dignità umana vuol dire non sprofondare nell’odio. “L’unica cosa che odio è la parola odio” racconta ancora Edith Bruck, anche se questo rifiuto della scorciatoia della vendetta non porta ad alcuna redenzione, perché il peso della condanna rimane sempre lì, sulle sue spalle. È quel “tu devi” per cui vacilli se un altro grande testimone come Primo Levi sceglie all’improvviso di spegnere la luce. Del resto, vorresti anche smettere di raccontare, ma sai già che se per caso lo facessi, staresti molto peggio. “Io sono la signora Auschwitz” è perentoria l’autodefinizione della stessa Bruck “perché quando vivi quell’esperienza sulla tua pelle, è come se di Auschwitz fossi rimasta incinta”. (Lorenzo Buccella)