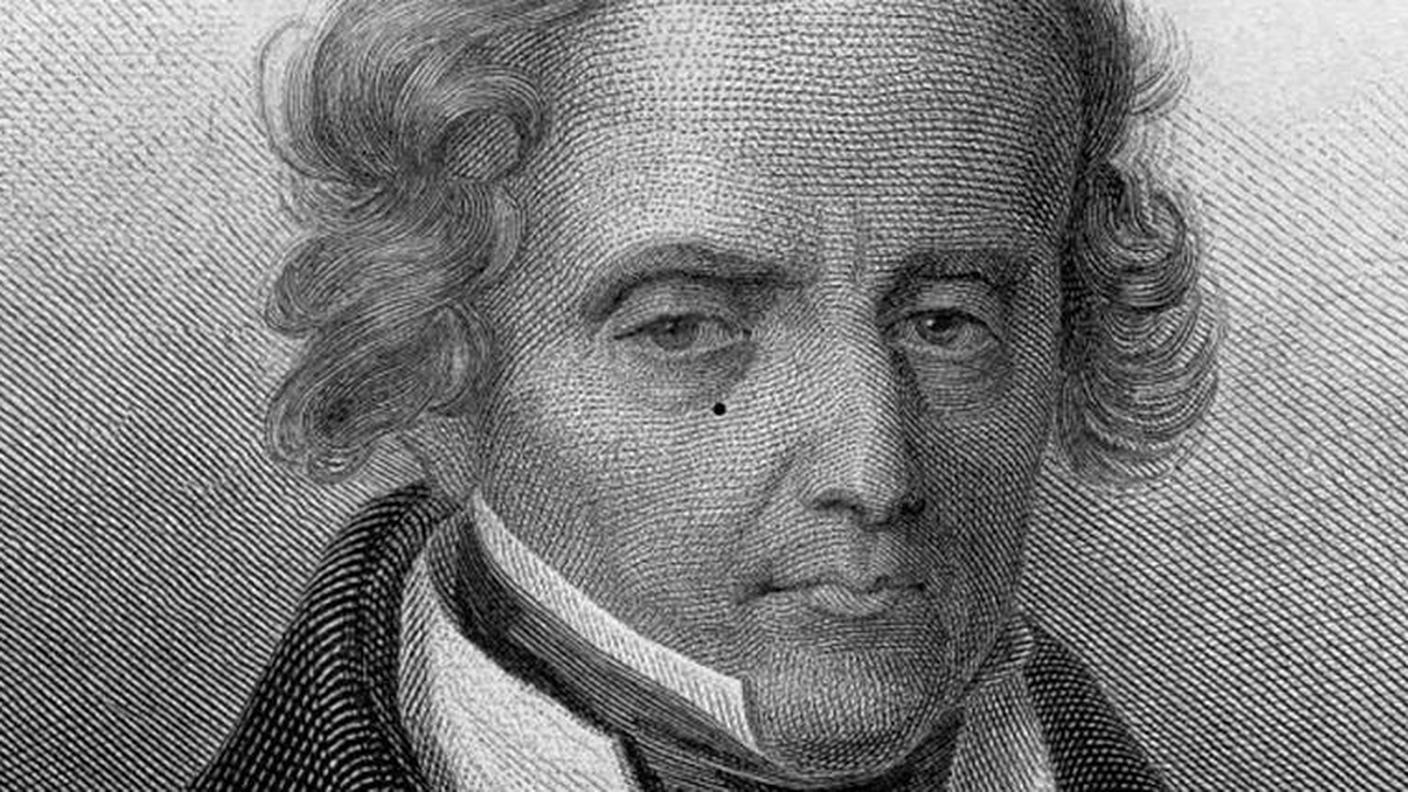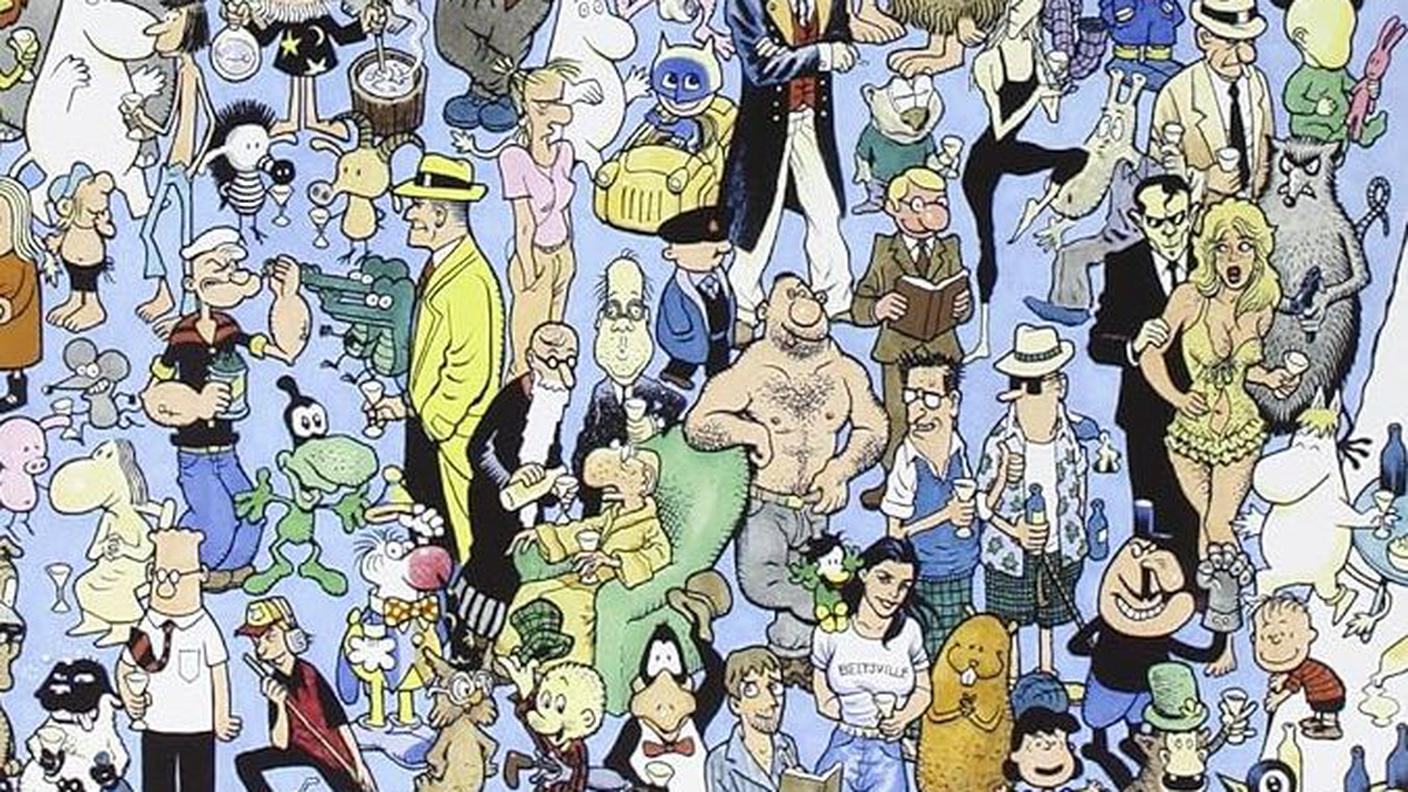Il romanzo più famoso dello scrittore svizzero Robert Walser è sicuramente I fratelli Tanner. Ma il romanzo più “walseriano” è probabilmente quello che ritengo uno dei grandi capolavori del Novecento: Jacob von Gunten. Un titolo che già nella sua natura anonima (quasi a indicare l’insignificanza di qualsiasi essere umano) ci racconta l’intenzione di Walser: riportare l’uomo alla misura della sua piccolezza e del suo inesorabile anonimato.
Certo, un approccio meno esatto al libro avrebbe potuto imporre al romanzo un titolo più emblematico: Istituto Benjamenta. Perché di tale istituto infine si tratta, e delle vicende paradossali, quasi tragicomiche, che vi si svolgono. Ma appunto non era questo l’intento di Walser: egli non voleva annunciare un luogo, per quanto emblematico (come emblematici furono il Castello di Kafka e il Palazzo dei sogni di Kadaré) bensì un uomo. O, per meglio dire, l’uomo per come Walser lo raffigura e lo anonimizza riducendolo allo stato di servitore.
All’Istituto Benjamenta, in effetti, gli alunni – quelli che il protagonista Jakob von Gunten chiama “condiscepoli” – non vengono formati a questo o quel sapere (al contrario, l’idea stessa di un apprendimento canonico sembra bandita): il suo scopo recondito, non meno tragico che grottesco, è quello di allevare dei perfetti subordinati, pronti a calarsi nel mondo nelle vesti di sottoposti o addirittura di schiavi. E l’unico vero dovere che incombe su di essi è quello di ottemperare alle regole (“conformemente al regolamento”) per adeguarsi alla loro inviolabile supremazia.
Così ecco che i concetti tradizionali a cui siamo abituati legare i personaggi dei cosiddetti “romanzi di formazione” vengono ribaltati: l’eroe non è tale perché si impone, si afferma, vince o trionfa (poco importa, infine, se contro i mulini a vento , come in Cervantes, contro l’occupazione nazi-fascista, come in Fenoglio, o contro l’alienazione come in Orwell), ma perché si sottomette, si piega, si prostra, si adatta alla subordinazione. In altre parole, perché, invece di perseguire qualche “altitudine”, qualche “grandezza”, qualche “superiorità”, qualche “vittoria”, si rassegna ad aspirare alla “bassezza” e alla “schiavitù”.
Scrive per esempio Walser: “Perché, vedi, in alto non vale proprio più la pena di vivere”. O ancora: “Ci si dà chiaramente a intendere che non c’è miglior modo d’istruirsi che la disciplina e le rinunce, che in un esercizio semplicissimo, in certo modo stupido, c’è maggior beneficio, più veritiere nozioni che non nell’apprendimento di una quantità di concetti e di significati”. O ancora: “Ci viene inculcato il principio che niente è più salutare che l’adeguarsi a un ‘poco’ solido e sicuro, cioè appoggiarsi a leggi e comandamenti prescritti da un severo ente a noi esterno. Forse si tende a istupidirci, comunque si vuole che siamo piccoli”.
Leggi e comandamenti prescritti da un severo ente a noi estraneo. In questa espressione –e nel romanzo ne ricorrono a bizzeffe – è forse il tratto più emblematico dell’“etica dell’obbedienza” presentata da Walser. In un certo senso non è anzi né più né meno che la sintesi geniale, tragicamente poetica, di tutto ciò che potremmo intendere per alienazione (non subita, bensì perseguita e quasi agognata).
Documentario-dibattito su Robert Walser
RSI Cultura 18.04.2023, 11:46
Una moltitudine di concetti e figure dell’umano – di questo umano degradato, deliberatamente, volontariamente, a nullità – si dispiegano così da questo romanzo per raccontarci il Contemporaneo. Un Contemporaneo che senza essere mai pronunciato potrebbe di volta in volta indicare il Potere (l’autoritarismo novecentesco, senza altra legittimazione che in se stesso), la Svizzera (paese per eccellenza della regolamentazione e del legalismo), la Sopraffazione (nel sadico compiacimento delle istituzioni a indurre i propri sudditi al masochismo) e via elencando. Insomma, come tutti i grandi romanzi, anche Jakob von Gunten non esaurisce il proprio messaggio nell’evidenza dei suoi accadimenti, ma ci porta a distanze e ad altezze ulteriori. Per esempio, sottoponendoci una domanda cruciale: Siamo sicuri che primeggiare sia la nostra vera aspirazione, siamo sicuri che l’uomo non è per sua natura vocato, o vocato anche, alla sottomissione?
Walser non offre risposte rassicuranti. Ma certo ci invita a porci le domande più scomode e a partecipare delle vicende di Jakob von Gunten come se, prima di ogni altra cosa, dovesse essere messo in discussione il nostro repertorio di certezze. Prime tra tutte: la certezza di essere al mondo per dominare e non per essere dominati, la certezza che in questa dicotomia sia il solo significato dell’esistenza, la certezza che la vita abbia un senso solo se posta nel quadro delle logiche dell’affermazione.
Walser morì il giorno di Natale, camminando nella neve dopo molti anni di manicomio. Una morte emblematica, di chi già da vivo diceva di sé: “Vorrei essere dimenticato”. Jakob von Gunten anticipa questa morte illustrandoci, con una sapienza stilistica ma anche morale senza eguali, che forse, in fondo, noi non siamo altro che nullità. E che in questa consapevolezza soltanto, come solo nella morte, possiamo ritrovare un coriandolo di grandezza.