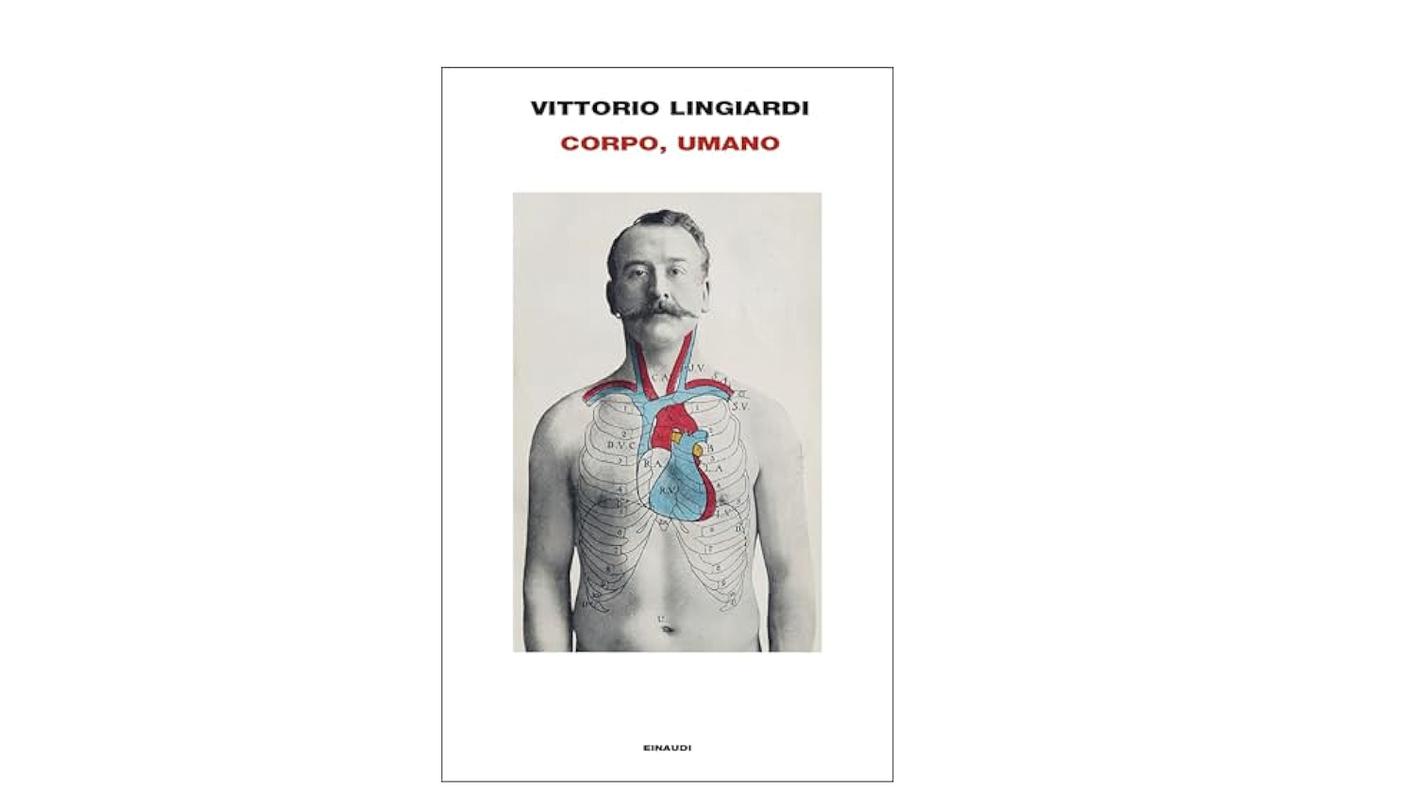Ci sono (o potrebbero esserci) due modi fondamentali per approcciare e circoscrivere la particolarissima vicenda umana e poetica di Paul Léautaud: per negazione oppure per affermazione, utilizzando come reagenti chimici – se così li si può definire – due grandissimi nomi della letteratura francese, Gustave Flaubert e Henri Beyle alias Stendhal. Flaubert rappresenta infatti il modello negativo: Léautaud lo riteneva (ingiustamente, ma questo è un altro discorso) un freddo realista e un esteta dallo stile troppo raffinato, alla costante e quasi mistica ricerca del mot juste, la “parola esatta” che deforma i suoi romanzi in qualcosa di astratto e artificiale, lontano dalla vita.
Considerato all’interno di una simile prospettiva, Flaubert si rivela niente più che «un autentico ebanista letterario, uno che lucida le frasi affinché risplendano, con un unico risultato: mediocrità e noia». Il leggendario livre sur rien sarebbe quindi una mistificazione, mentre il mot juste sarebbe l’oggetto di una ricerca tanto inutile quanto pretenziosa, e infine dannosa. Perché la verità della vita e della realtà sta altrove, perché lo stile è un’altra cosa: «Bisogna scrivere con semplicità, sempre, come quando si scrive una lettera». E poi perché lo stile ricercato e ridondante costringe a pose di importanza e messinscene d’autore, istituisce categorie e criteri immaginari, che sfalsano la visione delle cose così come sono, mentre invece «una cosa vale l’altra. Il resto, sono buffonate che abbiamo escogitato per dare un senso alla vita. Mi direte: “E voi, allora, coi vostri lavoretti?”. Perbacco! Ho fatto come gli altri, ho reagito, ho lavorato, mi sono divertito a scrivere, tanto per far passare il tempo».
È a questo punto che compare idealmente Stendhal, con l’idea della scrittura come “autobiografia del Signor Me Stesso”. Léautaud ha perseguito una simile idea nelle oltre seimila pagine che compongono il suo Journal littéraire, con assoluta coerenza e in ossequio alla massima contenuta in un’annotazione del marzo 1918: «In quello che scrivo ho una grande propensione a parlare di me, dei miei ricordi. Lo stesso nelle mie fantasticherie. Avrò passato la vita a scrivermi». All’esatto opposto di Flaubert, l’egotista Stendhal rappresenta il modello positivo, la verità della reinvenzione: Léautaud (giustamente, in questo caso) individua nel “beylismo” o “egotismo” un approccio unico alla “realtà”, che viene percepita dai sensi, registrata e codificata dall’intelletto e dalla ragione, e infine ricreata dal sentimento, dalla passione e dalla memoria. Più che uno scrittore, insomma, Stendhal è un fenomeno che trascende la letteratura e diventa un modo di essere, una possibile forma e un contenuto dell’esistenza.
Nella stendhaliana chasse au bonheur, non meno leggendaria del flaubertiano livre sur rien, il cinico sentimentale Léautaud scorge infatti il precipitato della tristezza immanente alla condizione umana, il tempo che passa, le troppe cose che si perdono, la quotidianità che non va da nessuna parte, la costante e irrisolta dialettica tra le istanze che sostanziano la vita ma la irrigidiscono e quelle che la liberano ma insieme la dissolvono. È precisamente per questo motivo che una delle più belle definizioni che ha dato di se stesso vale anche per l’illustre antenato nonché fratello spirituale: «In quanto scrittore, sono sempre stato sordo all’ambizione, all’esibizione, alla reputazione, all’arricchimento. Mi interessa soltanto una cosa: il piacere. Questa parola rappresenta per me il motore di tutte le azioni umane. Non intendo essere un folle, un profeta, un riformatore. Preferisco restare spiritoso, ironico, irridente».

Tutto Amiel
Attualità culturale 28.09.2021, 12:45
Contenuto audio
Comunque sia, che si tenti di avvicinarlo per il tramite di Flaubert e Stendhal, oppure di reagenti come mot juste, livre sur rien o chasse au bonheur, Paul Léautaud e il suo Journal littéraire rimangono un autore e un’opera difficilmente inquadrabili e catalogabili. Si potrebbero cercare modelli e paragoni nello Zibaldone di Leopardi, nel Diario di un scrittore di Dostoevskij e più ancora, forse, nel monumentale Journal intime di Henri-Frédéric Amiel, così come si potrebbero fissarne le credenziali in consolidate forme narrative ottocentesche, ma restituite con una sensibilità che approda a spicchi simbolici totalmente novecenteschi.
Il paragone con Amiel si rivela il più vicino per ragioni linguistiche, ma il più lontano per le coordinate esistenziali e letterarie: il Journal intime di Amiel è infatti il racconto microscopico di una vita solo sfiorata ma in sostanza mai vissuta, mentre il Journal littéraire di Léautaud è il racconto non meno microscopico di una vita vissuta e assaporata in tutte le sue venature e screziature, in tutte le sue vertigini, i suoi abissi, i suoi rivoli di fango e melma, nella palude del vizio e in una sobrietà quasi monastica, nel rumore delle vie e delle strade della grande metropoli, ma anche e soprattutto nel silenzio dei sobborghi e nella solitudine di una piccola casa trasformata in eremo (il leggendario padiglione di Fontenay-aux-Roses), non da ultimo nel sorgivo disprezzo degli uomini e nell’amore per gli animali («Che non si ubriacano e non prendono la sifilide»).
C’è infine un altro aspetto, non meno dirimente di altri. Il parigino Léautaud è non soltanto un francese totale, ma anche un fascio di contraddizioni e di antitesi: ha la freddezza cartesiana e l’esprit de geometrie del cinico, il moralismo settecentesco dell’amorale (come l’amatissimo Chamfort), la limpidezza illuministica del torbido. Si capisce perché il sistema editoriale italiano – a suo tempo troppo ideologizzato, ormai troppo distratto e alla costante quanto disperata ricerca della next big thing – non lo abbia mai veramente considerato: Léautaud guarda dove non bisogna guardare, dice ciò che non vogliamo sentirci dire. È vicinissimo, ma anche lontanissimo. Una scelta di circa quattrocento pagine del Journal littéraire, col titolo Diario, venne pubblicata da Garzanti nel 1969 per la cura di Oreste Del Buono, mentre la sua danza di amore e morte con Anne Cayssac (ribattezzata la “pantera” o le Fléau, il “Flagello”) era stata pubblicata l’anno prima da Feltrinelli col titolo Settore privato.
Il resto, per così dire, è un insieme di rimasugli: gli scritti raccolti in Passatempi (1929) e pubblicati da Einaudi nel 1983, il Diario particolare del 1933, edito da SE nel 1993 (un’altra danza di amore e morte, questa volta con Marie Dormoy, che in Francia ha fornito lo spunto per il film Comédie d’amour con Michel Serrault, Annie Girardot e Aurore Clément), infine un volume pubblicato nel 2011 da Sellerio col titolo Amori, che riprende senza modifiche un volume edito da Einaudi nel 1976 e propone i tre racconti autobiografici Il piccolo amico, In Memoriam e Amori, scritti tra il 1902 e il 1906. L’unico libro ancora in catalogo è quello pubblicato da Sellerio.
Quanto al teatro, nella stagione 2005-2006 Luca Ronconi portò sulle scene Settore privato col titolo Diario privato, nella riduzione di Raffaele La Capria, con Giorgio Albertazzi nella parte di Léautaud e Anna Proclemer in quella della Cayssac. In questi ultimi due decenni, Léautaud è pressoché scomparso dal panorama culturale italofono. Qualcuno ha improvvisato una spiegazione piuttosto malevola: l’Italia, che in ultima analisi è spesso un paese di compromessi e losche mediazioni anche nelle questioni culturali (e nella loro gestione), non sa che farsene di un autore puntuto, angoloso, spigoloso, urticante, volutamente outré e soprattutto inclassificabile come il “francesissimo” Léautaud (“ferocemente libero”, secondo le sue stesse parole). Un giudizio forse eccessivo, ma non privo di un fondo di verità, in particolare alla presente altezza cronologica.

Giorgio Albertazzi e Anna Proclemer in "Diario privato" di Paul Léautaud per la regia di Luca Ronconi
Poi sono arrivati Pirandello e Beckett, con la sottolineatura dell’io quale entità incerta e volatile, irretita in un continuo gioco delle parti dove non è più possibile distinguere la maschera dal volto, anche perché spesso, come nel ballo di carnevale immaginato nel Casanova a Spa di Schnitzler, la maschera stessa nasconde una molteplicità di volti che a sua volta si identifica o perfino coincide col nulla. Il racconto di una vita, come in Stiller di Frisch, Otto e mezzo di Fellini, Fuoco pallido di Nabokov e La morte di mio fratello Abele di Rezzori, è impossibile. Ma è proprio il racconto di questa sostanziale impossibilità a trasformarsi nel racconto – l’unico possibile – di una vita. Léautaud è stato l’iniziatore di questa consapevolezza in ambito novecentesco, perché la sua vita non si limita a coincidere più o meno direttamente col suo racconto, ma è in tutto e per tutto il suo racconto.
Per capire veramente Léautaud, oltre ogni possibile avvicinamento, bisogna quindi raccontarlo seguendo il suo stesso racconto, contenuto principalmente nel Journal littéraire (che copre ben sessantatré anni, dal 1893 al febbraio 1956, pochi giorni prima della morte), ma anche nei tre racconti autobiografici dedicati alla figura della madre (Il piccolo amico), alla morte del padre (In Memoriam) e al primo amore (Amori). Come dice una nota del Journal littéraire: «Ho vissuto soltanto per scrivere. Ho sentito, sperimentato, visto, udito, provato sentimenti e conosciuto persone per scriverne. Ho preferito la scrittura alla felicità materiale, alla facile reputazione. Ho spesso sacrificato i piaceri del momento, i più segreti amori, la felicità di poche creature, per scrivere ciò che volevo scrivere. Di questo conservo la più profonda gioia».
Paul Léautaud nasce a Parigi il 18 gennaio 1872. La madre, Jeanne Forestier, attrice e chanteuse da operetta, lo abbandona appena nato, per proseguire nella propria vita di attrice errabonda e «autentica puttana» (sono parole del figlio). Si incontreranno soltanto due volte, intorno al 1878 a Parigi e poi nel 1901, a Calais, in occasione del funerale della zia Fanny (sorella di Jeanne), quando tra i due si sviluppa un torbido rapporto di attrazione/repulsione che rischia di culminare nell’incesto, si concretizza in un breve ma fittissimo scambio di lettere e infine viene troncato improvvisamente dalla madre, che morirà nel 1916 senza più rivedere il figlio.
Il padre Firmin, dapprima attore di dubbio talento, poi suggeritore presso la Comédie-Française ma soprattutto inguaribile coureur de jupons, si interessa ben poco al figlio, che cresce nel ventre di una Parigi tentacolare che ricorda molto da vicino i Rougon-Macquart di Zola: si ingegna, fa mille mestieri (tra gli altri, segretario in uno studio notarile e in seguito in uno studio legale specializzato in fallimenti e liquidazioni) e legge molto, moltissimo, scoprendo per la prima volta, e in maniera decisiva, i grandi moralisti, Voltaire e Stendhal. Dirà in seguito: «Ho imparato da me, da me solo, senza nessuno, senza regole, privo di una direzione e di un maestro, a leggere ciò che mi piaceva, che mi attirava, che coincideva con la natura della mia mente. Ho lasciato la scuola a quindici anni, mi sono fatto una cultura da solo. Come scrittore, mi sono perfezionato senza l’aiuto della democrazia. Al contrario, agisco e sento come un aristocratico. Il mio modo di pensare, di giudicare, è aristocratico. Sono un antipedagogo, sono antipopolare. Forse sono un anarchico dello spirito». Il “forse” si può tranquillamente levare.
La svolta si verifica nel 1895, quando a ventitré anni entra nella redazione della leggendaria rivista e casa editrice Mercure de France, dove non si limita alla cosiddetta “cucina” (impaginazione, correzione delle bozze e preparazione dei risvolti), ma pubblica i tre racconti autobiografici e si fa subito notare come critico teatrale. La sua rubrica, firmata con lo pseudonimo Maurice Boissard (ma Léautaud viene scoperto subito come autentico autore) lo trasforma nel cronista per eccellenza della Parigi letteraria e culturale di quel periodo, che Boissard/Léautaud restituisce con tratti spesso feroci e sempre dissacranti, mostrando fino a che punto le vaporose e vellicanti idealità dello spirito siano una foglia di fico che nasconde una devastante pochezza umana.
Potrebbe essere la via verso il successo, la fama, perfino la ricchezza, ma non sarà così. Jacques Rivière, ad esempio, gli fa ponti d’oro per vedere la sua firma sulla Nouvelle Revue Française, Maurice Martin du Gard lo paga profumatamente per scrivere sulle Nouvelles littéraires, Jean Paulhan e Pierre Drieu la Rochelle non mancheranno di chiedergli articoli, saggi e recensioni. Ma lo svolgimento della trama, per così dire, è sempre lo stesso: Léautaud inaugura una rubrica, poco dopo scrive qualcosa che urta troppe sensibilità, gli viene chiesto di rettificare e lui, senza pensarci due volte, interrompe la collaborazione e rinuncia al guadagno.
La fama arriverà davvero pochi anni prima della morte, nel 1951, quando il giornalista e letterato Robert Mallet lo coinvolge in una lunga serie di interviste radiofoniche che lo rivelano al grosso pubblico. Ma Léautaud è ormai anziano, stanco, pieno di acciacchi, non ha bisogno di soldi che non saprebbe come spendere, chiede soltanto di vivere tranquillo e in solitudine nel padiglione di Fontenay, dove può scrivere e fantasticare indisturbato, con la sola compagnia dei cani e gatti che stanno un po’ dappertutto nell’abitazione e nell’annesso giardino (per un certo periodo, ci fu perfino una scimmia). Rifiuta i premi letterari, gli ipocriti onori tardivi e soprattutto la proposta del grande editore Gaston Gallimard, che gli offre una cospicua somma di denaro e la pubblicazione di una scelta delle opere nella prestigiosa collana della Pléiade.
Muore a 84 anni, il 22 febbraio 1956, dopo un soggiorno di un mese nella Maison de Santé della Vallée-aux-Loupes, dove aveva vissuto Chateaubriand. Se le ultime parole di Rabelais erano il compendio della tragicommedia umana («Abbassate il sipario, la farsa è terminata»), le ultime parole di Léautaud sono il compendio di una personalissima verità umana e poetica: «Et maintenant, foutez-moi la paix», «E adesso, lasciatemi in pace». Il Journal littéraire viene pubblicato in 18 volumi tra il 1954 e il 1966, con l’aggiunta, in questi ultimi decenni, di alcuni volumi giudicati all’epoca troppo spinti e ribattezzati Journal particulier. L’ultimo, relativo al 1937, è stato pubblicato nel 2020.
Lo si potrebbe comodamente definire un egotista alla massima potenza, un notista compulsivo, uno spietato anatomista di se stesso e del prossimo, un cinico sentimentale e un moralista immorale che non ha risparmiato amici, amori, conoscenti, convenzioni, finzioni culturali e ipocrisie civili, ma nemmeno i propri vizi e le proprie miserie (dello spirito e della carne). Il Journal littéraire, da questo punto di vista, fa pensare a un unico, lunghissimo e ininterrotto movimento di inspirazione ed espirazione, fino al soffocamento: un po’ come i Cantos di Ezra Pound. Tutto giustissimo, tutto verissimo, ma forse la verità vera è un’altra.
Perché forse Paul Léautaud, con la sua descrizione giorno per giorno, quasi ora per ora, di una vita umana nel suo farsi e disfarsi nella trama del tempo, col suo io – come quello di tutti – eternamente sospinto dietro chissà quale vento, è piuttosto l’incarnazione della coscienza infelice e di tutte le contraddizioni immanenti alla pretta fatalità biologica dell’esistenza: «Sono certo di chi sono: un niente, un neutrale, un indipendente, un marginale». Non ha mai votato, disprezzava sia la destra che la sinistra, detestava la légèreté francese deformata in ideologia (gravemente scontata, a suo modo di vedere, durante il secondo conflitto mondiale), immaginava un’utopica aristocrazia dello spirito e odiava tutto quanto ci sembra oggi definitivamente (e superficialmente) acquisito: la democrazia pervertita in democratismo, il culto idolatrico della “libertà” e l’astratto mito del “popolo”, il suffragio universale, l’istruzione obbligatoria e statalizzata, il servizio militare, l’idea di patria: «Saranno sempre abbindolati gli uomini, col loro eterno bisogno di credere in qualche cosa! Il progresso è puramente materiale, niente di spirituale. Non si sono migliorati gli uomini, che restano quelli che sono sempre stati e sempre saranno».
Vivere raccontandosi, raccontarsi vivendo (per vivere o almeno sopravvivere); non credere mai all’esistente come unico orizzonte possibile, e quindi non accettarlo, metterlo sempre in discussione: è questo l’invito che l’antipedagogo Léautaud ha trasmesso idealmente e concretamente con la sua vita, le pagine del Journal littéraire e gli altri scritti. È l’invito a restare umani malgrado tutto, malgrado un mondo sempre più disumano. Un invito valido oggi più che mai, riassunto come per contrasto in una breve ma fulminante e definitiva considerazione contenuta in Passatempi: «Com’è triste lo spettacolo di coloro che sono soddisfatti, che trovano che tutto va per il meglio, che non hanno più alcuna reazione, di nessun genere. Cadaveri viventi».