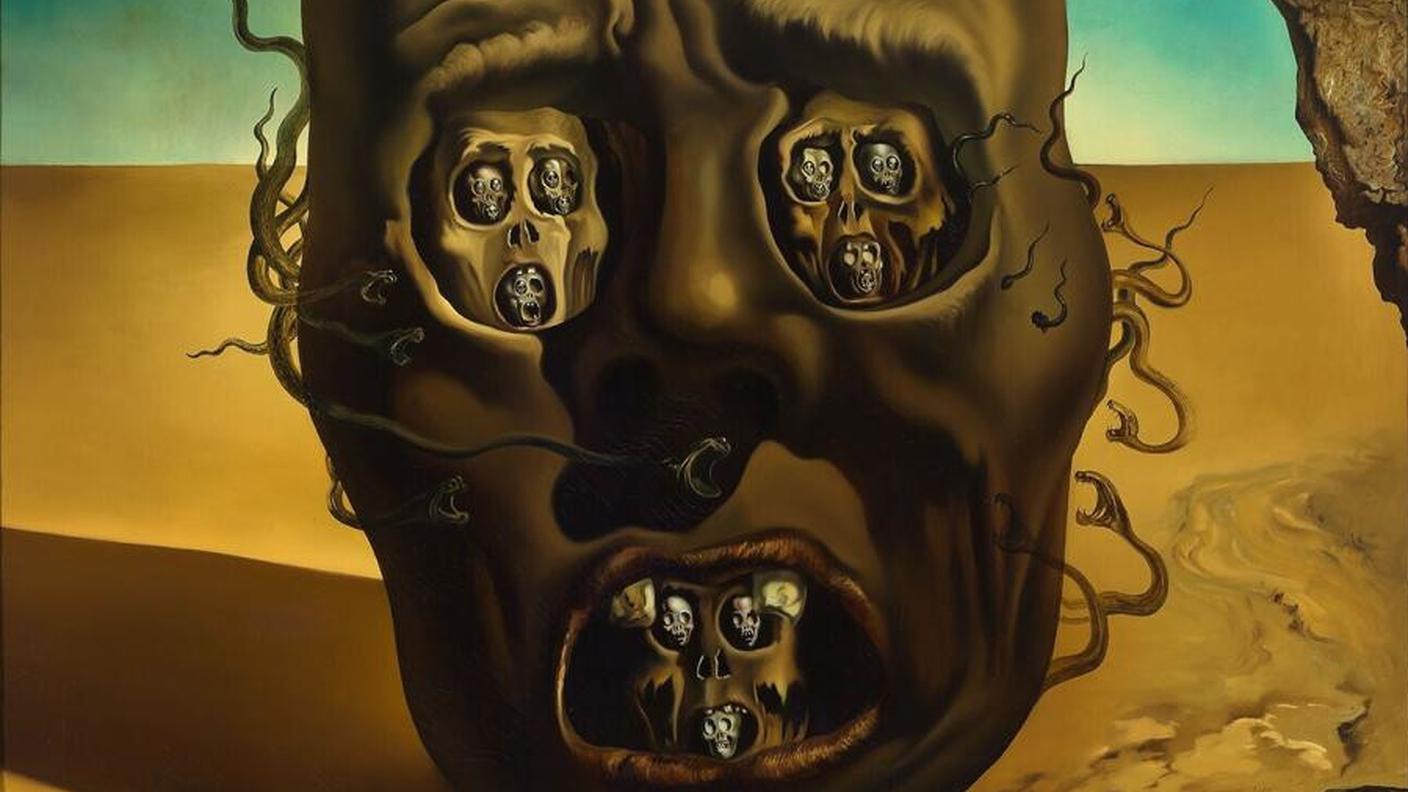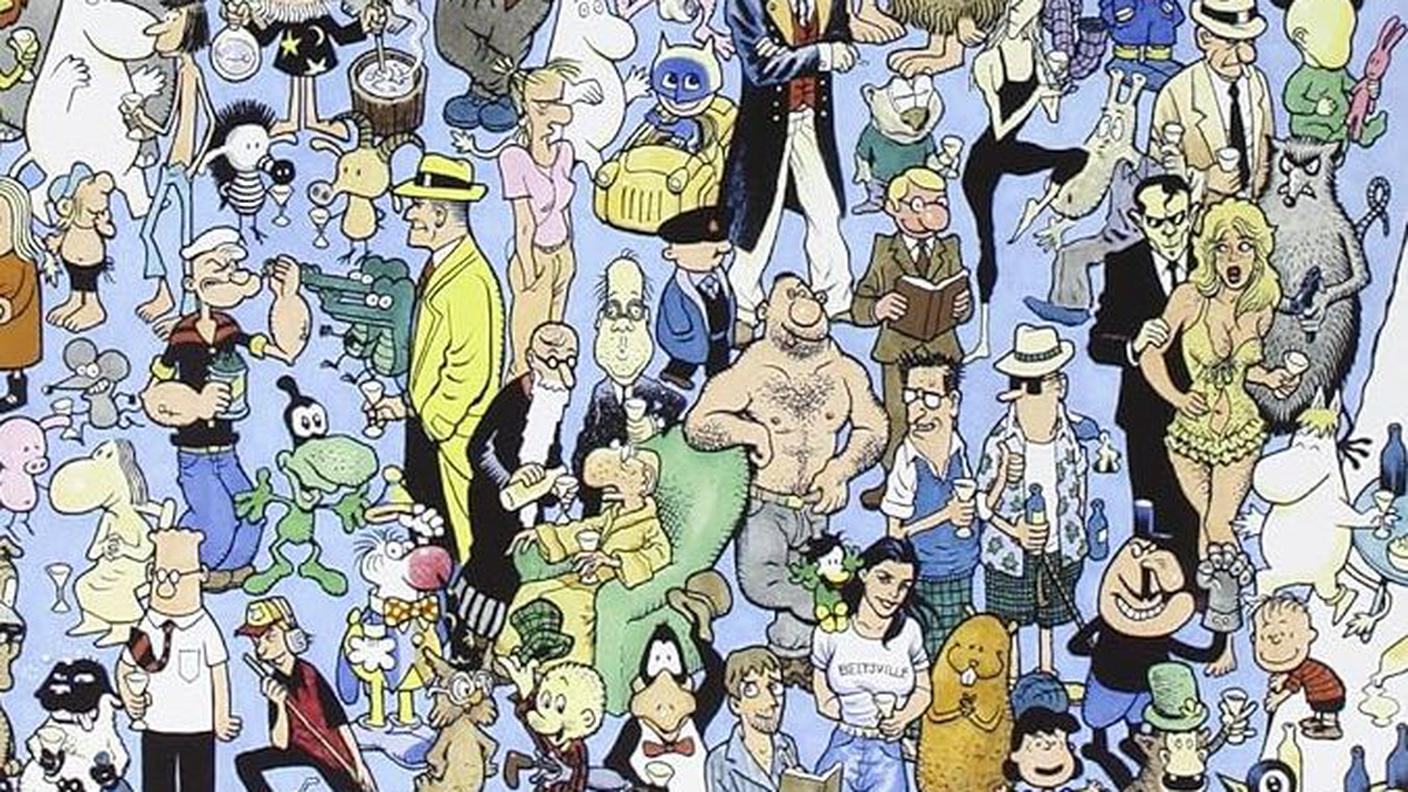In un passo particolarmente significativo della Fenomenologia della percezione – un testo del 1945 che meriterebbe un’attenta rilettura, perché ha anticipato e dice ancora parecchie cose molto vere sulla “realtà” e sul nostro modo sempre più astratto di intenderla e interpretarla, e quindi di viverla – Maurice Merleau-Ponty ha scritto giustamente che siamo tutti «dentro un discorso», nella misura in cui recepiamo qualcosa che è stato lasciato da chi è venuto prima di noi e lasciamo qualcosa che altri, dopo di noi, raccoglieranno. Tutto rimanda a tutto, il filo si dipana ininterrotto, un po’ come le interpretazioni dantesche di cui parlava Borges: noi lo reggiamo per qualche istante, poi lo affidiamo idealmente e concretamente ai posteri.

Friedrich Hölderlin: al fonte del Danubio (2./10)
Blu come un'arancia 05.07.2011, 16:29
Contenuto audio
Il “discorso” relativo allo sfalsamento della percezione e al conseguente scollamento tra vita e rappresentazione, ad esempio, è stato inaugurato all’inizio del diciannovesimo secolo dal massimo poeta tedesco di tutti i tempi, Friedrich Hölderlin, che da parte sua lo aveva sostanzialmente ricavato da un “discorso” molto precedente, che affonda le proprie radici addirittura in Platone, Empedocle e nei grandi tragici greci. Nell’epoca moderna, secondo Hölderlin, abbandonata dal Fato e ormai priva della dimensione verticale della vita (che lo stesso Hölderlin vedeva ancora presente, con quasi insostenibile nostalgia, nella grecità classica), si è infatti verificato uno smarrimento tragico e radicale. Dicono i versi della sua poesia maggiormente rivelatrice e profetica, Al fonte del Danubio, scritta tra il 1801 e il 1803:
Molto c’è da cantare ancora
ma ora mi finisce in beate lacrime
come una leggenda d’amore,
il canto: e così pure,
tra vampe e pallori, dal principio
m’è venuto. Ma tutto va così
F. Hölderlin, Al fonte del Danubio
È la consapevolezza della scissione tra la realtà e il suo racconto, e quindi dell’assenza di un possibile significato. «Ma tutto va così»: la percezione è torbida e fallace, la “pura esistenza” (il “fiore blu” del suo quasi coetaneo Novalis) non esiste, o comunque è un’utopia differita in chissà quale altrove, la vita esiste unicamente nel suo farsi accadere e disfarsi, altro non è possibile dire («ma ora mi finisce il canto»). Nel corso dell’Ottocento e soprattutto del Novecento sono poi arrivati i grandi scettici, che hanno raccolto la drammatica sollecitazione di Hölderlin declinandone il senso e l’eredità in molteplici variazioni.
Il poeta novecentesco che ha fatto maggiormente proprio il “discorso” specifico di Hölderlin rimane con ogni evidenza Thomas Stearns Eliot, la cui intera produzione ruota intorno alla percezione del carattere sfuggente ed enigmatico della realtà e si risolve nell’utopico tentativo di ricondurre la realtà stessa all’interno di alcune coordinate che la rendano interpretabile, esperibile e vivibile al di qua o al di là di tutte le strettoie ideologiche e delle sovrastrutture sociali e culturali.
https://rsi.cue.rsi.ch/cultura/letteratura/William-Wordsworth-la-normalit%C3%A0-del-Bello--1781451.html
Si tratta in fondo, per rimanere in ambito anglofono (statunitense di origine, nato a Saint Louis nel 1888 e naturalizzato britannico, Eliot morì a Londra nel 1965), della vecchia utopia romantica di Coleridge e soprattutto di Wordsworth, che Eliot riprende e svolge a partire da una sensibilità segnata e fortemente intaccata dagli orrori e dalle nefandezze del “secolo breve”. I Daffodils, i celebri narcisi cantati da Wordsworth, simbolo della vita così come dovrebbe essere, crescono ancora, ma Eliot li situa sullo sfondo di una Waste Land, una “terra desolata” e popolata da Hollow Men, “uomini vuoti” in quanto privi di un passato, inconsapevoli del presente e ignari del futuro («Andiamo ormai come orfani», diceva non a caso il verso finale della poesia di Hölderlin sul Danubio).
The Hollow Men era la lirica preferita del cantante e leader dei Joy Division, il sensibilissimo Ian Curtis, sofferente di epilessia e devastato da un sordo e penetrante male di vivere. Stando alle testimonianze dei suoi amici e degli altri tre membri del gruppo, si tratta della sua ultima lettura prima di togliersi la vita, la mattina di domenica 18 maggio 1980. La sera precedente, aveva visto alla televisione La ballata di Stroszek di Werner Herzog, uno dei più terrificanti affondi nel cuore di tenebra dell’animo umano, nel suo vuoto, nelle sue vertigini, quasi una trasposizione in immagini de Gli uomini vuoti. Esattamente un secolo dopo, questa meravigliosa poesia continua a scavare con precisione chirurgica nel ventre molle di un presente sempre più opaco, prefigurato una volta per tutte nei suoi icastici versi conclusivi: «È questo il modo in cui il mondo finisce / Non già con uno schianto ma con un piagnisteo». Non è un caso che venga citata anche da Marlon Brando alias Kurtz nel memorabile monologo della parte finale di Apocalypse Now, liberamente tratto da Cuore di tenebra di Conrad.
Anche se non bisogna dimenticare i Quattro quartetti, riuniti in volume nel 1943, che per molti versi costituiscono il suo testamento letterario e la sua parola definitiva («Via, via, via, disse l’uccello: / il genere umano non può sopportare troppa realtà. / Il tempo passato e il tempo futuro / ciò che avrebbe potuto essere e ciò che è stato / puntano ad un fine, che è sempre presente»), il poemetto La terra desolata del 1922 (col famoso incipit «Aprile è il mese più crudele») e la poesia Gli uomini vuoti del 1925 rappresentano i due vertici della produzione lirica di Eliot, ma possono essere pienamente comprese solo all’interno di una prospettiva più ampia, che includa anche le poesie giovanili e le composizioni della piena maturità.
Tra le tante versioni italiane delle liriche di Eliot, merita una particolare menzione la classica ma sempre ottima e congeniale traduzione di un grande anglista, poeta e uomo di raffinata cultura quale il compianto Roberto Sanesi (Eliot fu la sua passione di tutta una vita). Le traduzioni, purtroppo, tendono a invecchiare facilmente, anche e soprattutto nell’ambito della poesia, ma la versione di Sanesi non ha perso nulla e con ogni probabilità resta l’unica che ha restituito completamente anche nella nostra lingua le screziature e la raffinatezza dell’originale, i tic sintattici e lessicali di Eliot, il suo inglese all’apparenza arcaico ma in realtà modernissimo.
Come altri grandissimi autori, Eliot ha rivelato la propria verità umana e poetica anche in maniera obliqua e indiretta. Lo ha fatto soprattutto in una lunga intervista concessa nel 1958 al giornalista Donald Hall, poi raccolta in volume e disponibile anche in versione italiana, che si può leggere come un’autobiografia. L’intervista, che di fatto è un monologo, perché l’intervistatore si limita molto sapientemente a sollecitare Eliot su vari temi e argomenti, ha il merito di portare alla luce un autore per così dire inedito, o comunque in larga parte sconosciuto.
C’è infatti un Eliot “ufficiale” (francamente piuttosto datato, nella stessa misura in cui appare superato il lato “ufficiale” di Thomas Mann), che parla con un tono da funzionario della cultura, svolge considerazioni piuttosto prevedibili sulla funzione della poesia e scivola a volte nella banalità e nella retorica, in particolare quando constata con un certo ritardo il crescente affermarsi del linguaggio spurio della comunicazione a totale detrimento della purezza del linguaggio poetico: «Penso che, dove ci sono questi moderni mezzi di comunicazione e dove è diffusa la possibilità di imporre il linguaggio e i modi di dire alla massa della gente, il problema si complichi notevolmente». Non siamo molto lontani dal Dizionario dei luoghi comuni di Flaubert, ma in fondo c’è una spiegazione. Se Dante non sempre è stato Dante, come ha scritto lo stesso Eliot in uno dei suoi studi sulla Divina Commedia, è del tutto comprensibile che anche Eliot non sia sempre stato Eliot.
Ma accanto a questo Eliot “ufficiale” c’è anche l’autore che parla con lucidità dei propri esordi letterari e racconta come sono nate le opere più famose, e infine c’è l’autore davvero nascosto e sorprendente, che nelle ultime risposte non esita a confessare i dubbi, le incertezze, i disincanti e le disillusioni che hanno sempre accompagnato il suo lavoro di letterato e poeta. Nel 1941, ad esempio, poco prima di riunire in volume i Quattro quartetti, Eliot aveva rilasciato una dichiarazione ben poco “ufficiale”, che tra l’altro spiegava da quale esperienza fossero nate liriche come La terra desolata e Gli uomini vuoti: «Nessun poeta onesto può mai essere completamente sicuro della validità di ciò che ha scritto. Potrebbe aver perso il suo tempo ed essersi complicato la vita per niente». A diciassette anni di distanza, e con un Premio Nobel in mezzo (Eliot lo vinse nel 1948), l’intervistatore gli chiede se nel frattempo la sua opinione è mutata. Eliot potrebbe rispondere in maniera ufficiale e retorica, e invece le sue parole hanno l’irrefutabile limpidezza di un aforisma, quasi di una sentenza: «Potrebbero anche esistere poeti onesti che si sentono sicuri. Io non lo sono».
Forse non è la sua frase “originaria”, sicuramente è una frase molto rivelatrice, con l’idea dell’insicurezza che spiega molti versi “originari” contenuti nelle sue opere, fa capire cosa significhi la “troppa realtà” e perché sia così difficile sopportarla. Perché quando spariscono i panneggiamenti, quando crollano tutte le idealizzazioni, gli autoinganni e automatismi, le finzioni, le proiezioni immaginative, quando vengono a mancare tutte le ritualità e messinscene sulle quali si reggono i traffici sociali, quando si incrinano le ovvietà alle quali si deve credere per fare in modo che la vita quotidiana funzioni come una macchina, allora gli esseri umani si ritrovano completamente nudi e disarmati: uomini vuoti in una terra desolata.
Si capisce insomma perché “aprile” sia “il mese più crudele”. Perché «genera / lillà da terra morta, confondendo / memoria e desiderio, risvegliando / le radici sopite con la pioggia della primavera», e poi perché «l’inverno ci mantenne al caldo, / coprendo la terra di neve smemorata». Ma soprattutto – e in maniera definitiva – si percepisce il senso più profondo del destino degli “uomini vuoti”: «Figura senza forma, ombra senza colore, / Forza paralizzata, gesto privo di moto. / Coloro che han traghettato / Con occhi diritti, all’altro regno della morte / Ci ricordano – se pure lo fanno – non come anime / Perdute e violente, ma solo / Come gli uomini vuoti / Gli uomini impagliati».
Hölderlin si chiedeva se esiste ancora una “verità tra il giorno e la notte”, se la realtà possiede ancora un volto che ci somiglia, se “conoscere” può ancora significare “riconoscere” e “riconoscersi”, se la novità e l’ignoto non ci sono del tutto estranei ma in qualche modo ci implicano (e ci responsabilizzano), suscitando ricordi, rimandi e reminiscenze nel nostro rapporto col mondo. Si tratta della stessa domanda che si era posto il Goethe “italiano”, alla tanto agognata vista del paesaggio romano: “trovare” significa “ritrovare” nella realtà le coordinate della fantasia e dell’immaginazione? Tra i molti che hanno tentato di rispondere, l’incerto, dubitoso e insicuro Eliot ha fornito con Gli uomini vuoti la risposta più onesta e sincera (anche nel senso di non settaria e non ideologica). Una risposta che un secolo dopo, in un periodo di giustificate paure, ma anche di assurdi e disumani ottimismi, ci appare come l’unica davvero realistica e schiettamente umana:
Fra l’idea
E la realtà
Fra il gesto
E l’atto
Cade l’ombra
Fra il desiderio
E lo spasmo
Fra la potenza e l’esistenza
Fra l’essenza e la discendenza
Cade l’ombra
È questo il modo in cui il mondo finisce
T.S. Eliot, Gli uomini vuoti