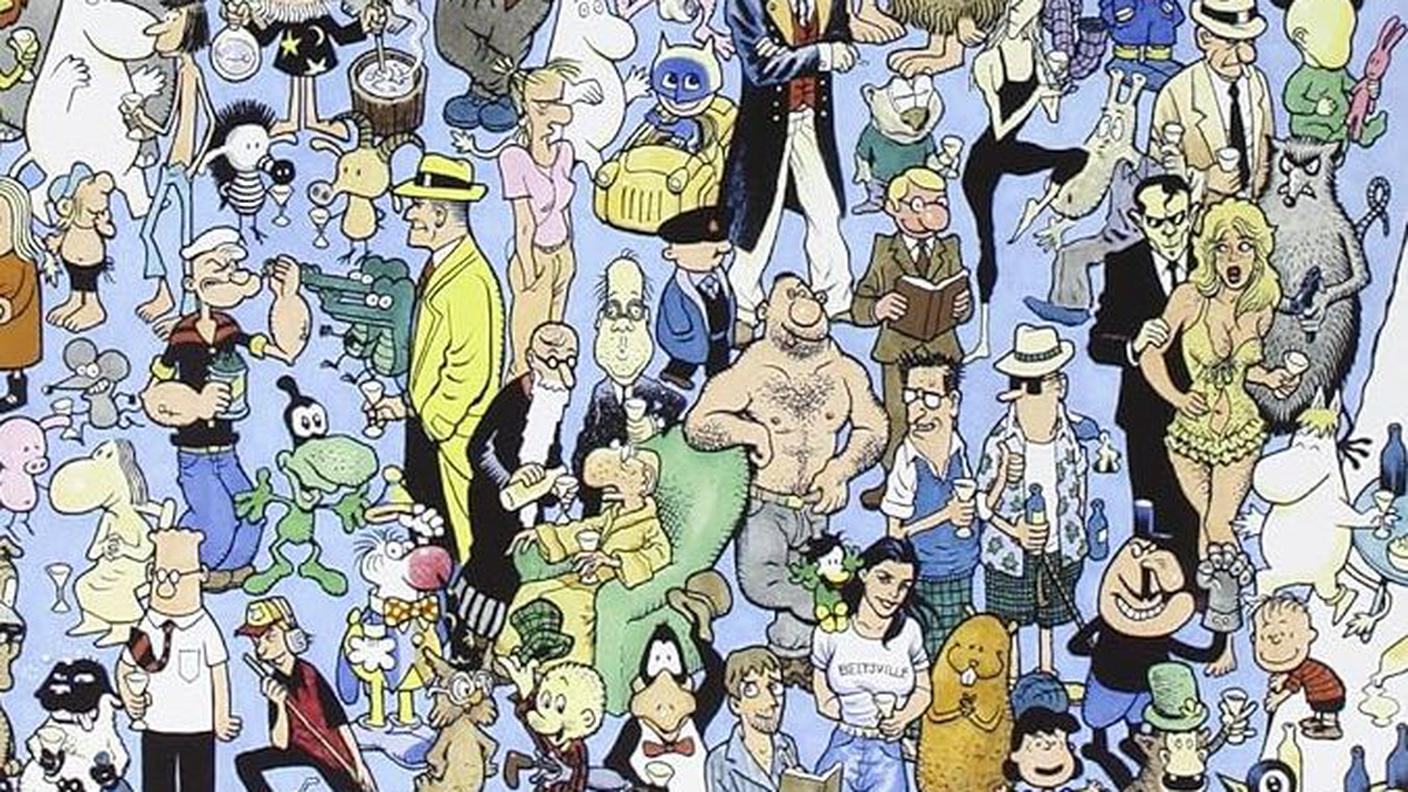In un passo particolarmente significativo della “Fenomenologia della percezione” Maurice Merleau-Ponty ha scritto giustamente che siamo tutti «dentro un discorso», perché recepiamo qualcosa che è stato lasciato da chi è venuto prima di noi e lasciamo qualcosa che altri, dopo di noi, raccoglieranno. Tutto rimanda a tutto, il filo si dipana ininterrotto, un po’ come le interpretazioni dantesche di cui parlava Borges, noi lo reggiamo per qualche istante e lo affidiamo idealmente e concretamente ai posteri, ai “Nachgeborenen” di una celeberrima lirica di Brecht: “Coloro che verranno”, i “venuti dopo”. Che però potrebbero anche essere “nipoti non nati”.
Il grande “discorso” relativo allo scollamento tra vita e rappresentazione è stato inaugurato all’inizio del diciannovesimo secolo (Mastro Goethe vorrà forse perdonarci: l’opinione è largamente condivisa) dal massimo poeta tedesco di tutti i tempi, Friedrich Hölderlin, che però lo aveva sostanzialmente ricavato da un “discorso” molto precedente, che affonda le proprie radici addirittura nell’antichità, in Platone, Empedocle e nei tragici greci (soprattutto Sofocle, che lo stesso Hölderlin aveva magistralmente tradotto e ricreato in lingua tedesca).
Nell’epoca moderna, secondo Hölderlin, abbandonata dal Fato e ormai priva della dimensione verticale della vita (che Hölderlin vedeva ancora presente, con quasi insostenibile nostalgia, nella grecità classica), si è infatti verificato uno smarrimento tragico e radicale, come dicono i versi conclusivi della sua poesia maggiormente rivelatrice e profetica, “Al fonte del Danubio”, scritta tra il 1801 e il 1803: «Molto c’è da cantare ancora / Ma ora mi finisce in beate lacrime / Come una leggenda d’amore, / Il canto: e così pure, / Tra vampe e pallori, dal principio / M’è venuto. Ma tutto va così». Nel corso dell’Ottocento e del Novecento sono poi arrivati i grandi scettici, che hanno raccolto il “discorso” di Hölderlin declinandolo in molteplici variazioni (viene da pensare, solo per fare un esempio tra i tanti, agli “uomini vuoti” nella “terra desolata” di Eliot: «E’ questo il modo in cui il mondo finisce / Non già con uno schianto ma con un piagnisteo»).
C’è stato tuttavia un poeta che più di ogni altro, con assoluto rigore e ferrea consequenzialità, ha fatto propria l’eredità umana e poetica di Hölderlin («il sacro fratello», secondo le sue stesse parole), esplorando tutto il dicibile e spingendosi oltre il confine dell’indicibile, dove ad attenderlo, esattamente come era accaduto circa un secolo prima al suo celebre antenato, ha trovato il Tutto e quindi il Nulla. Non deve quindi stupire che proprio a Hölderlin («uno che ha portato la sua quieta follia come una maschera contro il mondo») abbia dedicato una magnifica poesia che per uno strano scherzo del destino è venuta alla luce soltanto alcuni anni fa, a più di un secolo dalla sua morte. La poesia si intitola semplicemente “Hölderlin” e i suoi versi, quattro giambi con arsi incrociati di adamantina purezza, sono i seguenti: «Il bosco sta disteso nell’autunno / I venti sono attenti a non destarlo, / Quatta la selvaggina in dolce sonno / Mentre il ruscello scivola sommesso. / Così venne offuscato un nobil capo / Nel suo splendore bello e triste / Da follia, che pio uno scroscio / A sera tra le erbe sussurra».
Il poeta in questione si chiamava Georg Trakl, era nato nel 1887 nella cattolica e provincialissima Salisburgo, si era abbeverato alla fonte di Nietzsche, Dostoevskij, Rimbaud, Baudelaire e i “rivoltosi scandinavi” Ibsen e Strindberg e fin da giovanissimo aveva individuato nella poesia l’unico modo di tollerare la realtà, ricreandola e modellandola in versi che nel Novecento di lingua tedesca non hanno paragoni. Vengono in mente, è vero, nomi come Rilke, Benn e Celan, ma Trakl, se mai possibile, si è spinto perfino oltre, tanto che proprio Rilke, suo grandissimo ammiratore, si era chiesto quali potessero mai essere le scaturigini di un genio poetico così incommensurabile, capace di riplasmare la lingua tedesca con l’uso di catene di immagini e metafore volutamente incongrue, ma inserite all’interno di una struttura paratattica di geometrica e davvero prodigiosa perfezione. E’ vero, insomma, quanto scrisse di lui Albert Ehrenstein: «In Austria, nessuno ha mai scritto versi più belli dei suoi».
La verità umana e poetica di Trakl -il suo principio poetologico («dare alla verità quel che è della verità»), si vorrebbe quasi dire il suo magistero di tenebre- è tutta contenuta nelle liriche, che pagano un più o meno inevitabile dazio all’espressionismo (il “trend” quasi obbligato dell’epoca) ma poi si aprono verso dimensioni che sfuggono e si sottraggono a ogni possibile canone. Il compianto Italo Alighiero Chiusano ne ha descritto in maniera molto efficace la sostanza più profonda, fatta di una “putrida fosforescenza” e “tragica luttuosità”: «Quella di Trakl è una poesia di livida tristezza, con l’anima che si aggira spaesata in un mondo che sembra fatto per i lemuri e i morti, tra parchi abbandonati, fontane stillanti, fiori dalle tinte mai viste in natura, tramonti interminabili che si riflettono in vecchie specchiere dorate, viuzze deserte nella notte, voli di strani uccelli o di angeli malinconici, misteriosi volti di donne-sorelle, suoni non si sa bene se di campane a morto o di improbabili cornamuse».
Alla base di questa “putrida fosforescenza” e “tragica luttuosità” c’è precisamente la consapevolezza che Trakl ha mutuato da Hölderlin e ha poi spiegato in un celebre passo di una lettera all’amico Johannes Klein: «Il singolo, nella società moderna, si isola perché preferisce essere dissoluto anziché inautentico. Io anticipo le catastrofi mondiali, non prendo partito, non sono un rivoluzionario. Sono il partito, nella mia epoca non ho altra scelta se non il dolore». E’ una consapevolezza abissale e vertiginosa, perché Trakl -che amava paragonarsi al prediletto Kaspar Hauser, il singolo irrelato per antonomasia, figlio di nessuno e di nessun tempo- afferma in sostanza che la vita è esilio e l’unico modo di rappresentare le lacerazioni della propria epoca e della propria esistenza consiste nella scelta di una posizione marginale e dissoluta -nel senso etimologico di “sciolta”- da ogni possibile vincolo. Si tratta di un aspetto ben evidenziato da Claudio Magris nella prefazione alle liriche pubblicate da Garzanti nel 1983: «Trakl vive sino in fondo, nella sua breve esperienza straziata dal dolore e nella sua altissima poesia spezzata e brancolante, questa scissione dell’epoca. Nella sua vicenda privata, agitata da ombre e ossessioni, egli annuncia e patisce le catastrofi mondiali, l’agonia della civiltà che sgretola tutti i fondamenti della vita, sino a quel calvario della prima guerra mondiale nel quale egli si consuma e distrugge. Il singolo non può prendere partito, la sua unica autenticità possibile è la posizione marginale e sperduta».
La lirica che più di ogni altra esprime questa posizione marginale è la straordinaria “Hohenburg”, databile intorno all’autunno 1913, dove si dice che è possibile vivere soltanto “lontano dal frastuono del tempo” (“Ferne dem Getümmel der Zeit”), perché “trema nel buio l’estraneo / quando alza le sue ciglia su un che di umano”, e preferisce ascoltare “la voce del vento argentea” che lo riporta a profondità preverbali, prelogiche, perfino prenatali.
Questa percezione della vita come esilio e della marginalità quale unico spazio di sopravvivenza viene espressa anche in una lettera inviata da Vienna alla sorella Hermine il 5 ottobre 1908. Trakl si era infatti recato nella capitale per studiare farmacia ed era entrato in contatto per la prima volta con l’ambiente della metropoli e l’assordante “frastuono del tempo”: «Quando giunsi qui fu come vedere per la prima volta con chiarezza la vita qual è, nuda, priva di pregiudizi, quasi percepissi tutte le voci che parla la realtà, spietate, penosamente percettibili! Ho sentito, fiutato, toccato in me le possibilità più spaventose e ho udito ululare nel sangue i demoni, mille diavoli con i loro pungoli. Che incubo orribile…».
Anche in questo caso c’è un forte parallelismo con Hölderlin, in particolare con un passo del romanzo epistolare Iperione, quando il protagonista torna in Germania dalla Grecia e si imbatte nei nuovi “barbari” (dove per “barbari” bisogna intendere coloro che hanno perso la spontanea unione con la natura): «E’ una dura parola, tuttavia la pronuncio perché è la verità. Non mi posso immaginare un popolo più dilacerato dei tedeschi. Vedi operai, ma non uomini, pensatori, ma non uomini, sacerdoti, ma non uomini, padroni e servi, giovani e gente posata, ma non uomini… Non è forse simile a un campo di battaglia, dove giacciono, mescolate le une con le altre, mani, braccia, tutte le altre membra, mentre il sangue vitale versato si disperde nella sabbia?».
Ma le similitudini, almeno esteriormente, finiscono qui. Perché il destino, che tutto sommato aveva risparmiato Hölderlin permettendogli di vivere la seconda metà della vita nelle tenebre di una quieta follia, e quindi “lontano dal frastuono del tempo”, aveva in serbo ben altri piani per il saturnino Trakl, sulla cui esistenza gravavano due ombre enormi: il rapporto incestuoso con la sorella Grete, poi morta suicida nel 1917, e la sempre maggiore dipendenza dall’alcol e dalle droghe, soprattutto dalla cocaina. Lo scoppio del primo conflitto mondiale fece il resto. Trakl si arruola volontario come addetto alla farmacia e vede coi propri occhi l’orrore della battaglia di Grodek nella Galizia Orientale, tenta di suicidarsi e viene ricoverato per sospetta pazzia all’ospedale militare di Cracovia. Molto probabilmente sarebbe guarito, ma ormai aveva compreso che nel “frastuono del tempo” nessuna autentica guarigione sarebbe stata possibile. Nella notte tra il 2 e il 3 novembre 1914 si uccide ingerendo una dose letale di cocaina. La sua ultima poesia, scritta presumibilmente tra il 24 e il 25 ottobre, prende il titolo da Grodek ed è una delle più grandi liriche del Novecento, forse di tutti i tempi. Senza dubbio una delle più vere, di una verità che fa male perché affonda nella carne viva di noi “venuti dopo” e “nipoti non nati”, sempre più assordati dal “frastuono del tempo” e disperatamente in cerca di una lontananza sempre più differita e impossibile: «A sera risuonano i boschi d’autunno / Di armi mortali i piani dorati / E le acque d’azzurro, più cupo / Vi rotola il sole; chiude la notte / Guerrieri morenti, l’aspro lamento / Di bocche squarciate. / Ma quieto nel bosco di salci s’addensa, / Nuvola rossa, in cui siede un dio irato, / Il sangue sparso, freddo lunare / Tutte le strade portano a nero marciume. / Sotto notturna ramaglia dorata e le stelle / Della sorella scivola l’ombra fra il tacito bosco, / Saluta gli spettri d’eroi, i loro capi nel sangue; / Piano fra canne risuonano i flauti oscuri d’autunno. / O lutto più fiero! voi altari di bronzo / Possente un dolore oggi alimenta la fiamma bruciante del cuore, / I nipoti non nati».