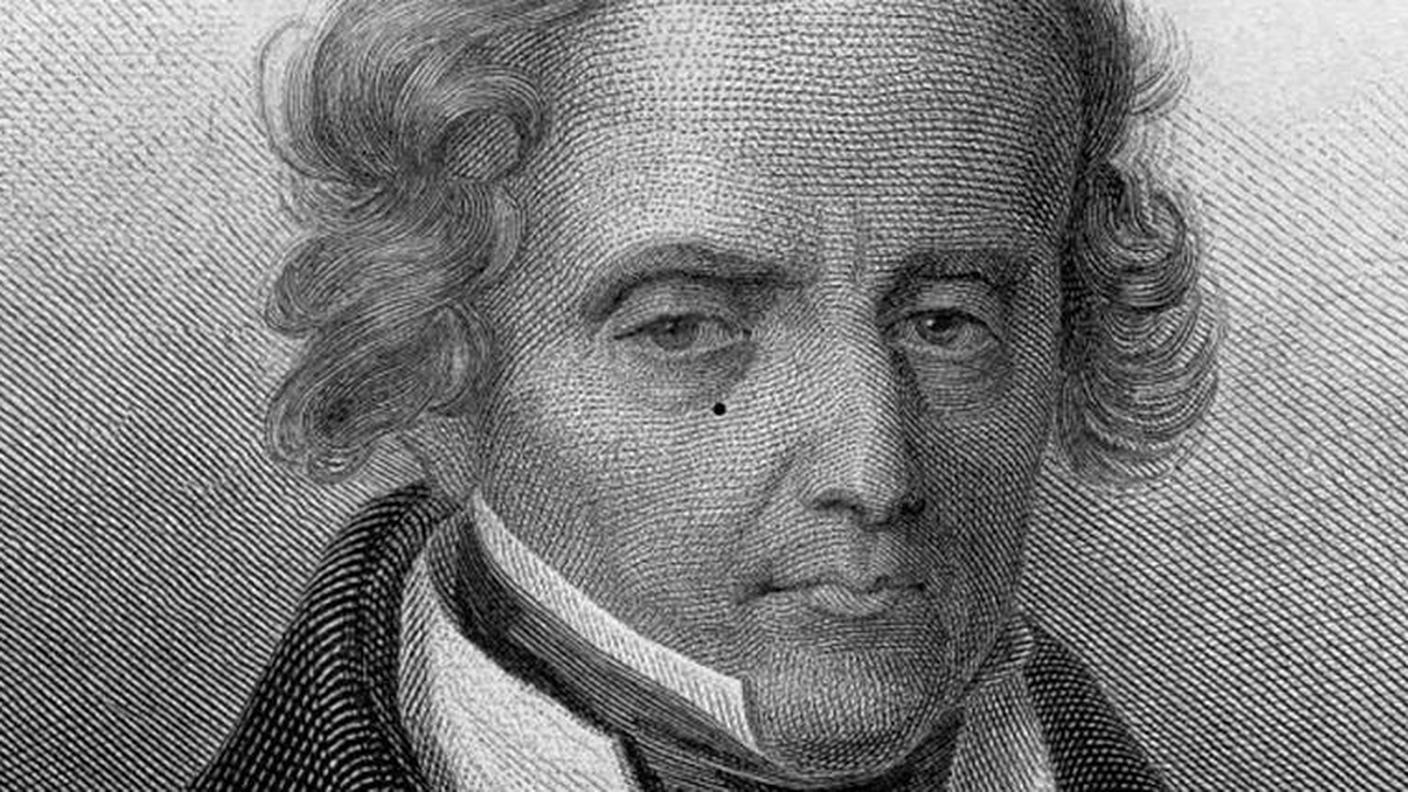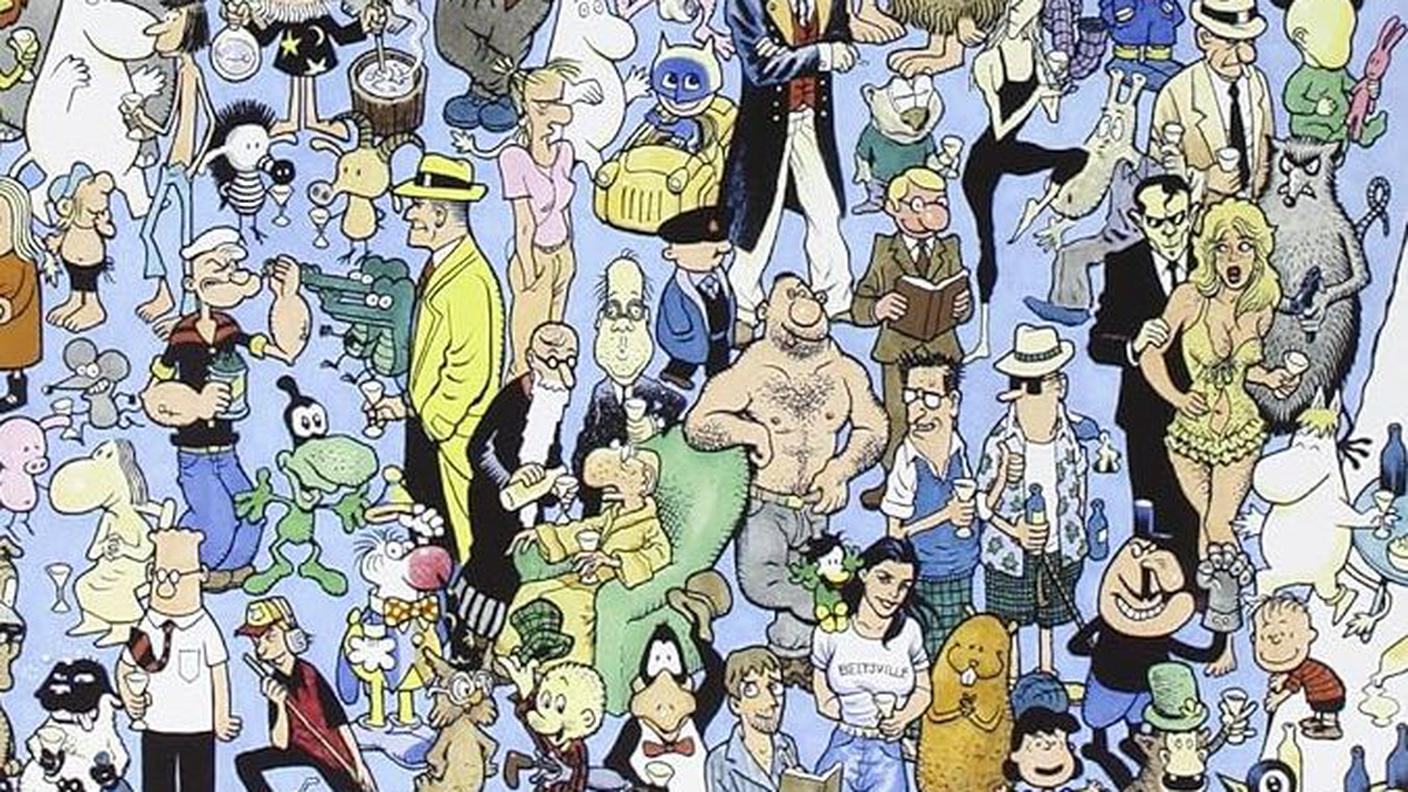Nel 1885, in occasione di una delle tante tournée che i richiestissimi teatranti italiani compivano un po’ ovunque in Europa, il livornese Ernesto Rossi, uno dei massimi attori dell’epoca e grande interprete di ruoli shakespeariani (le cronache riferivano soprattutto del suo personalissimo nonché inarrivabile modo di recitare il monologo di Shylock ne Il mercante di Venezia), approdò nei paesi scandinavi ed ebbe quasi l’impressione -sono sue parole- di scoprire «un nuovo continente».
Circa un decennio dopo sarà la volta di Eleonora Duse, la “maggiore artista” (secondo la definizione di Matilde Serao), congeniale interprete di molte eroine del norvegese Ibsen («senza Ibsen sarei morta già da tempo», era solita dire), che pur conoscendo bene talune atmosfere tipicamente scandinave, se non altro perché si era calata nei panni di vere e proprie incarnazioni dell’anima nordica come Rebecca West in Rosmersholm e la “donna del mare” Ellida Wangel, non mancò di rimarcare la propria estraneità nei riguardi di un contesto umano e sociale che le appariva straordinariamente esotico e di ardua comprensione.
Ma non è finita qui: pressappoco nello stesso periodo, in quel di Parigi, la grande attrice francese Sarah Bernhardt aveva parlato sprezzantemente di norderie per definire le novità che arrivavano dalla Scandinavia. L’ideale parterre du roi si completa con Isadora Duncan, che a distanza di alcuni decenni, in un passo delle memorie, ricordando l’irruzione della drammaturgia scandinava sulle scene europee non poté fare a meno di esclamare: «Maledetto Ibsen, maledetto Strindberg, maledetti scandinavi, maledetti tutti!». Una tipica uscita da primadonna, le cui motivazioni rimangono peraltro piuttosto oscure. Cosa le avranno mai fatto i “maledetti scandinavi”?
Comunque sia, questa percezione dell’estremo nord europeo quale terra incognita e territorio dello Hic sunt leones deriva anche dal fatto che i paesi scandinavi, a partire dal diciassettesimo secolo, erano rimasti abbastanza fuori dalle grandi correnti politiche europee, e quindi è comprensibile che ancora alla fine dell’Ottocento li si percepisse un po’ come paesi esotici. Ma proprio in quel periodo le cose stavano cambiando in maniera sostanziale: i “rivoltosi” drammaturghi Ibsen e Strindberg avevano portato la cultura scandinava sul continente europeo, e inoltre non bisogna dimenticare altri autori come Hamsum, Bjornson, Jacobsen, Herman Bang e non da ultimo il grande critico danese Georg Brandes, che svolse un’importantissima opera di mediazione tra Scandinavia ed Europa continentale.
Un altro aspetto tanto significativo quanto poco conosciuto è inoltre da ravvisare nel fatto che il cosiddetto “teatro di regia” non nasce ai primi del Novecento con Stanislavskij e il suo celeberrimo “metodo”, come si pensa comunemente, ma nella seconda metà dell’Ottocento nei teatri scandinavi, con lo svedese Ludwig Josephson e il danese William Bloch. Periferia, insomma, ma fino a un certo punto. Nel corso del Novecento la cultura scandinava si è poi affermata in particolare grazie ai film di Ingmar Bergman, però l’estremo nord europeo è rimasto qualcosa di lontano, soprattutto in Italia.
Basti pensare che ancora negli anni Ottanta del secolo scorso il critico danese Jorgen Clausen, presentando la traduzione italiana dell’Erasmus di Ludwig Holberg, il classico per eccellenza della letteratura danese del Settecento, si lamentava giustamente della «mancanza di conoscenza di una letteratura di cui sono noti soltanto Ibsen, Strindberg, Andersen e Karen Blixen», e si chiedeva perché mai non esistesse «una tradizione di traduzioni dalle lingue nordiche».
In questi ultimi quarant’anni la situazione è decisamente cambiata: molti autori scandinavi, sia classici che contemporanei, sono stati tradotti, letti e apprezzati. Tra gli autori finalmente riscoperti merita una menzione particolare l’islandese Halldór Kiljan Laxness, nato a Reykjavík il 23 aprile 1902 e morto nella stessa città l’8 febbraio 1998, Premio Nobel nel 1955 ma all’epoca conosciuto dai lettori italofoni principalmente in virtù di un volume pubblicato nel 1970 dalla Utet, nella collana dedicata ai vincitori del Nobel. La scelta, in occasione di quella meritoria ma sparuta pubblicazione, era caduta sui testi maggiormente legati al colore locale. Si era quindi ricavata l’immagine di Laxness come scrittore fortemente legato alla propria terra ma privo di un respiro più ampio, nello stesso modo in cui l’Islanda, in quel periodo, continuava ad essere conosciuta molto superficialmente come una remota terra vulcanica di ghiacci e geyser, fredda e inospitale, con tratti esotici non molto differenti da quelli che quasi un secolo prima avevano provocato il disorientamento di Ernesto Rossi ed Eleonora Duse.
Le opere pubblicate dalla casa editrice Iperborea permettono di inquadrare la narrativa di Laxness all’interno di una prospettiva completamente nuova e per molti versi sorprendente, perché la remota Islanda, così come si profila dalle pagine dello stesso Laxness, si è rivelata un paese culturalmente molto vivo e non privo di conflitti. L’onore della casa, ad esempio, si presenta come una variazione sul tema (che Laxness deriva con ogni probabilità dal tardo Ibsen) delle convenzioni sociali che non permettono la piena realizzazione dei desideri e delle aspirazioni; il possente romanzo Gente indipendente è la grande saga dell’Islanda nei primi decenni del Novecento e possiede molti punti di contatto con Cent’anni di solitudine di Garcia Marquez e i grandi romanzi russi del diciannovesimo secolo, soprattutto per l’incedere epico della narrazione e la capacità di restituire con pochi tratti l’anima più profonda di un popolo e di una nazione.
«Per la sua opera epica, che ha rinnovato l’arte e la letteratura islandese», recita del resto la giusta motivazione dell’Accademia di Svezia. Romanzi come Sotto il ghiacciaio, Sette maghi e Il concerto dei pesci penetrano infatti nel passato mitico della nazione, ma nello stesso tempo mostrano un’Islanda percorsa e talora lacerata da molte contraddizioni, divisa tra modernità e tradizione, tra l’esigenza di aprirsi al futuro e la necessità di non rinnegare il passato, mentre La base atomica, scritto nel 1947 e per lungo tempo censurato in Europa, racconta una storia vera e non propriamente edificante, quando nel 1940 gli Usa promisero l’indipendenza al governo islandese in cambio della possibilità, poi non realizzatasi, di costruire una base atomica sul territorio del paese.
Un piccolo aneddoto, ma non privo di significato: il massimo scrittore svizzero del Novecento, Robert Walser, ha reso simpaticamente omaggio a Laxness vincitore del Premio Nobel. L’omaggio è contenuto nelle celebri Passeggiate con Robert Walser di Carl Seelig, più precisamente nella passeggiata del 25 dicembre 1955. Racconta Seelig: «Lo diverte da non dirsi il modo di comportarsi dello scrittore islandese Halldór Laxness, insignito quest’anno del Premio Nobel per la letteratura. Non ha mai letto niente di lui, ma ha veduto in una rivista una foto che ritiene caratteristica. Ancora gli viene da ridere se pensa alla sicumera con cui Laxness, durante i festeggiamenti a Stoccolma, piroettava ballando con la principessa di Svezia. Su un sentiero del bosco mi rifà la scena di lui che in frac la obbligava a grandi giravolte da danza paesana, come a dire tutto trionfante: “Ecco, dopo l’Oriente tengo tra le mie braccia anche l’Occidente!”. Poco prima, infatti, Laxness aveva ricevuto un premio anche dai sovietici. Robert trova che di fronte a una tale baldanza gli insigniti del Nobel tedeschi e svizzeri non sono altro che un gruppettino di pantofolai».
Difficile dire con esattezza che siano i “pantofolai” tedeschi (probabilmente Thomas Mann e Hermann Hesse), mentre lo svizzero è ovviamente Carl Spitteler, che gli stava cordialmente antipatico. E’ comunque degno di nota il fatto che Walser, da una semplice fotografia, abbia colto alcuni tratti caratteriali di Laxness -lo humor, la baldanza, un certo spregio delle cerimonie, dell’ufficialità e delle convenzioni- che hanno trovato un perfetto rispecchiamento nei romanzi, dove è spesso difficile dirimere tragedia e commedia, la serietà della vita e la percezione della vita stessa come una kafkiana giostra delle apparenze senza senso e senza scopo.
Per conoscere davvero a fondo l’universo umano e poetico di Laxness bisogna assolutamente accostarsi alla sua opera maggiormente rivelatrice, per la quale una volta tanto vale la pena di scomodare il termine “capolavoro”, che peraltro è già stato giustamente scomodato da due lettrici di spicco quali Susan Sontag e Alice Munro. L’opera in questione è La campana d’Islanda, un romanzo uscito originariamente nel 1943 che è davvero un’indiscutibile capolavoro, se non altro perché si tratta di una cosiddetta “opera mondo”, che perviene a una perfetta sintesi di universale e particolare, investe le questioni di fondo dell’esistenza e insieme riscrive e reinventa uno dei miti fondativi dell’Islanda. Da questo punto di vista, fatte ovviamente le debite proporzioni, La campana d’Islanda si inserisce nel solco della Divina Commedia, del Faust e di Guerra e pace. Con l’aggiunta di alcune screziature, se così le si può definire, che ricordano il Don Chisciotte di Cervantes.
Laxness reinventa letterariamente, con uno spiccato e gustosissimo sense of humor, uno dei periodi più bui della storia del paese, intorno alla fine del Seicento, quando gli occupanti danesi avevano trafugato l’antica campana di Thingvellir, simbolo della nazione. Partendo da questo spunto, Laxness intreccia magistralmente una vicenda con tratti picareschi e tragicomici che è anche la storia dell’anima islandese e delle sue lunghe lotte per l’indipendenza: una storia che però, nel suo concreto divenire, si colora di leggende e connotazioni mitiche, penetrando in quel territorio prelogico che sta alla base di ogni vicenda umana, individuale e collettiva. Ecco perché l’Islanda di Laxness, soprattutto nelle pagine di questo romanzo davvero straordinario e irrinunciabile, ci appare da una vicinissima nonché modernissima lontananza. Poi sono arrivati altri scrittori e scrittrici, e in ambito musicale sono arrivati Björk (autentica voce d’Islanda, fuor di metafora) e i Sigur Rós, che hanno contributo a modificare radicalmente l’immagine consolidata della lontana terra dei ghiacci e dei geyser. Ma il primo a dissodare il terreno, per così dire, è stato senza dubbio Laxness.
Un’Islanda non più esotica, non più terra incognita, a dimostrazione che la “provincia” e la “periferia” sono due concetti molto relativi, due condizioni dell’anima, non due coordinate geografiche oppure due ineludibili dati di fatto. «Parla del tuo villaggio e parlerai del mondo», diceva giustamente Tolstoj, perché l’universale si rivela sempre (e soltanto) attraverso il particolare. La narrativa di Halldór Laxness, che ha avuto il merito di creare una moderna coscienza nazionale islandese, fornisce la conferma che ogni luogo, quando è magistralmente reinventato dalla creazione poetica, diventa davvero il centro del mondo, e forse solo in quel momento comincia realmente ad esistere. «Io sono la creta che hai tra le mani», dice una frase contenuta in un suo romanzo giovanile, Il grande tessitore del Kashmir, pubblicato a 25 anni nel 1927. E’ la “frase originaria” di Laxness, che contiene idealmente tutte le altre e spiega l’importanza e il senso complessivo della sua opera.
Voci dal Grande Nord

Contenuto audio
Voci dal grande nord
Laser 06.12.2023, 09:00
Voci dal grande nord
Laser 07.12.2023, 09:00